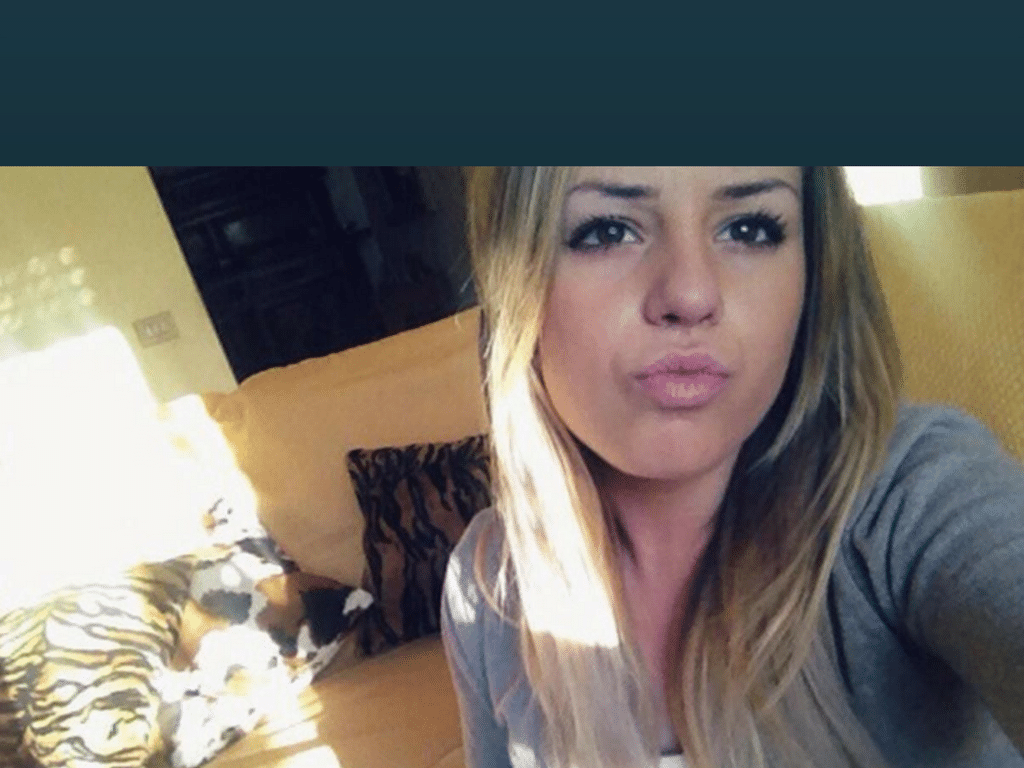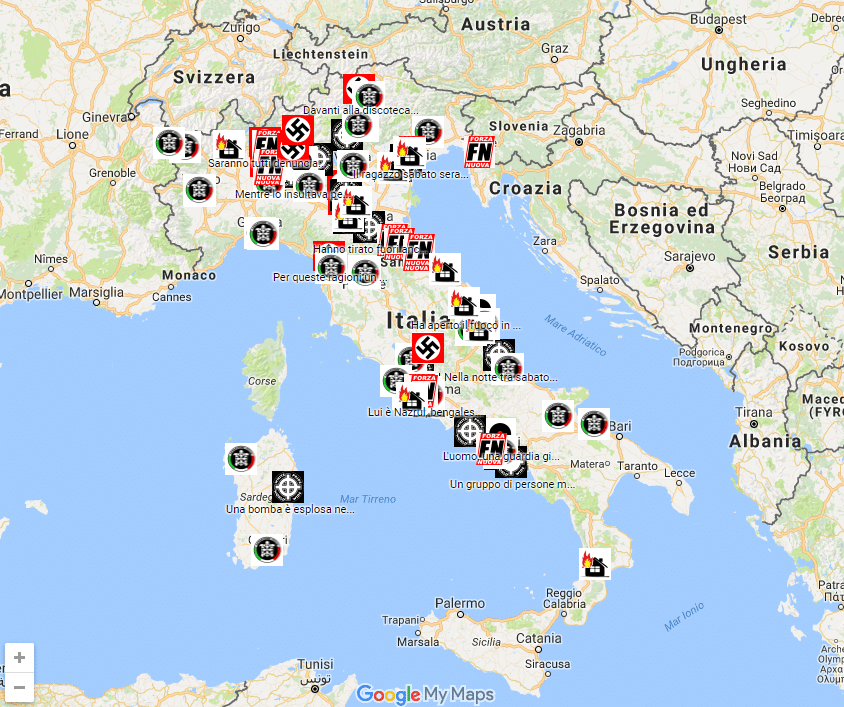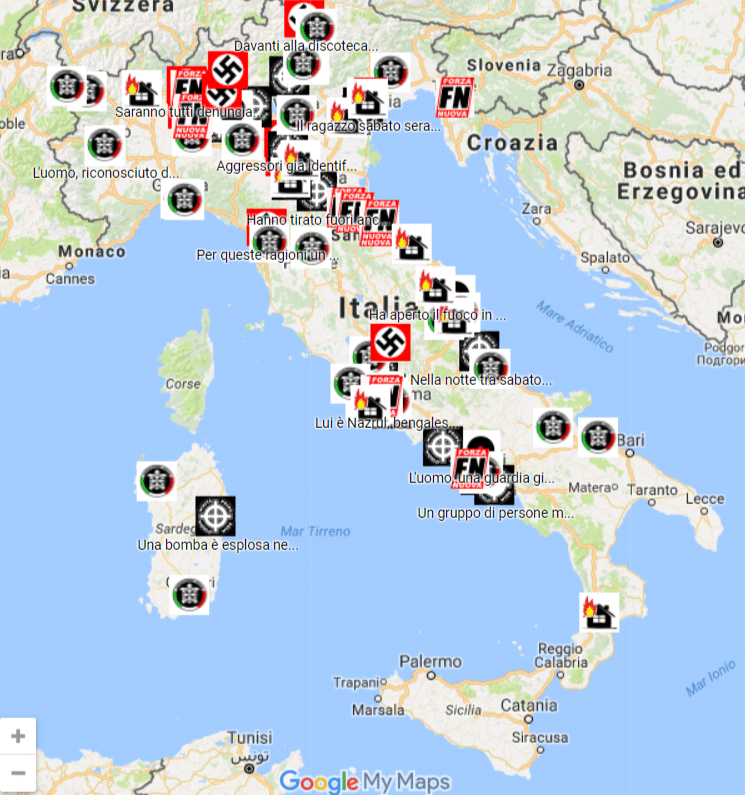Il 12 febbraio si celebra il Darwin Day, la giornata dedicata al naturalista inglese e alla sua “figlioletta”, le teoria dell’evoluzione biologica fondata essenzialmente, ma non solo, sulla selezione naturale del più adatto. Occasione della celebrazione è la data di nascita di Charles Darwin, il 12 febbraio 1809. Lo medesima di Abramo Lincoln. Strana coincidenza, perché in modo diverso l’uno in Inghilterra e l’altro negli Stati Uniti diventeranno campioni della lotta alla schiavitù. La vicenda antischiavista di Lincoln è ben conosciuta. Quella di Darwin forse un po’ meno. Anche se ha avuto effetti che, sul piano culturale, non sono stato certo meno importanti.
Esistono molte biografie di Darwin. Tra queste ve ne segnaliamo due, affatto diverse, scritte dai medesimi autori: Adrian Desmond e James Moore. Nella loro prima opera, Desmond e Moore hanno raccontato la vita del grande naturalista e hanno spiegato “come” il padre della teoria dell’evoluzione biologica ha generato la sua creatura. Quel lavoro, uscito in italiano nel 1992 per la Bollati Boringhieri con il titolo Darwin, si proponeva come (e certamente era) la più documentata biografia dell’evoluzionista nato a Shrewsbury, della contea di Shropshire, al confine tra Inghilterra e Galles. E tuttavia, per quanto importante, quel libro non proponeva una lettura “con occhiali nuovi” della vita di Charles Darwin.
Nella loro seconda biografia di Darwin, La sacra causa di Darwin, pubblicata in italiano con l’editore Raffaello Cortina nel 2012, Desmond e Moore spiegano “perché” il naturalista di Shrewsbury si è messo alla ricerca di una teoria dell’evoluzione biologica. Ed è il “perché” che, più della medesima data di nascita, accomuna Darwin a Lincoln: l’antischiavismo.
«Questa è la storia, mai raccontata, di come l’orrore di Darwin per la schiavitù abbia condotto alla nostra attuale comprensione dell’evoluzione», scrivono Desmond e Moore nell’introduzione a La sacra causa di Darwin. La “causa prima” che ha spinto Charles Darwin a elaborare la sua teoria e a pubblicare nel 1859 il capolavoro che divide le epoche, Sull’origine delle specie, è la medesima che ha portato Lincoln due anni dopo, nel 1861, a non tirarsi indietro di fronte all’apertura di una guerra civile: la “lotta alla schiavitù”. Una causa non strettamente scientifica, dunque, ma piuttosto un valore: culturale, morale, politico. Un valore che oggi definiremmo “progressista”.
Ciò non significa certo che Charles Darwin possa essere iscritto d’ufficio alla sinistra. Ma è certo, come documentano Desmond e Moore, in 700 pagine e con documenti alla mano, è stato un valore ascrivibile alla sinistra, l’orrore per la schiavitù, che ha portato Charles Darwin a elaborare e poi a difendere la sua teoria dell’evoluzione biologica. E poi a spiegare perché le “razze umane” non esistono e, dunque, non esiste alcuna base scientifica per il razzismo (che invece, purtroppo) esiste.
Quel 12 febbraio 1809, in cui sono venuti al mondo due campioni della lotta alla schiavitù: Abramo Lincoln e Charles Darwin, sono una coincidenza che tuttavia spiega come l’avversione per la schiavitù tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo fosse un sentimento tutto sommato abbastanza diffuso. Più in Inghilterra che in America, per la verità.
Ebbene, Charles Darwin nasce in una famiglia di antischiavisti militanti. Sia il nonno paterno, Erasmus Darwin, medico e poeta, sia il nonno materno, Josiah Wedgwood, esponente della nuova ed emergente classe degli industriali manifatturieri, erano antischiavisti. Antischiavisti militanti, appunto. E anche piuttosto coraggiosi, visto che la loro azione politica era contestata, spesso con violenza, dai reazionari del tempo. Non fosse altro perché l’uno e l’altro erano persone molto famose e non solo nello Shropshire.
In realtà, i nonni di Charles avevano una connotazione culturale molto precisa. In Inghilterra il sentimento antischiavista a cavallo tra XVIII e XIX secolo aveva, infatti, due anime. Una di matrice religiosa e tendenzialmente conservatrice, come quella di William Wilberforce. L’altra laica e progressista: è a questa che aderiscono Erasmus Darwin e anche Josiah Wedgwood.
Quando Charles nasce, le due correnti di pensiero sono alleate eppure sono destinate a divergere e, nell’arco di due generazioni, a contrastarsi. Anche e soprattutto a causa del nipote di Erasmus e Josiah. E il motivo risiede nel ruolo che ciascuna di loro assegna all’uomo rispetto alla natura. La corrente religiosa dell’antischiavismo considera l’uomo distinto dalla natura e pone l’intera umanità su un piano incommensurabilmente superiore a ogni altro essere vivente. La corrente laica di pensiero considera invece l’uomo parte della natura e – senza distinzione alcuna e con pari dignità – si trova in una rete di relazioni col resto della natura.
È con questa intima convinzione che il giovane Darwin intraprende quel celebre viaggio sul Beagle, nel corso del quale non solo ha modo di vedere coi propri occhi e di toccare con mano l’orrore della schiavitù, ma anche di raccogliere le prove della rete di relazioni che lega l’uomo alla natura. Prove che sono sotto gli occhi di molti, se non di tutti. Ma che Darwin legge con gli specialissimi occhiali dell’antischiavismo laico che gli consentono di “vedere” le trame dell’evoluzione biologica per selezione naturale che si fondano sulle relazioni di tutti con tutti tra i viventi. Corollario di questa rete di relazioni che si estende nello spazio ma si snoda anche nel tempo profondo, è l’origine comune di tutte le specie.
Certo, quando pubblica L’origine delle specie, nel 1859, Darwin non fa esplicita menzione dell’origine che accomuna l’uomo a tutte le altre specie viventi. Le conclusioni le trarrà pubblicamente solo undici anni, quando pubblicherà il libro dedicato a L’origine dell’uomo e la selezione sessuale. Tuttavia le conseguenze sono chiare a tutti. Compreso il vescovo Samuel Wilberforce, figlio di William, che sbotterà, rivolto a Thomas Huxley, il mastino di Darwin: «Lei, di grazia, discende dalle scimmie per parte di madre o di padre?».
Sia Samuel Wilberforce sia Charles Darwin sono e continuano a essere antischiavisti militanti. Ma la visione dell’uomo che porta ciascuno di loro a “provare orrore per la schiavitù” è ormai irrimediabilmente diversa. Ed è proprio questa diversità che impone una nuova e più avanzata “militanza”. Il religioso Wilberforce nega l’evoluzione biologica. In nome della scienza che impone spiegazioni naturalistiche, Darwin si difende ed è costretto a scendere in campo per spiegarla l’origine naturale e non soprannaturale, come vorrebbe Wilberforce, dell’uomo. Ed è a questo punto, nel 1870, che affronta il tema delle razze umane.
Quattro gli argomenti portanti. Le relazioni tra tutti gli esseri viventi e la logica dell’evoluzione dimostrano che la discendenza comune di tutti gli esseri viventi. Anche tutti gli uomini sono nati da un comune antenato. «L’uomo – scrive – è stato studiato più estesamente di qualsiasi altro animale, eppure vi è la più grande diversità possibile di opinioni tra gli studiosi eminenti circa il fatto che l’uomo possa essere classificato come una singola specie o razza, oppure come due (Virey), tre (Jacquinot), quattro (Kant), cinque (Blumenbach), sei (Buffon), sette (Hunter), otto (Agassiz), undici (Pickering), quindici (Bory St. Vincent), sedici (Desmoulins), ventidue (Morton), sessanta (Crawford), o sessantatre, secondo Burke». Nessuno è in accordo con nessun altro. Nessuno riesce a dare una definizione precisa di razza. Ultimo, ma non ultimo, Darwin stesso ha verificato, in Brasile per esempio, la completa interfertilità tra indios, negri ed europei che dà luogo a individui “meticci” altrettanto fertili. Ma l’argomento di gran lunga più importante «contro l’idea che le razze umane siano specie distinte» sono le gradazioni naturali di ogni fattore preso in considerazione, compreso il colore della pelle, anche in assenza di incroci.
Oggi sappiamo che la genetica fornisce la piena conferma dell’ipotesi di Charles Darwin: le razze umane non esistono. Il naturalista e militante antischiavista inglese, dunque, ha falsificato l’idea di razza umana e destituito di ogni fondamento scientifico il razzismo. In questa sua dimensione “politica”, la vicenda di Darwin mostra molte analogie con quella di altri grandi scienziati, come Galileo e di Einstein. Come loro, Darwin ha un progetto politico forte. E “progressista”. Nel suo caso, un mondo senza schiavitù e senza razzismo. Quello di Galileo è un mondo che accoglie e non si scontra con la scienza. Quello di Einstein, un mondo in pace. Ciascuno di loro dedica una parte importante del proprio tempo e del proprio impegno nella realizzazione del proprio progetto politico. Ma mentre in Galileo il progetto politico (e teologico) viene dopo le grandi scoperte astronomiche, quasi come una loro conseguenza; mentre in Einstein il progetto politico (un mondo in pace) marcia in parallelo a quello scientifico (la ricerca dell’intima unità e razionalità della natura); in Darwin il progetto politico, la lotta alla schiavitù, precede e, in qualche modo, indirizza la stessa ricerca scientifica. Tutti dimostrano che la cura dei rapporti con la società, lungi dall’essere indifferente, come sostengono alcuni, o addirittura fonte di distrazione, come sostengono altri, contribuisce a rafforzare l’impegno scientifico dei grandi.
DARWIN DAY tanti eventi in Italia organizzati dalla Uaar, dal Cicap e da Pikaia
L’11 febbraio a Rimini il convegno dal titolo Mostri degli abissi tra mito e realtà con la naturalista Manuela Travaglio e lo zoologo Lorenzo Rossi, entrambi del Cicap Veneto. Nella giornata del 12 febbraio tre sono gli appuntamenti previsti: a Firenze, dove si terrà un incontro con Fausto Barbagli, del Museo di Storia Naturale, e Roscoe Stanyon e Gregorio Oxilia – entrambi del Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Firenze; a Milano, dove Marco Ferraguti, della Società italiana di Biologia Evoluzionistica, e Claudio Bandi, docente di Evoluzione biologica all’Università degli Studi di Milano, sfateranno errori e preconcetti su Charles Darwin in un incontro intitolato appunto “Che cosa non ha detto Darwin?”; a Pordenone, infine, si ricorderà il grande scienziato attraverso la lettura e la presentazione di una selezione di documenti sulla sua attività scientifica. Ma gli eventi in programma non finiscono qui. Tra gli altri segnaliamo: il 14 febbraio a Modena, Mauro Mandrioli, docente del Dipartimento di Scienze della Vita – Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, terrà una conferenza su “Genomi umani in evoluzione: il DNA per capire origine, migrazioni e futuro della nostra specie”. A Venezia il 16 febbraio “L’uomo sta creando l’uomo. Le nuove frontiere per modificare il genoma”, giornata di studio con la collaborazione dell’Ateneo Veneto ed il patrocinio della Facoltà di Scienze Università di Padova: partecipano Piero Benedetti (Biologia Molecolare, Università di Padova), Anna Meldolesi (specialista in comunicazione scientifica), Luigi Perissinotto (Filosofo del linguaggio, Università Ca’ Foscari di Venezia); sempre il 16, a Torino, conferenza sull’evoluzione del volo con Alberto Massi, ornitologo e musicista, e Giorgio Pozzo, ingegnere aerospaziale; e ancora, a Ravenna, presentazione del libro “Evoluzione al femminile. Il contributo delle femmine all’evoluzione dell’Homo sapiens” della biologa Bruna Tadolini; a Palermo il 18 febbraio “Darwin Family Day” al Planetario (Villa Filippina), con laboratori didattici gratuiti e una tavola rotonda per avvicinare i cittadini alla ricerca scientifica; sempre il 18 febbraio, ad Ancona, conferenza “Umanesimo Darwiniano. Una nuova prospettiva su uomo e natura” con Roberto Verolini, docente di Scienze naturali; il 19 febbraio, a Padova, “Introduzione all’epigenetica”: lezione divulgativa del prof. Giuseppe Macino, ordinario di Biologia Cellulare presso l’Università di Roma La Sapienza.
Per il calendario completo e in continuo aggiornamento degli eventi Darwin Day Uaar
Per altri Darwin Day organizzati in Italia: Link a pikaia.eu
Per quelli previsti a livello internazionale: Link