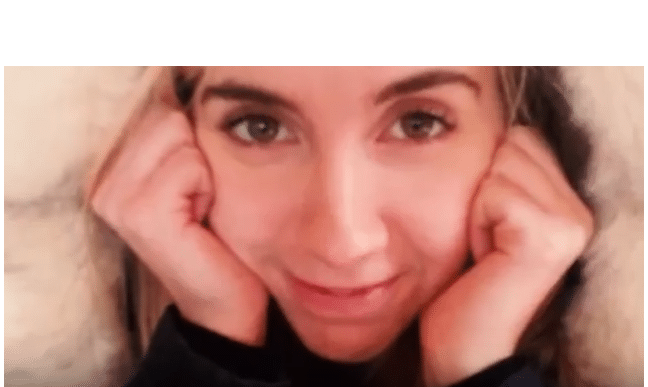All’inaugurazione, tanto attesa dopo dieci anni di lavori nell’isola Saadiyat, c’era il gotha della politica emiratina e francese. Accanto al principe e al primo ministro Sheikh Mohamed bin Rashed al-Maktoum, ha sfilato il presidente francese Emmanuel Macron con la moglie Brigitte. L’evento richiedeva pomposità: il Louvre di Abu Dhabi – disegnato dal pluripremiato architetto francese Jean Nouvel – ha aperto i battenti l’11 novembre. Un luogo avveneristico, in perfetto stile Golfo: una struttura iper moderna, costruita con speciali tecnologie che proteggono seicento opere dalle temperature cocenti del luogo, con rimandi all’architettura contemporanea europea ma senza minimizzare la natura araba.
La copertura è un enorme arabesco, un intreccio morbido di curve; intorno solo acqua dove la grande cupola, richiamo ad una moschea, si specchia. Illuminate dai raggi che penetrano dal soffitto e che il bianco delle pareti rilanciano in un gioco continuo di ombre e luci (nell’idea dell’architetto fanno rivivere l’atmosfera di un suq), le dodici gallerie del nouveau Louvre spaziano dalla preistoria all’oggi. È l’obiettivo del megaprogetto: un museo che racconti la storia dell’uomo, «ponte tra le civiltà» che metta a tacere «i bugiardi che tentano di far passare l’Islam come la distruzione delle altre religioni». Macron ha elogiato il progetto, «prova che le nostre religioni, le nostre civilità, sono collegate». E il Louvre di Abu Dhabi lo dimostra raccontando l’incontro tra popoli, gli scambi, i reciproci arricchimenti culturali: egizi, cinesi, romani, greci, assiri, arabi, cristiani, ebrei e musulmani, il mondo scorre tra le gallerie passando per Leonardo da Vinci e Van Gogh, per Mondrian e Hamdy Bey, per bibbie gotiche, torah yemenite e i più antichi corani, fino a lambire il nostro tempo.
Il costo, per dieci anni di lavoro in partnership con istituzioni francesi, è stato pari a 1,1 miliardi di dollari (quasi la metà per il brand, “Louvre”, utilizzabile per trent’anni). Questo è il costo noto, tangibile. C’è poi un altro costo, tanto pesante quanto invisibile che getta ombre sugli obiettivi dichiarati del new Louvre, «un museo fondato sui diritti umani universali» che si erga a modello «dell’audace avanzata culturale e dell’apertura degli Emirati Arabi». Il costo pagato dalle migliaia di lavoratori migranti che hanno fisicamente tirato su il museo in condizioni di semi-schiavitù…