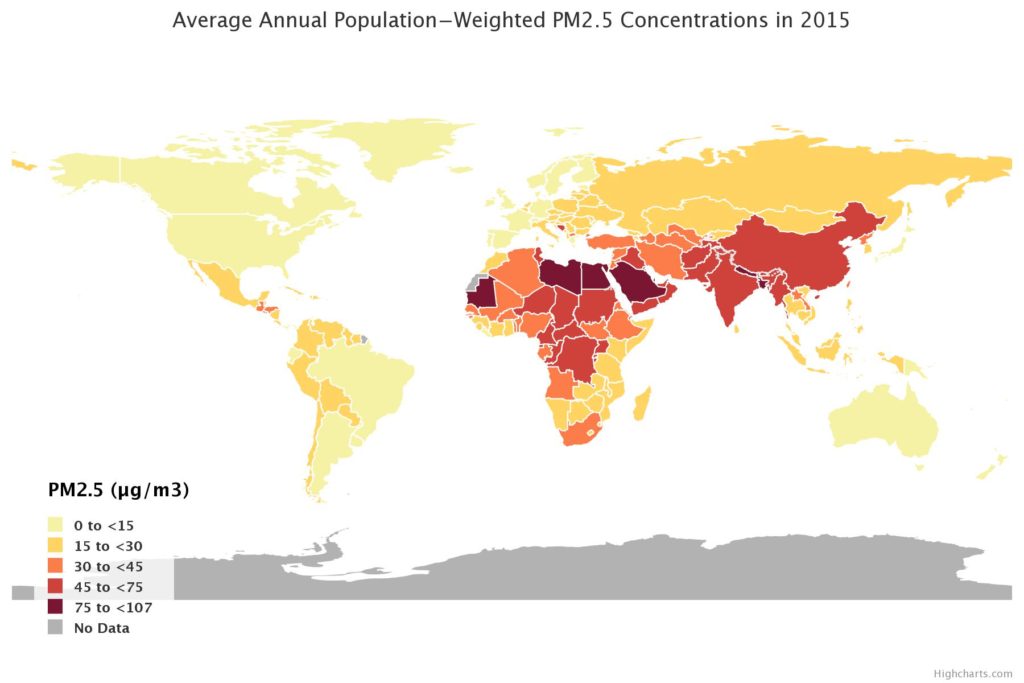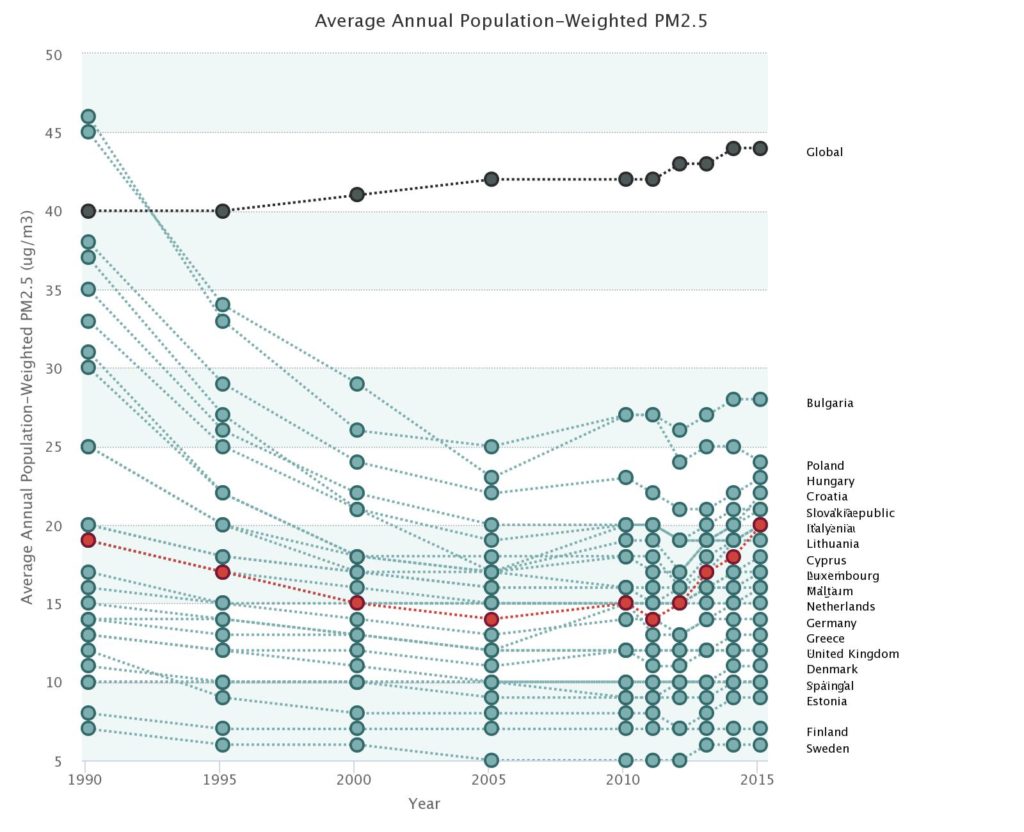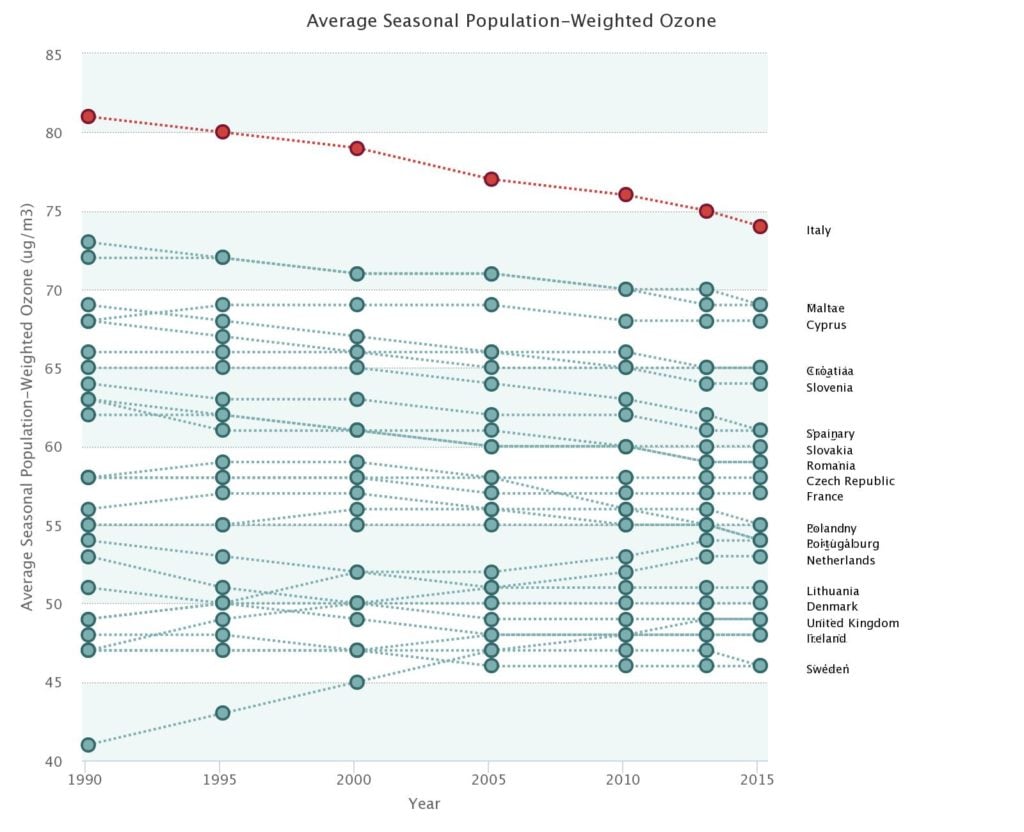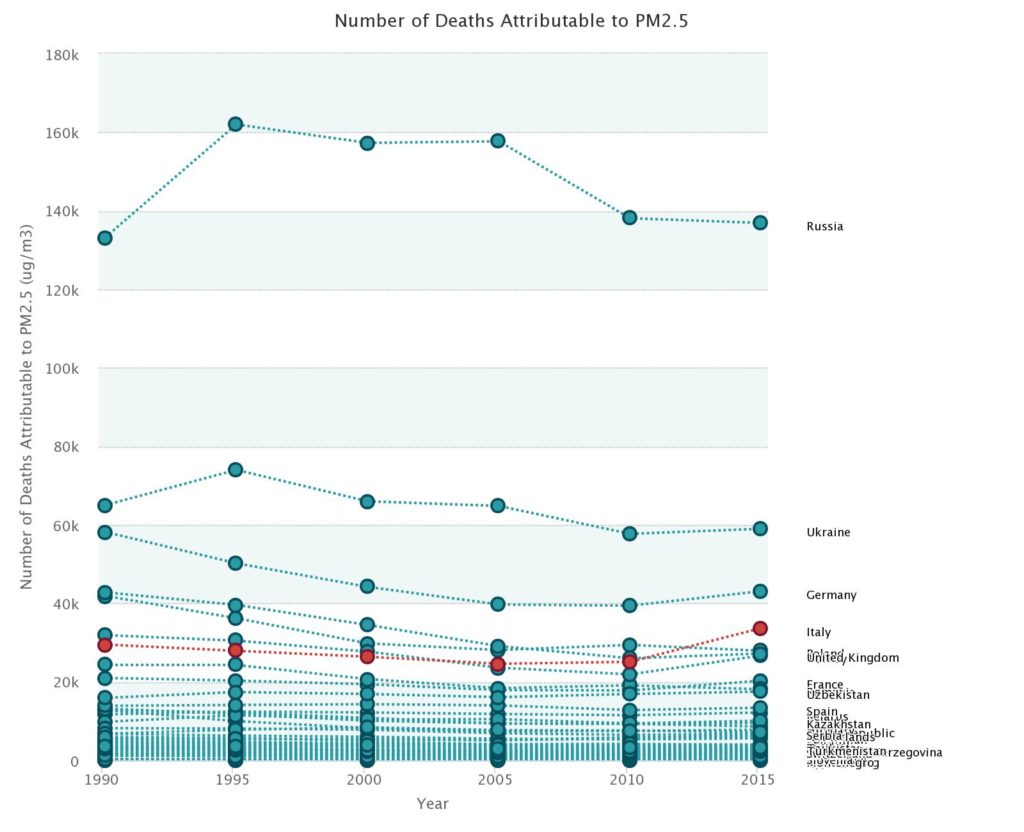«Hanno paura del congresso» accusa Matteo Renzi, che si atteggia a quello che proprio non capisce cosa abbia da protestare, adesso, ancora, la minoranza dem, con le sue varie anime, dopo che lui ha concesso il congresso che così insistentemente chiedevano.
Nella sua e-news, Renzi ricorda quando detto già nell’ultima direzione, quando ha risposto a Massimo D’Alema (che per primo ha detto: “O congresso o sarà scissione”) e agli «altri leader della minoranza». «Mi domando come sia possibile fare una scissione sulla data di convocazione del congresso e non sulle idee», continua dunque Renzi, provocatorio, «ma io non voglio dare alcun pretesto, davvero. Voglio togliere ogni alibi. E anche se il grido “congresso o scissione” sembra un ricatto morale, accettiamo di nuovo il congresso dicendoci: ragazzi, dobbiamo essere responsabili».
Sentire Bersani parlare di buon senso mentre minaccia scissioni dalla mattina alla sera è davvero pittoresco.
— Roberto Giachetti (@bobogiac) 14 febbraio 2017
Lui, insomma, dice di aver fatto il suo. E in effetti ha proposto un congresso, da tenere però presto, perché – sempre senza passare per quello che ha messo la data di scadenza a Gentiloni, cosa in realtà fatta – lui vuole che il Pd sia pronto quando, «presto o tardi, ma comunque entro un anno», si voterà. Vuole farlo prima dell’estate, Renzi, o al massimo a giugno, ed è questo che non piace alla minoranza. Che si mostra preoccupata per il governo, che, dicono, non sarebbe da partito responsabile mandare via in un momento così delicato, con lo spread che risale etc etc. L’accusa mossa a Renzi è quella di ricercare invece un plebiscito, preoccupato solo del proprio smalto e incurante del destino del Paese.
La minoranza PD preoccupata per il governo Gentiloni è quella che quando nacque disse “dovranno convincerci provvedimento per provvedimento”
— Francesco Costa (@francescocosta) 14 febbraio 2017
A Renzi però l’accusa scivola addosso, consapevole che, in effetti, sembra così che la minoranza si stia preparando alla scissione sulla data di un congresso. Non proprio il massimo. E non solo: a Renzi non dispiace neanche l’idea che risulti Bersani, alla fine, il difensore, ancora una volta, di un governo di larghe intese. Bersani, che pone sì il tema del calendario, ma che lo fa anche sempre (e di questo bisogna dargli atto, anche se può porsi il tema della credibilità) segnalando la necessità di un cambio radicale di segno politico – confermato invece da Renzi – abbandonando ogni residua fascinazione per una Terza via fuori tempo massimo. Dice Bersani (che la terza via, una globalizzazione governata da sinistra, l’ha applicata e predicata per anni, e non lo rinnega) che ora la fase economica è cambiata e bisognerebbe adeguare le risposte, con più protezione.
La vera notizia sulla scissione del PD, è che dopo 10 anni in cui viene annunciata ogni settimana non sia ancora avvenuta.
— Luca Sofri (@lucasofri) 15 febbraio 2017
A noi questa sì che sembra un motivo giusto per una scissione (e forse sarebbe stato il motivo per non farlo proprio il Pd), se non fosse che poi finora la minoranza ha votato tutto: non la legge elettorale, ma sì il jobs act, ad esempio, con l’abolizione dell’articolo 18 fatta proprio nel solco del mito delle briglie sciolte, non certo della protezione.
Ma insomma: la scissione ci sarà? Qui abbiamo imparato a dubitare. Ma intanto, è vero, viene paventata come mai prima, e così Roberto Speranza e Michele Emiliano, ben più dubbiosi di D’Alema e Bersani, ad esempio, saranno con Enrico Rossi al Teatro Vittoria di Roma, questo sabato mattina, pur confermando la presenza all’assemblea dem convocata da Renzi l’indomani. Aspettano una mossa dal segretario, dicono. Qualcosa che dimostri che il congresso sia un momento vero di discussione.
In realtà aspettano più una mossa di Franceschini e Orlando, aspettano che qualcuno scarichi Renzi riaprendo così una partita altrimenti chiusa in partenza, un congresso che non avrebbe senso giocarsi con la certezza di finire «asfaltati». Perché se già l’addio al maggioritario mette in crisi l’idea del partitone unico, la leadership renziana, incontrastata, rende impossibile – pensa soprattutto la minoranza, che comunque farebbe un nuovo partito largo, con moderati e cattolici – spostare a sinistra il partito. Ma se Renzi tornasse ad esser una delle tante anime del Pd, magari segretario ma costretto alla mediazione (sulle liste, sui programmi, sulla segreteria, su un manifesto delle idee, come propongono Orlando e Zingaretti), beh, allora…

Della crisi (per noi definitiva) del Pd parliamo anche su Left in edicola