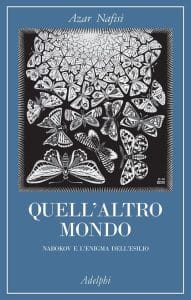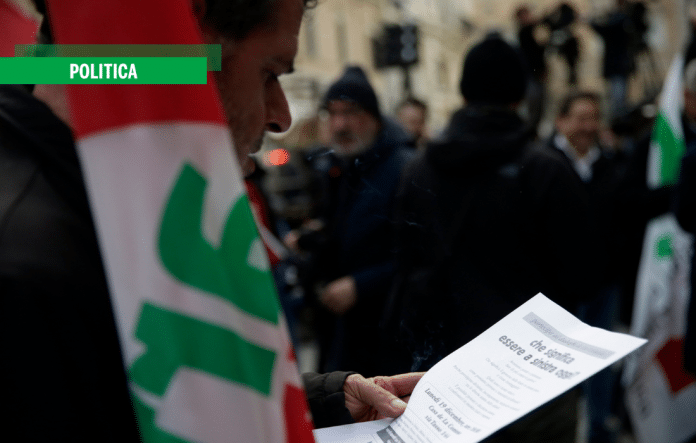Premessa. Giunto all’età di settantacinque anni, più di cinquanta dei quali trascorsi come militante di sinistra e come studioso di economia, chiedo ospitalità per alcune considerazioni generali sulla attuale situazione politica. Derivano dai due aspetti della mia biografia citati qui sopra: ritengo infatti di avere una lunga esperienza dall’interno degli errori della sinistra (inclusi, nel mio piccolo, i miei), e in particolare di quelli che sono stati e sono compiuti quando si trascura l’economia. Toccherò tre punti: la natura dell’attuale governo, perché la sua politica ha molte probabilità di avere successo (dal suo punto di vista) e cosa manca alla sinistra per essere all’altezza della situazione.
1 Il Non Fascismo di Meloni.
Credo che le caratteristiche fondamentali di un governo fascista siano il suo essere al servizio di un potere forte (o di più di uno), e di operare al di fuori di regole democratiche. Ci serve fare una rozza ripartizione. Storicamente, ci sono stati un fascismo di tipo “sudamericano” (feroce oppressione, danni pesanti inflitti alla popolazione, disprezzo per la vita delle persone), e uno di tipo “europeo” (meno disprezzo per la vita della popolazione di riferimento, anche se non per altri gruppi, provvedimenti di assistenza sociale). Suggerisco che la sostanza della politica di Meloni corrisponda a un terzo modello, che potremmo chiamare, con un neologismo, liberismo realizzato. Avrà le due caratteristiche fondamentali dei modelli fascisti appena citati, ma allo stesso tempo potrà operar all’interno di un sistema formalmente, ma non sostanzialmente, democratico (se avrà successo). Questo modello avrà le sue radici nel liberismo, e la sua relazione con la sostanza teorica di esso è paragonabile a quella che si ha fra il socialismo e il socialismo realizzato. Questa classificazione naturalmente è molto schematica, gli elementi di contaminazione fra i tre modelli sono molteplici, eccetera; l’ho introdotta per sottolineare cosa distingue il o liberismo realizzato dai fascismi tradizionali, e cioè l’assenza della repressione “alla sudamericana” da una parte e dei provvedimenti di welfare alla “europea” dall’altra. Questo a sua volta ci serve per porre la domanda cruciale, come farà allora un regime siffatto ad avere successo, in assenza sia del bastone che della carota (o meglio, con un bastone piccolo e una carota piccolissima)? Perché in effetti non è improbabile che tale successo venga conseguito, come vedremo.
2. Il Liberismo realizzato. Per quanto visto fin qui, la novità per così dire metodologica del modello Meloni consiste in questo: il saccheggio delle risorse dei poveri e il trasferimento delle medesime a un’oligarchia, così come il loro sfruttamento e lo redistribuzione verso l’alto dei redditi che vengono prodotti, non sono ottenuti mediante la repressione delle opposizioni (che avrà un ruolo minore) e nemmeno con un meccanismo di “divide et impera” che consenta di comprare il consenso di una parte delle classi inferiori con politiche assistenziali. Lo strumento utilizzato saranno da una parte lo svuotamento (non il rovesciamento) della democrazia e dall’altra la drastica riduzione della solidarietà. Non si otterrà il consenso della popolazione; si otterrà qualcosa di meno ma di più che sufficiente, e cioè l’assenza del dissenso. Cerco di spiegarmi con un esempio, facendo riferimento al “combinato disposto” di due provvedimenti di prossima attuazione, e cioè la modifica al Reddito di Cittadinanza e il tetto molto elevato per l’uso dei contanti. L’esclusione dal RDC di chi è “occupabile” allarga la platea di chi sarà disposto a lavorare in nero; mentre la libera circolazione dei contanti toglierà all’economia illegale un ostacolo che altrove è piuttosto serio, e quindi farà aumentare la domanda di lavoratori in nero. La generalizzazione di queste tendenza avrà come punto di arrivo un’economia in cui il mercato del lavoro è perlopiù precarizzato, i padroni possono fare quello che vogliono e la corruzione regna sovrana (è di questi giorni la notizia che il ministro della giustizia, Nordio, vuole subordinare i Pubblici Ministeri al Governo, e imporre ad essi di procedere secondo priorità stabilite dal medesimo, previa abolizione dell’obbligatorietà dell’azione penale). A differenza del fascismo sudamericano non si procederà quindi con la repressione violenta del dissenso, e a differenza di quello italiano non si procederà con la violazione de facto ma non de jure del diritto comune; si adotteranno provvedimenti che legalizzeranno il padrinaggio e l’impunità. Si tratta di una strategia più efficiente (e anche più umana) delle precedenti. Non si perderanno tempo e consenso violando le leggi e salvando i colpevoli: si renderanno leciti comportamenti che oggi non sono legali. In altri termini, e semplificando, non si abolirà la lotta alla corruzione, si abolirà il reato di corruzione. Se qualcuno vuole vedere un obbiettivo positivo in tutto ciò potrà citare il tentativo di fare concorrenza alle economie forti creando un’economia priva di diritti per i lavoratori e di controlli per i padroni, riportando insomma l’Italia alla condizione di un’economia sottosviluppata, sperando con ciò di attrarre capitali e investimenti proprio grazie alla libertà di cui godranno i capitalisti selvaggi: una strada che attraverso molte lacrime e molto sangue ha portato in effetti alcuni paesi ad uscire dalla trappola del sottosviluppo.
3. Liberismo realizzato, consenso e dissenso. Veniamo allora alla questione del possibile successo del liberismo realizzato. Cosa fa si che questo regime, nonostante le lacrime e il sangue di cui sopra, abbia buone probabilità di avere il consenso della popolazione, o meglio di non averne il dissenso?Immaginiamo di essere nel liberismo realizzato. Il soggetto rappresentativo (o l’elettore mediano, a seconda che usiamo il gergo dei sociologi o quello degli economisti) sarà un lavoratore precario, obbligato a un insieme di piccoli compromessi per sbarcare il lunario (evadere il fisco se è un autonomo o se ha una seconda attività, accettare di lavorare in tutto o in parte in nero se è un lavoratore dipendente, chiedere raccomandazioni per qualsiasi cosa, ecc.). La scelta (in realtà una non-scelta) cui si troverà di fronte sarà fra accettare la situazione oppure ribellarsi e venire licenziato, e/o non potere pagare la scuola per i figli, e/o accettare di essere emarginato sempre di più, e così via. Si noti che la strategia del liberismo realizzato si innesca saldamente sulle radici del berlusconismo realizzato: se già adesso l’uomo della strada sa che adire ai tribunali per avere giustizia, chiedere che vengano rispettati il suo diritto alla salute tramite il SSN e il suo diritto alla dignità tramite un reddito di base, essere protetto dagli abusi sul lavoro tramite un sindacato, ecc. sono cose nel peggiore dei casi impossibili e nel migliore molto faticose, sarà lui stesso a preferire di rivolgersi al padrino. Già adesso sono in molti, anche poveri, a preferire le prestazioni sanitarie private a quelle pubbliche: costano un po’ di più, ma si fa in fretta. Questo schema si estenderà sicuramente a molti altri settori dell’economia e della vita civile. (Su tutto ciò le responsabilità storiche dei vari Prodi, D’Alema e Letta sono colossali; ma questo è un altro discorso). Questo naturalmente non solo non è in contrasto con l’odiare la classe politica –todos ladrones, come dicevano (e forse dicono ancora) in Argentina: è assolutamente complementare con tale odio. Qualcuno va incolpato dei guai che affliggono il nostro soggetto, ma non può essere il capoufficio (occorre tenerselo buono), il padrone (non si sa mai…) e così via. La causa va riportata talmente in alto da corrispondere a qualcosa contro cui non c’è niente da fare. L’opposizione al regime, così come mi raccontano essere stato tipico del ventennio mussoliniano, tornerà a essere una cosa riservata a persone molto coraggiose, ai matti, e a chi abbia abbastanza risorse per poterselo permettere. Pochi termini sono più abusati nelle scienze sociali di quello di equilibrio; ma è fuor di dubbio che i sistemi non in equilibrio tendono a raggiungerne uno, e il liberismo realizzato potrà esserlo.
4. Cosa si può fare per contrastare questa deriva? Chi sia obbligato a evadere il fisco non potrà votare per chi propone la lotta all’evasione come ideale, a meno che non che gli venga offerto realisticamente qualcosa in cambio; e chi è obbligato ad accettare un lavoro in nero non potrà votare per chi vuole abolirlo se ciò non comporta anche la promessa credibile di un posto di lavoro regolare. Cerco di spiegarmi meglio con un altro esempio. Nemmeno il regime di cui stiamo parlando potrà abolire le norme sulla sicurezza del lavoro; potrà però svuotarle dall’interno, per esempio riducendo drasticamente il numero di ispettori del lavoro (o meglio, non aumentandoli, perché la loro riduzione fino a un livello grottesco è già stata operata dai governi precedenti, compresi quelli di centrosinistra: si veda per esempio un articolo sul Fatto Quotidiano del 29 aprile di quest’anno). In queste condizioni molte imprese saranno obbligate, per non uscire dal mercato, a trascurare le norme sulla sicurezza, dato che chi lo fa produce a costi minori. Quando si verificheranno tragedie sul lavoro bisognerà dare qualcosa in pasto all’opinione pubblica, e si dirà che quel singolo imprenditore è un mostro, mentre il sistema è sano. Come reagirà il piccolo imprenditore o l’artigiano obbligato a violare le norme? Probabilmente così: “ma come, io faccio sacrifici enormi per mandare avanti la baracca e dare lavoro a X dipendenti, e loro mi obbligano a scegliere fra chiudere o rischiare di andare in galera per avere fatto qualcosa che fanno tutti. Bisogna cambiare le norme e lasciarci più libertà, se no chiudo.” Naturalmente esiste un’altra soluzione, e cioè che tutte le imprese siano simultaneamente obbligate a rispettare le norme di sicurezza. Ma nel regime liberista realizzato questa alternativa non esisterà.
In queste ultime righe ho usato il tempo futuro, ma sarebbe andato altrettanto bene il presente, a dimostrazione di quanto il processo di instaurazione del liberismo realizzato sia già andato avanti, di come i meccanismi del suo consenso siano profondamente radicati nella nostra società, e di come esso sia il punto di arrivo di un processo iniziato da Berlusconi (e, ahimè, propiziato anche dal PD – ma questo è un altro discorso).
Veniamo allora a cosa dovrebbe fare la sinistra. Perché una politica di sinistra possa essere credibile, il che è una condizione necessaria (anche se non sufficiente) perché abbia un seguito di massa, occorre che essa possa offrire un’alternativa a chi è obbligato ad accettare i compromessi imposti dal regime di liberismo realizzato; e come abbiamo visto questa alternativa deve essere tale da consentire dei vantaggi reali e rapidi. Si tratta evidentemente di un compito immane; ma lo diventerà sempre di più man mano che il regime prende piede, e quindi prima si comincia meglio è. Ammetto che può sembrare presuntuoso, ma mi pare che fino ad ora non si sia ancora realmente incominciato.
Infatti l’ipotetica politica di cui sopra richiede soldi. Si devono creare posti di lavoro, e ciò richiede investimenti e il pagamento di stipendi. Si devono pagare sussidi a chi non si vuole che lavori in nero. Se si vuole evitare che l’illegalità fiscale diventi talmente diffusa da obbligare anche gli onesti a praticarla si deve far sì che l’osservanza delle norme fiscali non implichi seri rischi di fallimento, e così via. Ora, questi soldi non possono essere trovati a debito, perché più alto è il debito, più alti sono gli interessi da pagare; e anche perché chi sottoscrive il debito (se non viene monetizzato) è gente che di soldi ne ha, e quindi il pagamento di interessi è oggi, in regime di crescita bassa o negativa nel medio e probabilmente lungo periodo, sostanzialmente un trasferimento dai poveri ai ricchi. Quindi bisogna far pagare più tasse ai ricchi. Tassare i redditi è relativamente difficile, perché i ricchi possono portare i reddito all’estero; non possono portare però la ricchezza, a meno di cambiare cittadinanza. Quindi, primo passo ineludibile se si vogliono fare politiche di sinistra: tassare la ricchezza dei ricchi. Basterebbe poco: un’imposta con aliquota media (ma sarebbero preferibili aliquote progressive) dell’1% sulla sola ricchezza finanziaria ufficiale, quindi non eludibile, renderebbe intorno ai 50 miliardi.
Se si vuole che i cittadini preferiscano lo stato al padrino, occorre poi che lo stato funzioni bene; e se si vuole che i lavoratori siano poco ricattabili, occorre aumentare l’occupazione nel settore pubblico, visto che il settore privato non lo fa. Quindi, secondo passo ineludibile, occorre un massiccio piano di assunzioni nel settore pubblico, che come è noto in Italia è paurosamente sottodimensionato: l’assunzione di un milione di nuovi dipendenti, in aggiunta allo stock attuale di circa 3.200.000 addetti, non basterebbe a colmare il divario con i paesi europei “normali”. La Cgil ha recentemente proposto un progetto che prevede 480.000 assunzioni oltre a quelle per sostituzione: nella attuale temperie questa cifra è sembrata a molti utopistica, ma in realtà è ampiamente insufficiente se vogliamo dotarci di un’amministrazione “al passo con i paesi più sviluppati”, come si usava dire una volta (e ora non più, perché questi paragoni si preferisce non farli).
Infine, non possiamo più permetterci di sperperare ogni anno fra il 2 e il 3% del PIL in interessi sul debito pubblico, e men che meno di rimborsarne una parte in regime di ristagno o recessione. Quindi, terzo passo ineludibile, bisogna fare la voce grossa con l’Europa (e l’Italia ha il potere di farla) per ottenere che il servizio e il rimborso del debito siano legati alla crescita economica. Niente crescita, niente pagamenti; in presenza di crescita, una parte limitata delle nuove risorse va indirizzata ad essi. E’ bene ricordare che l’Italia da molti anni è obbligata – Covid a parte – a fare nuovo debito solo per pagare gli interessi di quello vecchio. I tre punti di cui sopra non bastano: su di essi (e forse di altri) si deve costruire un programma serio e articolato. Sono, come suggerivo più sopra, una condizione necessaria ma di per sé non sufficiente. L’elaborazione di questo programma, ripeto, è un compito difficile ma non impossibile, ed è appunto necessario. Personalmente, giunto alla mia veneranda età e sulla base di mezzo secolo di studio dell’economia, non sono disposto a dare credito a programmi, soggetti e militanti politici che non partano da quei tre pilastri fondamentali. Per alcuni militanti e per qualche soggetto ho la massima stima e mi sento profondamente solidale con gli ideali che li ispirano. Ma la stima e la solidarietà non bastano: non si deve convincere me, ma la casalinga di Voghera.
5. Conclusione. Può darsi – e me lo auguro – che io abbia torto. Forse si possono trovare le risorse per lo sviluppo senza tassare i ricchi. Forse non occorre aumentare di molto il numero degli ispettori del lavoro, basta dare a ciascuno di essi due computer invece di uno. E forse la Germania ci aiuterà a far calare il famoso spread, ostacolando altruisticamente l’emissione del suo debito in nome della Solidarietà Europea. E poi, come diceva Churchill, è molto difficile fare previsioni, soprattutto riguardo al futuro. Forse insomma la mia analisi è del tutto sbagliata. Se anche non lo è, è possibile (ma direi molto improbabile) che la vigorosa battaglia degli antifascisti militanti faccia nascere un governo progressista che avrà l’appoggio popolare. È anche possibile (e già meno improbabile) che l’attuale governo collassi per le sue contraddizioni interne, e chissà cosa capiterà dopo. Ed è anche possibile, e temo probabile, che alla fine della guerra in cui siamo coinvolti l’economia e la società italiane si troveranno in una condizione talmente disastrata da fare apparire quanto scritto in questo articolo del tutto irrilevante (come ritenuto possibile tra l’altro dall’Economist, si veda il numero del 26 novembre). Ma sperare che il nemico faccia errori e temere che una guerra cambi tutto mi sembrano comunque strategie sbagliate; e su questo sono sicuro di avere ragione.
L’autore: Guido Ortona è economista, già professore di Politica economica presso l’Università del Piemonte orientale; [email protected]