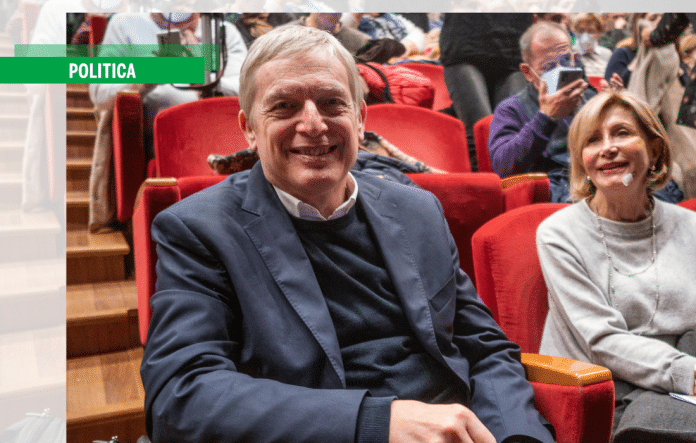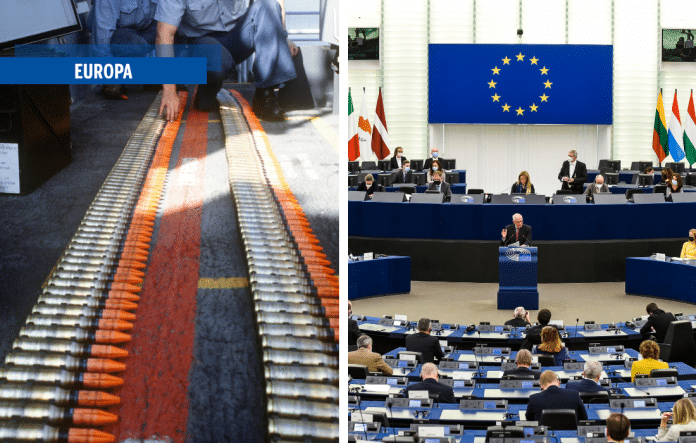Incontro Giyasettin Şehir – attore, insegnante, regista teatrale e cinematografico curdo – durante alcune ricerche online sulle condizioni dei detenuti nelle carceri turche. Ha vinto diversi premi come il Festival internazionale del film Antalya Golden Orange in Turchia – migliore direzione artistica – a cui ha partecipato nel 2011 con il film Yürüyüş (Meş). Diversi articoli poi danno notizia del suo arresto nel settembre 2018 presso Diyarbakır con l’accusa di far parte di un’associazione terroristica. Già negli anni Novanta e Duemila Şehir era stato detenuto più volte in Turchia. Ha un profilo social su facebook. Gli scrivo per chiedergli un’intervista ed è da qui che inizia la nostra fitta corrispondenza. Şehir risponde dal campo profughi di Chiasso, in Svizzera. «Le mie condizioni non sono molto adatte per scrivere. Non ho strumenti tecnici oltre al mio telefono. Oggi esco dal campo e prendo un quaderno e una penna così comincio a scrivere. Poi copio tutto sul telefono e invio le mie risposte». Così è iniziato il nostro colloquio a distanza.
Dopo aver realizzato questa intervista è arrivata la notizia che il 28 novembre la Segreteria di Stato della migrazione gli ha concesso ufficialmente asilo in Svizzera riconoscendogli lo status di rifugiato politico. Adesso Giyasettin Şehir vive a Lucerna.
Giyasettin Şehir, qual è stata l’accusa nei suoi confronti nel processo in Turchia?
Sono stato accusato di aver tenuto delle conferenze presso il partito curdo chiamato Hdp (Partito democratico dei popoli). Ma io ho spiegato nei tribunali che sono un artista curdo e sono contrario al regime e tutto quello che faccio è realizzare la mia arte e vivere per essa. Il regime non accetta nessuna voce dissidente o diversa, senza tener conto della professione e reputazione della persona. Molti personaggi si trovano nella mia stessa situazione; penso all’imprenditore e difensore dei diritti umani Osman Kavala, al pianista Fazil Say, alla presidente dell’Associazione medica turca Şebnem Korur Fincancı, al politico Selahattin Demirtaş. Ora in Turchia ho una condanna a 7 anni e 6 mesi. Circa quattro mesi fa sono arrivato in Svizzera.
Era consapevole, con la sua produzione artistica, di quello che le sarebbe accaduto nel suo Paese?
So che essere un dissidente in Turchia e soprattutto essere curdo ha dei costi. Il fine della mia arte è raggiungere la verità e gridarla. Sapevo che ci sarebbero state delle conseguenze, ma non avrei mai pensato fino a questo punto. Il processo che sto attraversando ora me lo sta dimostrando in modo cruciale ma non mi sono mai pentito delle mie azioni.
Ha realizzato diverse opere che sono successi artistici come il film Mesh, una storia ambientata a Nusaybin, un villaggio curdo nel sud-est della Turchia, durante il golpe militare del 1980. Pensa che l’arte possa cambiare lo stato delle cose (sociali, politiche, di diritto)?
L’arte è la voce e il linguaggio della coscienza della società. Forse non ha il potere di cambiare tutto, ma il suo effetto è imprevedibile. L’arte attira l’occhio con la sua visuale, colpisce l’orecchio con il suo timbro. Fa appello al cuore con il suo aspetto letterario e soprattutto, risveglia le coscienze con la sua retorica attraversando mitologia, storia, letteratura, attualità, teatro, filosofia, matematica e persino scienze fisiche. L’arte esiste dall’inizio della storia e esisterà finché esisteranno le persone, la vita e la società.
A quando risale la sua prima esperienza artistica?
La mia prima esperienza seria sul palcoscenico è stata nel 1991, avevo diciotto anni. Abbiamo preparato uno spettacolo in due atti e alcune scenette per la celebrazione del Newroz. Quando sono salito sul palcoscenico, mi sono trovato faccia a faccia con il pubblico che gremiva la sala. Era un’atmosfera emozionante, affascinante, mi sembrava di essere in un sogno e il palcoscenico è stato per me come un veleno che è penetrato nelle vene.
Poi dalla primavera del 1992 fino all’autunno del 2002 ha vissuto in carcere. È un tempo lunghissimo…
Portavamo in giro molti spettacoli teatrali fino a quando una mattina la mia casa è stata perquisita e io sono stato preso in custodia. Per un mese sono stato torturato. Era come se ogni giorno mi venissero tolti dei pezzettini dal corpo. Io stesso ero stupito dai suoni che emettevo nei momenti di tortura. Non è mai stata una voce umana. C’è da dire che in carcere ci sono due opzioni: arrendersi alle condizioni della prigione e quindi alienare la propria identità, personalità e arte, oppure trasformare quel posto in una scuola costruendo un laboratorio dove acquisire profondità intellettuale e pratica. Non mi sono mai arreso in nessuna circostanza nella mia vita. Ho resistito e provato con pazienza e ostinazione. Invece di fissare un unico obiettivo, ho preferito camminare costantemente. E mi sono aggrappato ai libri leggendo di movimenti artistici e teatrali, generi, maestri, tecniche, ecc. Ho confrontato, tratto conclusioni, prodotto le mie sintesi. A poco a poco, stavo acquisendo profondità e maturità. Da un lato resistevo alla violenza, alle condizioni del carcere e, dall’altro, ero impegnato a istruirmi. Dopo lo studio è però sorta un’altra esigenza: coronare la conoscenza con le esperienze pratiche.
Parla di violenza, delle dure condizioni del carcere ma con la possibilità comunque di istruirsi, leggere, organizzare spettacoli teatrali. Potrebbe sembrare contraddittorio…
Non c’è tortura sistematica durante la detenzione ma viene eseguita soprattutto durante l’interrogatorio da parte della polizia, prima di entrare in prigione. Attraverso la resistenza, scioperi, siamo riusciti a conquistare anche alcuni diritti come quello allo studio.
Dopo gli studi in carcere, diceva, ha avuto necessità di mettere tutto in pratica. In che modo ha cominciato a organizzare spettacoli teatrali in carcere? E come hanno reagito i compagni alle sue proposte?
Vivevo con 50 persone con cui stavo 24 ore al giorno ed è stata una grande opportunità. Organizzavamo il palcoscenico unendo i tavoli da pranzo. Una serie di costumi locali, tendaggi, cappelli, berretti, ecc., avrebbero potuto soddisfare il bisogno di costumi per le fasi iniziali; la luce del palcoscenico poteva essere ottenuta dipingendo le lampadine e inserendole in fessure di cartone mentre il suono era prodotto con un lettore di cassette. Alcuni compagni avevano anche un precedente background teatrale. Tutto era perciò pronto per creare un gruppo con il potenziale per realizzare molte cose insieme. Per prima cosa abbiamo iniziato con dei laboratori didattici che ci hanno aiutato a sviluppare varie tecniche. Man mano che il linguaggio del corpo, il diaframma, la voce, le intonazioni e le tecniche di recitazione miglioravano, abbiamo iniziato a lavorare su spettacoli in due atti. La destrezza e il pensiero creativo hanno prodotto risultati sorprendenti. Poi abbiamo iniziato a concentrarci su spettacoli più specifici che richiedevano la sincronizzazione corporea con la danza, la musica e la coreografia. In poco tempo, i nostri spettacoli hanno attirato l’attenzione di altri reparti politici, giudiziari e persino dell’amministrazione penitenziaria. C’erano visite ai rioni una volta alla settimana e l’opportunità di riunirsi in alcune giornate nazionali e culturali, e il nostro pubblico è aumentato. Queste condizioni sono state preziose per noi perché sono state ottenute attraverso la resistenza. Poi ci siamo domandati: “Perché non facciamo anche proiezioni di film?”. Dopo molti tentativi, finalmente ce l’avevamo fatta. Avevamo realizzato un proiettore fatto a mano con scatole di cartone e lenti per proiettare le immagini sulle pareti. Abbiamo messo in scena dozzine di opere teatrali nel corso di dieci anni. Alcune delle commedie erano adattamenti di testi già esistenti ma la maggior parte consisteva in testi scritti da noi. Oltre ad acquisire padronanza sia teorica che pratica, il dungeon (terreno di gioco, ndr) è stato una scuola che ha permesso alla mia personalità, identità, pensiero, di crescere. È stato un decennio pieno di resistenze, scioperi della fame, digiuni mortali e ovviamente, arte. Ho imparato qui la resistenza, la pazienza, la caparbietà inflessibile, la produttività, la solidarietà, il pensare bene e fare il bene, e che si può fare molto anche con risorse scarse. Ho acquisito la consapevolezza che la povertà non è privazione e che il potere della creazione è reso illimitato dalla determinazione del proprio pensiero creativo.
Quali sono stati i modelli, i personaggi che hanno influito nella sua carriera artistica?
Yılmaz Güney è stato un idolo per me fin da adolescente. Volevo come lui fare film e avere un impatto nel mondo come regista curdo anche se era difficile raggiungere il suo livello. Anche l’incontro con l’ambiente patriottico curdo è stato uno dei principali elementi che hanno giocato un ruolo importante nella mia formazione. Il soggetto dell’arte che dirige la mia vita e determina la mia esistenza è l’amore semplice per la natura, gli esseri viventi e la vita. Secondo me, la traiettoria principale, corpo e centro dell’arte è la bellezza.
Da artista, da uomo… come descriverebbe il Kurdistan?
Il Kurdistan mi ricorda sempre una donna. Secondo la struttura della lingua curda, ha già di per sé un significato femminile. È per me madre e amante, bellezza e dolore. Il mio legame verso di lei mi ricorda l’epopea degli amanti Mem û Zîn e il loro amore che viene ostacolato non facendoli mai ricongiungere se non alla loro morte.
Qual è la sua posizione circa le responsabilità politiche da parte dell’Onu verso il regime turco e la questione curda?
La Repubblica di Turchia ha sempre in qualche modo voluto appartenere alla cultura occidentale formando partnership militari ed economiche per ricevere aiuti e sostegno politico europei. Si è unita alla Nato sfruttando la sua posizione geo-strategica come arma di scambio contro la lotta dei curdi. Basti pensare che la maggior parte delle bombe che cadono in Kurdistan sono di origine europea o alla messa al bando delle istituzioni curde in Europa. Insomma, il regime turco non vuole nulla a favore dei curdi in nessuna parte del mondo. L’Onu ha visto il massacro curdo come una questione di diritti umani ma non è solo questo: è una lotta per l’identità, la lingua, la cultura e per la patria. I veri sostenitori dei curdi sono le istituzioni della società civile, gli attivisti, gli intellettuali, i difensori dei diritti umani, i socialisti. Gli Stati non sono veramente interessati alla questione in Kurdistan, né possono esserlo per le relazioni politiche, militari, economiche che intercorrono tra di loro.
Giyasettin Şehir, lei è stato arrestato nuovamente nel 2018, ha trascorso quattro mesi in carcere fino alla pena definitiva che l’ha portato a scappare fino a raggiungere la Svizzera. Racconti il suo viaggio.
Dopo essere stato a Istanbul per 8 mesi, mi sono trasferito a Edirne. Ho stretto un accordo con una rete di contrabbandieri. Era inverno, le traversate erano diventate molto difficili e le ispezioni militari erano aumentate sia al confine turco che a quello greco. Ci sono due modi per oltrepassarlo: attraversare il fiume Meriç in barca oppure scavalcare i fili di ferro spinati alti 5 metri. Sono rimasto a Edirne per tre mesi e ho provato a passare più volte il confine senza riuscirci. Con un mio compagno e la nostra guida ci abbiamo nuovamente provato la notte del 24 dicembre 2021. Dopo una camminata di quattro ore sul confine turco, abbiamo raggiunto la recinzione sul confine greco. Mentre camminavamo è arrivata una pattuglia militare turca e abbiamo dovuto nasconderci. Ci cercavano nella foresta, sotto tutti gli alberi ma la nostra guida ci ha aiutato a scappare facendoci sdraiare sul terreno più pianeggiante. Quando si sono assicurati che non fossimo lì, sono saliti in macchina e se ne sono andati. Abbiamo aspettato per un po’ senza muoverci. Siamo tornati ai fili. La guida è salita rapidamente ed è arrivata in cima. Il mio amico mi ha chiesto di salire per primo ma ho rifiutato. Ho sostenuto la guida dal basso e l’ho fatto salire. Quindi, ha attraversato i fili ed è passato in Grecia. Dopo abbiamo dovuto percorrere un terreno pianeggiante di 100 metri. Dopo che il mio amico ha oltrepassato questa terra, è corso veloce e si è rifugiato in un ruscello asciutto e ci ha aspettato. Era il mio turno. Il filo spinato era costituito da due parti. Non c’era niente a cui aggrapparsi nella prima. Non c’era posto dove mettere i piedi e ottenere supporto. Ho cercato di resistere e salire con le braccia ma non avevano la forza per sollevarmi. Anche la borsa, che avevo riempito con bottiglie d’acqua, sulla schiena era pesante e ci ho provato finché non ho perso le forze. Quando la guida si è resa conto che non riuscivo mi è venuto in soccorso e ho scalato la prima sezione. I fili spinati mi graffiavano le gambe in molti punti e quando ero proprio sopra, due veicoli venivano verso di noi dal lato greco e dovevo atterrare velocemente altrimenti sarei stato catturato e deportato al confine. Mentre cercavo di scendere le mie mani sono scivolate e sono caduto da 4 metri. Le bottiglie di plastica dell’acqua nella borsa mi hanno protetto la schiena e la testa. Mi sono alzato velocemente perché i veicoli erano vicini adesso. Il mio piede era dolorante, avevo dei tagli sul corpo e la mia energia era esaurita. Ho iniziato a correre con tutte le mie forze. E finalmente, esausto, ho raggiunto il ruscello. Entrambi siamo passati ma la guida è rimasta dalla parte turca a causa dei veicoli in arrivo. Non conoscevamo la strada e non potevamo continuare da soli. Ci siamo seduti e abbiamo aspettato che passassero i veicoli che sono andati via dopo mezz’ora. Una voce proveniva dalla recinzione. La guida non ci aveva lasciato, stava salendo i fili per raggiungerci e la nostra marcia è proseguita in Grecia. Abbiamo camminato per due ore e ci siamo presi la prima pausa. Il pericolo era stato ridotto. Abbiamo acceso una sigaretta ciascuno. Le luci della città si vedevano vagamente. E tutti i dolori nel mio corpo hanno iniziato ad attaccare come un esercito barbaro, il mio cervello, il mio cuore. Ho preso una maglietta dalla borsa e l’ho avvolta intorno alle dita del piede. Dopo aver camminato per due ore siamo arrivati ai binari di Tiren. Questa è stata la parte più difficile per me. O camminavo calpestando i binari oppure la ghiaia. Dopo aver camminato per altre quattro ore in questo stato, siamo arrivati alla stazione dei treni (Banhof) della prima città greca al confine. Erano le 9 del mattino. Abbiamo chiamato il contrabbandiere al telefono e aveva delle richieste per noi. Gli abbiamo inviato un selfie. Indossavamo un vestito pulito e abbiamo lasciato lì le valigie. Dopo aver fatto quanto richiesto, ci siamo costituiti alla prima stazione di polizia. Dopo 45 giorni in una prigione greca siamo stati liberati. Sono rimasto a Salonicco e ho dovuto vivere in Grecia per 8 mesi. Dopodiché, il mio passaggio in Svizzera.
Quali sono le condizioni nel Campo d’asilo a Chiasso?
Ci sono molte persone qui, sia curde che di altre nazionalità, è affollato. Dormo insieme ad altri dieci nella stessa stanza. Abbiamo la possibilità di uscire durante il giorno dalle 9 del mattino alle 18 della sera. C’è il fine settimana festivo e chi ha un posto dove andare può andarci. Di solito esco e sto seduto a un caffè, faccio una passeggiata, leggo notizie, guardo film. Cerco di passare il mio tempo in modo produttivo. A volte bevo qualche birra o qualcosa del genere. Ci sono bambini e famiglie, politici, richiedenti asilo (colombiani, arabi, georgiani, alcuni neri).
Anche Ucraini?
Sì, ma il loro posto è in un altro edificio. Quando non c’è spazio li possono trasferire qui.
E come si sostiene economicamente? Riceve aiuti?
Qui danno 21 franchi a settimana, due pacchetti di sigarette insomma. Avevo dei soldi con me quando sono arrivato e stanno finendo ma resisterò come sempre.
Dopo tutto questo tornerebbe come artista in Turchia?
Il mio paese è il Kurdistan e mi piacerebbe fare arte lì. Tuttavia, non ci sono condizioni per me di vivere in Turchia. Ho resistito fino alla fine per restare.
È cresciuto a Diyarbakır. Che ricordi ha della sua infanzia?
Ho completato la mia istruzione primaria, secondaria e superiore lì ma fui gettato in prigione prima di avere l’opportunità di iniziare la mia formazione universitaria. Gli anni della mia infanzia sono stati i migliori. Ho trascorso ogni momento del mio tempo tra curiosità e ricerca. Ero attivo e veloce. Tanto che molto più tardi mia madre mi avrebbe detto “come se avessi fretta”. Volevo arrivare ovunque e avere tutto e subito, cercando di fare tante cose insieme. Anche a quell’età, mi sono ritrovato a correre al cinema nel tempo libero. Lavoravo per il proprietario del cinema e ho avuto l’opportunità di guardare i film vendendo pop corn e soda nella sala.
Poi il carcere… fino al 2002. Come è stato il ritorno alla vita quotidiana?
La città, che non vedevo l’ora di rincontrare con entusiasmo e impazienza, aveva un volto diverso. Quando l’autobus su cui sono salito è entrato in città, l’unico sentimento che si è fatto avanti in me è stata la delusione. Non c’era più traccia della città in cui sono nato, cresciuto. Gli edifici moderni, le strade larghe e le file di automobili che viaggiavano nel caos mi erano estranei e non si adattavano affatto a Diyarbakır. Mi hanno portato a casa di mio padre nella nuova zona residenziale. Sono stato lì per alcuni giorni con un sentimento di freddezza ed estraneità. Tutti mi venivano a dare il benvenuto. Avevano un viso caldo e sorridente tra pranzi, conversazioni, risate e ricordi. Ma non riuscivo a sentire quello che veniva detto, non potevo unirmi alle risate, non potevo condividere i sentimenti. Mi sentivo come un uomo solo in un universo astratto. Anche la tecnologia era cambiata. Tutti avevano strani telefonini in tasca. Ne avevo sentito parlare, ma era la prima volta che li vedevo. E poi me ne hanno regalato uno. All’inizio riuscivo a usare solo il pulsante di accensione. Lo utilizzavo come fosse walkie-talkie. Lo portavo alla bocca e parlavo ad alta voce, poi lo portavo all’orecchio e ascoltavo la voce dall’altra parte. Computer portatili, giochi virtuali, registratori di cassa ecc. erano sorprendenti e interessanti. Anche gli ascensori.
E l’incontro con gli ambienti culturali invece?
In poco tempo sono stato incuriosito da alcuni ambienti artistici. Alcune brave persone avevano avviato uno studio per aprire un centro culturale a Diyarbakır. Dopo averli incontrati ho chiesto loro di essere coinvolto. Ho iniziato a far parte di quel gruppo con grande entusiasmo. Dopo un lavoro faticoso, ero diventato manager e insegnante di teatro presso il centro culturale che abbiamo aperto il 23 aprile 2003. Fino al 2006 ho cercato di organizzare laboratori. Dalla fine del 2006 al 2010, ho iniziato a lavorare nel comune di Mardin Nusaybin come responsabile della cultura. Ho avuto la fortuna di aprire qui il Centro culturale Mitanni. Abbiamo organizzato molti eventi che hanno fatto rumore in questo enorme centro. Anche qui ho continuato a produrre opere teatrali con una compagnia da noi fondata. Nel 2017 sono tornato a Diyarbakır e ho continuato il mio lavoro presso il Centro culturale Dicle Fırat. Abbiamo fatto spettacoli con un gruppo teatrale chiamato Teatra Yekta Hêvî. Con questa squadra abbiamo eseguito spettacoli che hanno attirato l’attenzione e fatto molto rumore. La squadra ha continuato il teatro dopo di me ed è ancora attiva. Gli spettacoli che ho diretto hanno partecipato a molti festival nazionali e internazionali e sono stati apprezzati.
Quali saranno i suoi progetti ora che è in Europa?
Ogni periodo della mia vita è stato per me un processo nuovo, stimolante e prezioso. Ora ho iniziato una nuova fase entrando in Europa ed è entusiasmante, piena di speranza. Penso che continuerò i miei studi con la stessa vivacità ma con più qualifiche. Indubbiamente, quello europeo è un campo nuovo per me, quindi ci vorrà del tempo per rivelare, valutare le opportunità. Nuova vita, nuove persone, nuove opportunità sono gravide di buoni risultati se valutate bene.
In apertura, Giyasettin Şehir in una foto dalla sua pagina facebook