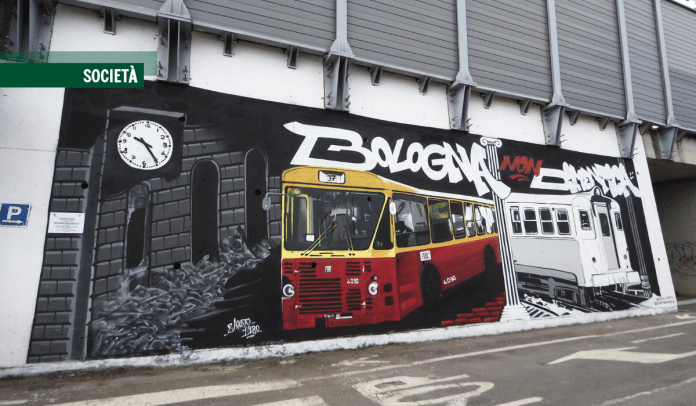La forza della rivoluzione e la fiducia nel cambiamento traspaiono nei documentari del regista tunisino Walid Falleh. Fin dalla sua partecipazione alla Rivoluzione dei Gelsomini nel 2010 e nel 2011, Falleh, 38 anni, ha trovato nell’arte e nell’informazione un potente mezzo di cambiamento. La videocamera è diventata il suo sguardo, il mezzo attraverso il quale cerca di capire e raccontare la realtà. E la realtà che si è trovato davanti ha mille volti: la fiducia e poi la disillusione nel progetto rivoluzionario tunisino, la drammaticità delle morti in mare di chi cerca l’Europa, ma anche la lotta e la determinazione di molti migranti subsahariani nel sorpassare i confini e rivendicare i propri diritti. Falleh racconta la migrazione dentro e oltre le frontiere tunisine. E ribadisce, in ogni situazione c’è sempre una scelta.
Questa convinzione assume particolare valore nell’attuale contesto tunisino. «È molto preoccupante che la Tunisia abbia adottato una nuova Costituzione che compromette i diritti umani e mette in pericolo i progressi fatti dalla rivoluzione del 2011» denuncia Amnesty international in merito alla vittoria del Sì nel referendum dello scorso 25 luglio, indetto dal Presidente della Repubblica, Kaïs Saïed. Un voto che ha visto una astensione elevata, vicina al 70%, e ha provocato forti tensioni nel Paese. La crisi politica in atto, però, è frutto di una crisi economica e sociale. La Tunisia sta subendo le conseguenze della pandemia e della guerra in Ucraina, raggiungendo un tasso di disoccupazione del 16% con duri effetti sulla vita dei cittadini, molti dei quali vedono come primo responsabile dell’instabilità del Paese il partito islamico di Ennahda. Il partito è stato al centro della politica tunisina negli anni dopo la Rivoluzione fino al luglio 2021, momento decisivo nella crisi-politico istituzionale, in cui è maturata la svolta autoriaria del presidente Saïed.
In Tunisia lunedì 25 luglio è stata approvata la nuova Costituzione, mediante un referendum a cui solo il 30% della popolazione ha partecipato. Verrà quindi sostituita la Costituzione del 2014, accentrando in tal modo i poteri nelle mani del Presidente della Repubblica, Kaïs Saïed. Cosa pensa al riguardo?
Non si può ridurre l’attuale situazione in Tunisia a un giudizio sintetico, positivo o negativo che sia. Personalmente avevo supportato la decisione di Kaïs Saïed di sospendere il Parlamento lo scorso 25 luglio 2021 e di licenziare il primo ministro Hichem Mechichi. Ed è comprensibile la scelta di istituire un referendum nazionale per la riforma della Costituzione, svoltosi questo 25 luglio 2022. So che Kaïs ha preso questa decisione da solo e non ha considerato la società civile, ma ritengo che si stia passando attraverso un periodo di transizione in seguito al quale queste decisioni verranno poi accettate da tutta la cittadinanza. La popolazione vuole che i corrotti del governo degli anni precedenti siano chiamati a rispondere di fronte alla giustizia. Così Kaïs è visto come il salvatore e l’uomo adatto per la situazione. Fondamentalmente perché è un avvocato. Inoltre considero che sia più semplice vedere come responsabile una sola persona, che un intero gruppo di corrotti. Detto ciò, ovviamente rimaniamo in allerta e pronti a manifestare in caso che Kaïs superi il limite e instauri una dittatura. Al momento noi giovani continuiamo a lottare contro le aggressioni della polizia e questo rimane un punto nero del modo di governare di Kaïs. In generale penso si debba continuare a protestare e a impegnarsi per riuscire a sviluppare una migliore situazione economica che è ciò che più interessa ai cittadini.
Come si inserisce la questione migratoria all’interno di questo contesto?
In Tunisia molte persone vedono l’immigrazione nel Paese come un problema. Sono preoccupate per l’assenza di lavoro e l’economia in bilico. Così non riescono ad essere empatiche, fanno fatica a trovare soluzioni per dare una buona accoglienza. E a livello strutturale e istituzionale non c’è un piano, ma nuovi migranti continuano ad arrivare, così che si va creando un conflitto sociale.
Sta lavorando a un nuovo documentario proprio sul tema della migrazione, Baba Chams. Se da un alto vi è diffidenza, altre persone si stanno invece organizzando per reagire con la solidarietà, come racconta il tuo prossimo lavoro. Ci può spiegare meglio di cosa si tratta?
Il protagonista è un pescatore tunisino della mia città, Chamseddine Marzoug, che ha deciso di rimanere nel Paese, mentre la sua famiglia se n’è andata con un barcone. Sua moglie e i suoi figli sono tutti in Europa. È un pescatore, gli piace pescare, gli piace la sua routine e vivere a Zarzis. Fa attivismo politico, lo trovi dappertutto mentre aiuta e supporta i migranti a giro per la città. Nella sua casa in questo momento vivono alcuni migranti subsahariani a cui hanno bruciato l’appartamento: ha una nuova famiglia anche qui.
Chamseddine segue la legge del mare, non lascia morire chi ha bisogno di aiuto. Ma non si prende cura solo dei vivi…
Lo Stato tunisino non è preparato a gestire la migrazione subsahariana degli ultimi anni. Il governo non sembra interessarsene, perciò la questione diventerà ancora più problematica, socialmente e logisticamente. Ma Chamseddine ha reagito alla realtà che si è trovato di fronte. Così si è reso subito conto della necessità di un cimitero. Il “Cimitero degli stranieri”. Ha iniziato a seppellire i migranti non sopravvissuti al viaggio verso l’Europa e a prenderne i dati anagrafici, perché sapeva che la famiglia li avrebbe cercati e chiesto di loro.
Perché per il suo documentario ha scelto come titolo Baba Chams?
Baba significa papà in arabo. Chams è il suo nome, ma nella sua forma scritta significa anche “sole”. Tutti i migranti lo chiamano “baba, baba”; inoltre è il padre della sua famiglia in Europa. È affascinante vedere quest’uomo gentile come un padre, il padre di tutti. Perfino quando siamo andati al cimitero mi ha detto: «Vedi, queste persone non hanno una famiglia qui, sono io la loro famiglia». È commovente. Credo sia più o meno dal 2012 che li seppellisce, si prende cura di loro, prega per loro.
Perché ha deciso di raccontare questa storia?
Qualche anno fa ero a Zarzis, la mia città, in occasione di una protesta internazionale organizzata dai pescatori tunisini contro le frontiere e la guardia costiera italiana. Ho potuto conoscere meglio Chamseddine, così ho iniziato a seguire le sue attività e a riprenderlo. Spero di riuscire a finire il documentario per settembre, sto facendo un crowdfunding per portarlo a termine. Voglio raccontare la vita del pescatore, da solo a casa o in giro per la città, la routine con le sue tante famiglie. Non voglio che appaia solo la storia del cimitero, lui è più di questo. Lui era un semplice pescatore, non coinvolto nell’attivismo politico, ma ora se lo incontri lo percepirai quasi come un “eroe politico”, perché reagisce e fa semplicemente quello che sente come un dovere. La sua vita è cambiata radicalmente.
La migrazione, le morti in mare e alle frontiere, sono spesso percepite come qualcosa di distante dalla nostra vita di tutti i giorni. Chamseddine invece ne è venuto a contatto incontrando barconi pieni di persone mentre svolgeva le sue attività quotidiane da pescatore. Pensa che il suo sia un caso eccezionale?
No, ci sono molti altri esempi, io stesso lo sono. Prima non ero troppo interessato al tema migratorio, ma quando ho cominciato a vedere le persone partire di fronte ai miei occhi, mi sono chiesto che cosa avrei dovuto fare. Il mio impegno ha la stessa origine di Chamseddine. Immediatamente dopo la fine della rivoluzione in Tunisia, nel 2011, è iniziata la guerra in Libia, con cui Zarzis confina. Sono cominciati ad arrivare moltissimi rifugiati, intorno al milione, così le autorità tunisine hanno creato a Médenine, qui vicino, un campo per rifugiati insieme all’Unhcr, detto Choucha. Compare anche nel mio film Boza. È proprio in quel momento che molti giovani della mia città sono andati ad aiutare a Choucha come volontari insieme alla Croce rossa o al Danish refugee council, io compreso.
Boza – di cui poi le chiederò di parlarci – non è la sua prima opera in cui si parla di migrazione. Nel suo primo cortometraggio, Liberté 302, aveva raccontato insieme al suo gruppo, Zarzis Tv, una altro tipo di migrazione, quella degli stessi tunisini verso l’Europa…
Prima che andassi come volontario al campo profughi Choucha ho visto molte persone della mia città partire per l’Italia. Erano persone giovani, le stesse persone che avevano fatto la rivoluzione. Con il mio gruppo di amici, Zarzis Tv, abbiamo cominciato a filmare questa migrazione, perché volevamo capirla. Per me all’inizio quella situazione era incomprensibile, ogni giorno vedevo barconi pieni partire. Continuavo a chiedermi perché quelle persone non credessero in quello che avremmo potuto fare e cambiare dopo la rivoluzione. Perché non avessero fiducia. Ma poi ho capito che le ragioni per lasciare la propria terra sono molteplici, è una questione di libertà, dignità, vita. Un giorno un gruppo di giovani tunisini si era avviato verso l’Italia con un barcone improvvisato. L’esercito tunisino li ha rintracciati, per poi danneggiare e rompere la barca. Molte persone sono morte o rimaste disperse. Abbiamo deciso di raccontare questa vicenda. Il nome della nave dell’esercito è il titolo del nostro cortometraggio: Liberté 302.
Dopodiché ha cominciato a parlare della migrazione anche oltre le frontiere tunisine. Nel suo documentario, Boza, è partito dal suo Paese, ha oltrepassato i confini per arrivare fino all’Europa.
Dopo essere stato a Choucha, sono stato invitato in Marocco per lavorare con Gadem (Gruppo antirazzista di difesa e accompagnamento alle persone straniere e migranti, ndr). Lì, ho iniziato a riprendere alcuni momenti di un processo contro un attivista politico camerunense che difendeva i diritti dei migranti nel Paese. Anche se non compare nel film, è nata lì l’idea del mio documentario Boza, che ho iniziato nel 2014.
A differenza di Baba Chams, in Boza ci sono numerosi luoghi, differenti voci, e molteplici situazioni. Cosa li unisce gli uni con gli altri?
In Boza ci sono tre diverse prospettive, tre diverse possibilità. Volevo mostrare che c’è sempre una scelta. In Tunisia, nel campo di Choucha, le persone hanno deciso di aspettare. Attesa, solo attesa. Non hanno niente da fare, se non aspettare anni e anni che qualche organizzazione li consideri e che li porti in Europa regolarmente. Altri hanno preso una decisione. Partire. Questa è la seconda situazione che racconto: il Marocco e la foresta vicino Ceuta dove le persone si nascondono in attesa di trovare il momento giusto per provare ad attraversare il confine verso l’enclave spagnola. Appaiono poi alcuni momenti della Marcia per la libertà da Strasburgo a Bruxelles, durante la quale i migranti già arrivati hanno deciso di lottare, che è quello che mi auguro accada sempre. Lottare per i propri diritti. Le circostanze sono molteplici, ma si può sempre scegliere. Non conta tanto dove sei, ma come sei in quel luogo.
La parola boza, che è anche il titolo, viene introdotta attraverso la melodia di una canzone che alcuni migranti cantano nel bosco in cui sono accampati in Marocco. Cosa significa?
Nella foresta i migranti subsahariani hanno un linguaggio segreto. Davvero, è incredibile, hanno creato un linguaggio per non farsi capire dalla polizia e dalle persone arabe. Hanno dei codici. Boza è usato in diverse occasioni, quindi ha un significato ampio. Quando devono avviarsi verso il confine, devono “andare per boza”. Andare verso la vittoria. Ci sono alcuni video nel mio documentario dove alcuni ragazzi saltano il confine e iniziano a urlare “boza, boza”, “ce l’abbiamo fatta!”. Ho visto molta speranza seppur all’interno di un contesto così problematico.
Qual è la relazione tra spazio nascosto, come la foresta, spazio privato, come le case che riprende in Marocco, e spazio pubblico, come quello della marcia?
Non me lo sono mai chiesto. Penso che il legame tra gli spazi, il loro intreccio, sia venuto in modo spontaneo. Il mio modo stesso di filmare è spontaneo. Andando su un piano filosofico, la penso un po’ come Marx: attraverso l’esperienza delle persone, come la rivoluzione del 2010, nasce un’idea e da questa idea sorge l’esperienza che viviamo. C’è continuità. Per me è stato così, non avevo un’idea chiara sulla migrazione in Marocco e sulle frontiere. Poi sono andato con la mia videocamera nella foresta, ho potuto vedere cosa stava succedendo lì e farmi un’opinione attraverso la quale ho vissuto nuove esperienze. I miei documentari sono il mio riflesso. La videocamera i miei occhi. Nel contenuto non c’è solo quello che appare, ma anche quello che ho vissuto. Ho bisogno di immergermi e leggere l’esperienza che sto vivendo come se fosse un libro da cui imparare. Ho impiegato tre anni per finire Boza, mentre sono già due anni che sto seguendo Chamseddine.
Qual è la relazione tra lei come regista e i protagonisti dei suoi documentari?
Quando entri nella vita reale di alcune persone, è fondamentale per me rispettare alcune regole. Ad esempio, per realizzare Boza, non avrei mai potuto iniziare a filmare fin dal primo giorno in cui mi trovavo in Marocco nei luoghi in cui vivevano i migranti. Ho passato tempo con loro, ho cercato di capirli e di farmi capire, li ho coinvolti. Riprendevo le persone quando si sentivano a loro agio, a volte mi dicevano “Walid, riprendi”, in qualche modo stavamo lavorando insieme al progetto. Durante la rivoluzione avevo sentito il bisogno di raccontare quello che stava succedendo senza aspettare che qualcun altro dall’esterno lo facesse. Molti giornalisti e registi venivano a riprendermi: ho lavorato con loro, ho imparato da loro e poi ho trovato il mio modo di raccontarmi e raccontare. Per questo motivo ho cercato di coinvolgere i migranti dei miei documentari, affinché potessero imparare e decidere come esprimersi.
Quindi non sono passivi, ma soggetti attivi. Non sono solo vittime.
L’intera questione migratoria è densa di drammaticità, ovviamente. Ma c’è anche tanta speranza. Non ho ripreso solo sofferenza e pianti. Le persone danzano, cantano, si divertono e lottano. I problemi non possono cambiare velocemente, perciò è importante avere fiducia nel cambiamento. Per spiegarmi meglio, basta pensare alla rivoluzione. Non è stato facile ribellarci, ma ci siamo riusciti. Alcune persone però pensavano che dopo la rivoluzione tutto sarebbe andato meglio, improvvisamente. Così si sono depresse e hanno smesso di credere e impegnarsi per quello che eravamo riusciti a fare. Niente può cambiare in un anno o due, è un percorso lungo, in cui la speranza è fondamentale. Questo voglio mostrare nei miei documentari: la ribellione, la lotta. E nella lotta c’è speranza. Non serve aspettare che le organizzazioni europee ci vengano a salvare. Dobbiamo organizzarci e trovare soluzioni da soli. Dopo la rivoluzione molte organizzazioni sono venute a insegnarci la democrazia. Non l’ho mai sopportato. È bello vedere formarsi una società civile strutturata, ma non durerà a lungo se le persone non si autorganizzano seguendo il proprio modo di pensare e i propri bisogni, reagendo, tutte insieme.