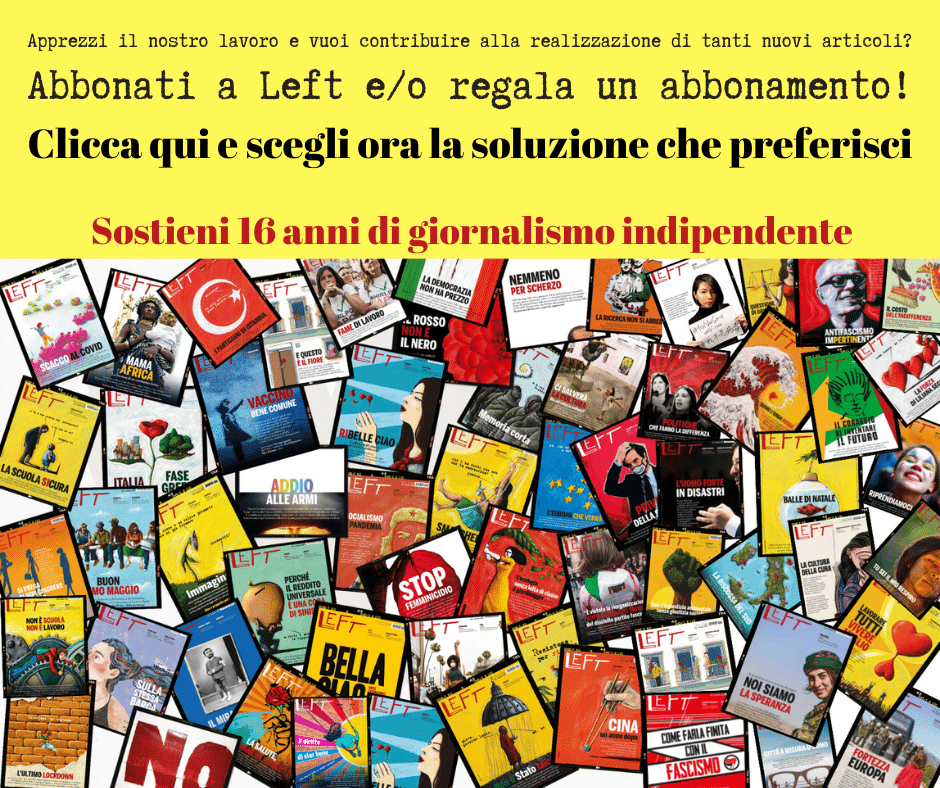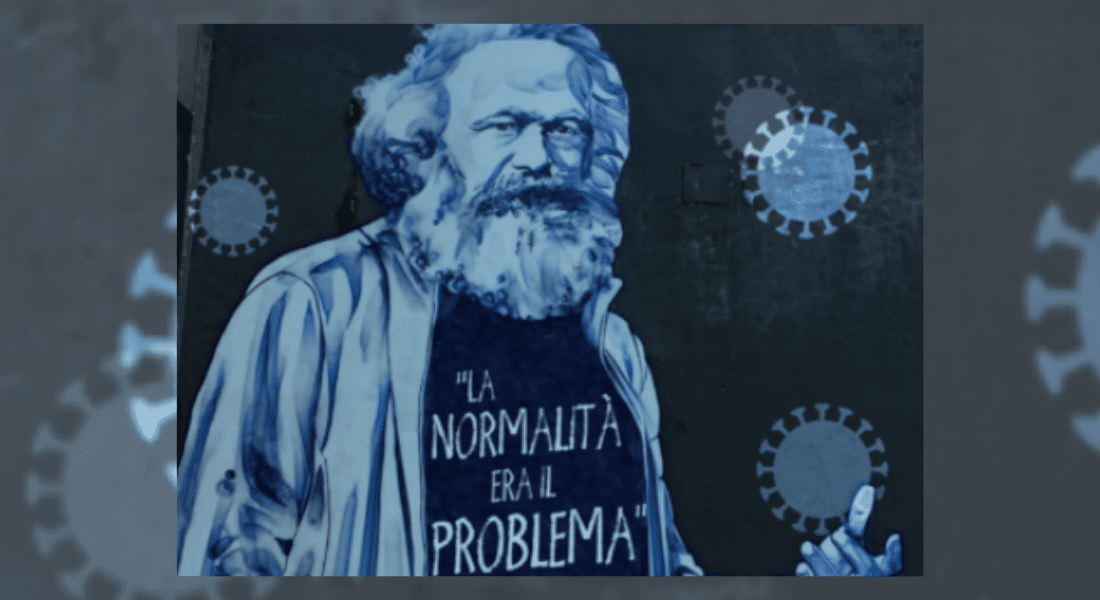Intitolare un parco alle vittime “delle Foibe e della Shoah”. È la proposta di un’assessora di Tarquinia, in quota Lega Nord. La più recente tra quelle messe in campo negli ultimi anni dalle destre in Italia con un preciso scopo: equiparare due vicende, l’Olocausto e una serie di violenze commesse dalla Resistenza jugoslava durante la Seconda guerra mondiale, entrambe drammatiche certo, ma assolutamente incommensurabili. Per farlo, nazionalisti, neofascisti e nostalgici non si sono fatti problemi ad “inquinare pozzi”. Con mistificazioni storiche, ricostruzioni inventate, numeri senza alcun legame con la realtà. A partire, ad esempio, dai «diecimila infoibati» di cui parla CasaPound. Così, i presidenti della Repubblica Napolitano e Mattarella sono arrivati a definire i morti delle foibe come vittime di una «pulizia etnica» che in realtà non ha avuto luogo.
L’obiettivo finale delle destre radicali è chiaro: disattivare il significato della Giornata della memoria celebrando ogni 10 febbraio un suo “omologo” anticomunista, il Giorno del ricordo; disseccare le radici antifasciste della nostra Repubblica; rilegittimarsi a livello nazionale e internazionale. Per opporci a questo gioco sporco, senza ovviamente sminuire in alcun modo crimini e tragedie che si verificarono sul cosiddetto confine orientale, compreso l’esodo italiano dall’Istria e dalla Dalmazia, e anzi indagandoli, abbiamo da quest’anno uno strumento assai prezioso. Si intitola E allora le foibe?, è appena uscito per Laterza nella collana Fact checking (realizzata con la collaborazione di Carlo Greppi, v. Left del 22 gennaio 2021) ed è l’ultima fatica dello storico e divulgatore Eric Gobetti. Con lui abbiamo fatto il punto su questo capitolo del Novecento, a partire dai riscontri storici, per ricostruire la reale dinamica degli eventi.
Per prima cosa, quando si parla di foibe e di esodo si fa spesso riferimento a territori “da sempre” italiani. È davvero così?
Per parlare di “territori italiani” bisognerebbe intendersi su cosa sia l’italianità, dato che la stessa idea di nazione inizia a diffondersi tra fine Settecento e inizio Ottocento. Dire che queste zone dell’Alto Adriatico, dove si è consumata la vicenda delle foibe e dell’esodo giuliano dalmata, erano italiane in quanto appartenevano alla Repubblica di Venezia è una castroneria. Venezia non era uno Stato nazione, la venezianità non era l’italianità. Lo stesso discorso vale ancora di più per l’Impero romano. La propaganda fascista gioca su queste ricostruzioni, che per uno storico sono prive di logica. Questi territori erano abitati da italiani, slavi, tedeschi, ungheresi e altri popoli. Vi era una grande commistione di popolazioni che hanno vissuto assieme per secoli, mescolandosi e creando identità comuni locali, entrate poi in crisi dalla fine della Grande guerra, quando queste zone entrano per la prima volta a far parte di uno Stato nazione, il Regno d’Italia.
La prima ondata di violenze al confine orientale contro la popolazione italiana si è manifestata nel 1943. Possiamo parlare di “pulizia etnica”?
Le violenze commesse dai partigiani jugoslavi non avevano una logica nazionale, né tanto meno “etnica”, bensì politica. Le vittime delle violenze avvenute dopo l’8 settembre erano principalmente rappresentanti dello Stato italiano, delle istituzioni del governo fascista. Vengono colpite non in quanto italiane bensì in quanto fasciste. Seppure non era facile distinguere le cose, poiché il regime insisteva nell’equivalenza tra fascismo ed italianità. Inoltre, un altro elemento che contraddice la narrazione della “pulizia etnica” è dato dal fatto che gli italiani erano presenti in entrambi i fronti. Spesso lo si dimentica, infatti, ma molti partigiani italiani combattevano al fianco delle forze di Resistenza slava. Nella primavera del 1944 si stima che fossero tra i 20 e i 30mila i partigiani italiani integrati nell’esercito jugoslavo. Una cifra incredibile, considerato che i partigiani in Italia nella stessa epoca erano numericamente equivalenti. Infine, va ricordato che in quella prima fase di violenze molti omicidi furono frutto di odio e vendette personali. Dopo l’invasione della Jugoslavia nel 1941 il livello di rabbia po- polare si era alzato enormemente.
Ciò che spesso si dimentica, poi, sono i crimini del regime fascista commessi in Jugoslavia.
Noi abbiamo un problema più generale con la memoria storica dei crimini fascisti, non solo quelli compiuti nei Balcani, si pensi alla vicenda del colonialismo in Africa. Gli italiani hanno avuto responsabilità dirette nella repressione della popolazione civile in Jugoslavia, i morti sono stati nell’ordine dei 10mila. Senza considerare le responsabilità indirette dell’aver appoggiato i movimenti collaborazionisti come gli ùstascia croati e i cetnici serbi, responsabili del maggior numero di uccisioni nel teatro jugoslavo, che ha contato un milione di morti. L’Italia ha anche costruito campi di concentramento in quella zona, che servivano a recludere civili, e non solo partigiani, i quali generalmente venivano fucilati. Sono stati circa 100mila gli internati in questi campi e 5mila le vittime, a causa del freddo e della fame. Nel campo dell’isola di Arbe, non molto distante da Fiu- me, abbiamo lasciato morire donne e bambini, circa 1.500 civili in tutto. Com’è possibile che ad oltre 80 anni di distanza questo episodio vergognoso sia stato quasi dimenticato? Proprio per costruire un sito dedicato alla storia del campo di Arbe e organizzare un viaggio della memoria abbiamo aperto un crowdfunding (lo si trova su Produzioni dal basso, ndr).
Arriva il 1945 e nell’Alto Adriatico si scatena una seconda serie di violenze.
In questo caso ci troviamo di fronte all’esercito di un Paese, la Jugoslavia, che fa parte dello schieramento antifascista internazionale, alleato con l’Urss e con gli Stati Uniti, che prende il controllo del territorio e compie due tipi di operazione. Da un lato una resa dei conti, in cui vengono prese di mira le persone che fino all’ultimo avevano combattuto coi nazisti oppure che erano rappresentanti del precedente governo fascista. È una pratica compiuta dai partigiani in varie parti d’Europa. Dall’altro l’eliminazione degli oppositori politici, quella che gli storici chiamano repressione politica preventiva. Fino al 1948 Tito era alleato di Stalin, in quel momento puntava a instaurare un regime comunista che guardava a Mosca come modello, e quello era uno dei modi per raggiungere il suo scopo.
Veniamo alle foibe, di cosa si è trattato e quali furono le dimensioni della tragedia?
Le foibe sono cavità naturali, simili a grotte verticali, tipiche della regione carsica e dell’Istria. Nei contesti di guerra sono state utilizzate come strumento di sepoltura rapida. Durante la Seconda guerra mondiale ci finirono sia i civili e partigiani uccisi da fascisti e nazisti, sia i soldati o i collaborazionisti uccisi dai partigiani. La pratica di gettare individui vivi nelle foibe non era certo comune, seppure lo sostenga un vario corredo di racconti mai verificati che appartengono ad un immaginario razzista che dipinge lo slavo come un barbaro primitivo. Inoltre, buona parte delle violenze che si consumano sul confine orientale non hanno nulla a che fare con le foibe. Arrivando alle cifre, io nel libro non propongo alcuna nuova ricerca, mi rimetto ai numeri che sono universalmente accettati tra gli storici, che vanno dalle 3.500 alle 5mila vittime, e prendo per buone le stime arrotondate all’eccesso, considerata la difficoltà nell’accertare le morti avvenute in quella circostanza. Su queste stime, ad ogni modo, tutti gli storici sono concordi, così come lo sono nell’escludere l’ipotesi della pulizia etnica.
Il luogo prescelto per celebrare la memoria delle Foibe è Basovizza, nel comune di Trieste, dove si trova un monumento nazionale. Nell’inghiottitoio che si trova in loco, in realtà un pozzo minerario, non è mai stato accertato alcun infoibamento. Cosa significa?
Già, non c’è certezza che siano realmente avvenute uccisioni in quella zona, però in fondo si tratta di un luogo della memoria, che è lecito individuare anche in una località arbitraria per facilitarne la fruizione. Tutto sommato è in Italia, vicino a Trieste, facilmente raggiungibile. Certo, il monumento dovrebbe essere gestito con più serietà. All’interno è rappresentata un’illustrazione della profondità del sito minerario, in cui viene calcolata la sua capienza, e si conclude che in virtù di quelle dimensioni la “foiba” conterrebbe alcune migliaia di persone. È assurdo. Poi ci sono le lapidi di gruppi armati della Repubblica sociale che hanno combattuto fino all’ultimo coi nazisti in quel territori. Se vogliamo che quello sia il monumento di un Paese fondato su una Costituzione antifascista, andrebbero eliminate all’istante.
Il Giorno del ricordo, però, gioca proprio su ambiguità come questa. E la sua genesi, come spieghi, lo dimostrerebbe…
Della vicenda delle foibe c’è stato un uso strumentale subito dopo la Seconda guerra mondiale, in chiave anticomunista. Eravamo in piena Guerra fredda. A questa fase è seguito un lungo oblio bipartisan, terminato in epoca più recente con un nuovo uso strumentale dai primi anni 2000. Un uso sbagliato per diverse ragioni. Primo: lasciando perdere gli aspetti più apertamente fascisti della vicenda, c’è una volontà nazionalista e vittimista esercitata dallo Stato italiano dietro alla nascita del Giorno del ricordo (coniato dal centrodestra nel 2004, ndr). È ciò è chiaro sin dal testo della legge che lo istituisce, che ci mette in imbarazzo con i nostri Paesi vicini, perché si parla solo delle “nostre” vittime e non di quelle del regime fascista. Nell’ottica di un reciproco rispetto tra Paesi europei si sarebbe dovuto procedere nella direzione di una memoria transnazionale, che tenesse conto anche delle diverse “memorie”. Secondo: questa celebrazione rischia di vittimizzare i fascisti. Questo è il problema. Poiché le vittime sono fasciste, dunque i fascisti sono le vittime. Che hanno così la possibilità di diventarlo senza neanche affrontare le loro responsabilità. È una costruzione simbolica che fa male all’Italia e pure agli esuli stessi, rappresentati, ingiustamente, come fascisti. Ultimo aspetto: la data della celebrazione. Il 10 febbraio è stato scelto perché in quel giorno del 1947 venivano firmati i Trattati di pace di Parigi, che assegnavano alla Jugoslavia l’Istria, parte della Venezia Giulia e altri territori in precedenza italiani. Quella data è molto calzante, naturalmente, se si parla dell’esodo a cui molti italiani furono costretti dopo la sigla di quell’accordo. Però, d’altra parte, è una scelta un po’ inquietante perché è come se stessimo affermando di essere stati “vittime della pace” e in qualche modo la mettiamo in dubbio. Vorrei ricordare, anche se potrà essere fastidioso alle orecchie di alcuni, che è un bene se abbiamo perso la Seconda guerra mondiale, perché l’Italia combatteva dalla parte sbagliata. Se avessimo vinto noi adesso saremmo tutti nazisti. Usare in senso vittimista una data che segna la nostra sconfitta, mi sembra, in questo caso, piuttosto grave.

Leggilo subito online o con la nostra App
SCARICA LA COPIA DIGITALE