Una sentenza profondamente ingiusta quella contro le/gli indipendentist@ catalan@, giunta al termine di un processo che due organismi internazionali di verifica, la Fidh (Federazione internazionale diritti umani) e la Euromed Rights (Rete mediterranea diritti umani), hanno giudicato non soddisfare le garanzie necessarie per poterlo considerare giusto.
È stata evitata l’accusa di ribellione, che avrebbe portato anche a 30 anni di reclusione, e, per quanti sforzi si siano fatti per dimostrare che ci fu anche violenza nel disobbedire, troppo evidente è stato il carattere pacifico e non violento di ciò che è avvenuto nel 2017 con il referendum e la dichiarazione di indipendenza. Le condanne dai 13 ai 9 anni per sedizione contro le autorità spagnole e malversazione del denaro pubblico sono decisamente sproporzionate rispetto a ciò che realmente è successo.
A questo esito punitivo puntavano le tre destre spagnole che hanno sempre identificato la dichiarazione unilaterale di indipendenza come un vero e proprio colpo di Stato. Il governo di Barcellona ha bollato la sentenza come «atto di vendetta» e ha chiesto l’amnistia per i leader condannati. Il presidente della Generalitat de Catalunya considera la risoluzione giudiziaria come «un insulto alla democrazia», ha ribadito che la risposta sarà pacifica e ha chiesto una riunione urgente con lo stesso Sánchez e il re Felipe VI.
Ma lo Tsunami Democratico, questo il nome della mobilitazione, è iniziato con il blocco dell’aeroporto, delle strade e delle linee ferroviarie, con il rifiuto assoluto di una sentenza che, delegando ad un tribunale una questione politica, non soddisfa le aspettative di nessuno. Sánchez ripete che la sentenza va rispettata, afferma che la Spagna è una democrazia e che “nessuno viene giudicato per le proprie idee” e si ostina a dire che non prenderà in considerazione un provvedimento di grazia o indulto che sia.
Si può discettare all’infinito sulla credibilità del processo, sulla affidabilità democratica della magistratura spagnola, ma è del tutto evidente che non sarà mai possibile una riconciliazione, né tantomeno una riduzione della spinta popolare verso l’indipendenza catalana dalla Spagna, finché la linea prevalente sarà quella dell’umiliazione e repressione dell’avversario.
Forse ora risulta più chiaro perché i socialisti non abbiano voluto un governo di coalizione con Unidas Podemos. Non c’è stata nessuna guerra di poltrone, ma solo una diversa visione, su come risolvere la crisi catalana e sulle misure con cui affrontare la crisi sociale ed ambientale in cui da anni è sprofondata la Spagna, insieme all’Europa.
Ora la sentenza riporta al centro dello scontro politico la crisi territoriale del Paese, offuscando il resto. Condanne così dure vincolano la crisi catalana nelle dinamiche contrapposte che l’hanno resa ingovernabile: da un lato l’unilateralismo indipendentista, privo di maggioranza sociale e di riconoscimenti internazionali, e dall’altra la totale delega della crisi alla magistratura, con la repressione e l’applicazione dell’articolo 155.
Su questo scenario peseranno moltissimo le elezioni politiche che si terranno il prossimo 10 novembre e la campagna elettorale che le precede. Inoltre c’è il nodo politico che la sentenza solleva ed è la limitazione, di fatto, del diritto a manifestare. Colpendo il gruppo dirigente indipendentista si vuole in realtà criminalizzare un sentimento collettivo che riguarda quasi due milioni di persone in Catalogna che hanno da tempo scelto la linea indipendentista e ad ogni elezione ne ribadiscono le ragioni.
Ma condanne così dure contro un delitto di opinione, il reato di sedizione che ripropone un limite per i diritti di cittadinanza, arrivare a criminalizzare le forme di dissenso, potrebbero valere anche per le/i pensionati che da mesi lottano a Bilbao per i diritti acquisiti, per le femministe che si ribellano al sistema patriarcale che le opprime, per le/gli studenti che reclamano azioni concrete per fermare il cambio climatico che ruba loro il futuro.
Ora serve capacità di proposta per affrontare la questione catalana, ma anche per avviare un dibattito sui limiti della democrazia spagnola che delega la soluzione politica dei conflitti alle derive giustizialiste. I sondaggi pre elettorali confermano i socialisti come primo partito, ma lontani dalla maggioranza assoluta necessaria per un governo monocolore.
Quali alleanze inseguirà Sánchez dopo il voto faranno capire se si andrà verso un possibile condono delle pene oppure, in caso di un sostegno esterno delle destre di Ciudadanos e del PP, a una maggiore intransigenza. Sánchez intende prendere le distanze o rimanere fedele alle scelte che lo riportarono alla guida del suo partito e che determinarono le dimissioni del governo Rajoy?
Certo è che questa sentenza obbliga i socialisti a fare chiarezza. Stare a sinistra, alleandosi con Unidas Podemos, non significa solo battersi per l’indulto, ma riuscire a immaginare e realizzare un modello di convivenza nuovo, una visione dell’unità della Spagna basata sulla plurinazionalità.
Per ora non è questa la scelta dei socialisti. Non basterà a convincerli solo la mobilitazione dello Tsunami Democratico catalano, sarà necessaria anche la forza che esprimerà Unidas Podemos, la sua capacità di mobilitare il Paese dalle strade al voto. Su questo terreno si capirà meglio anche la collocazione di Errejón e del suo Más País.











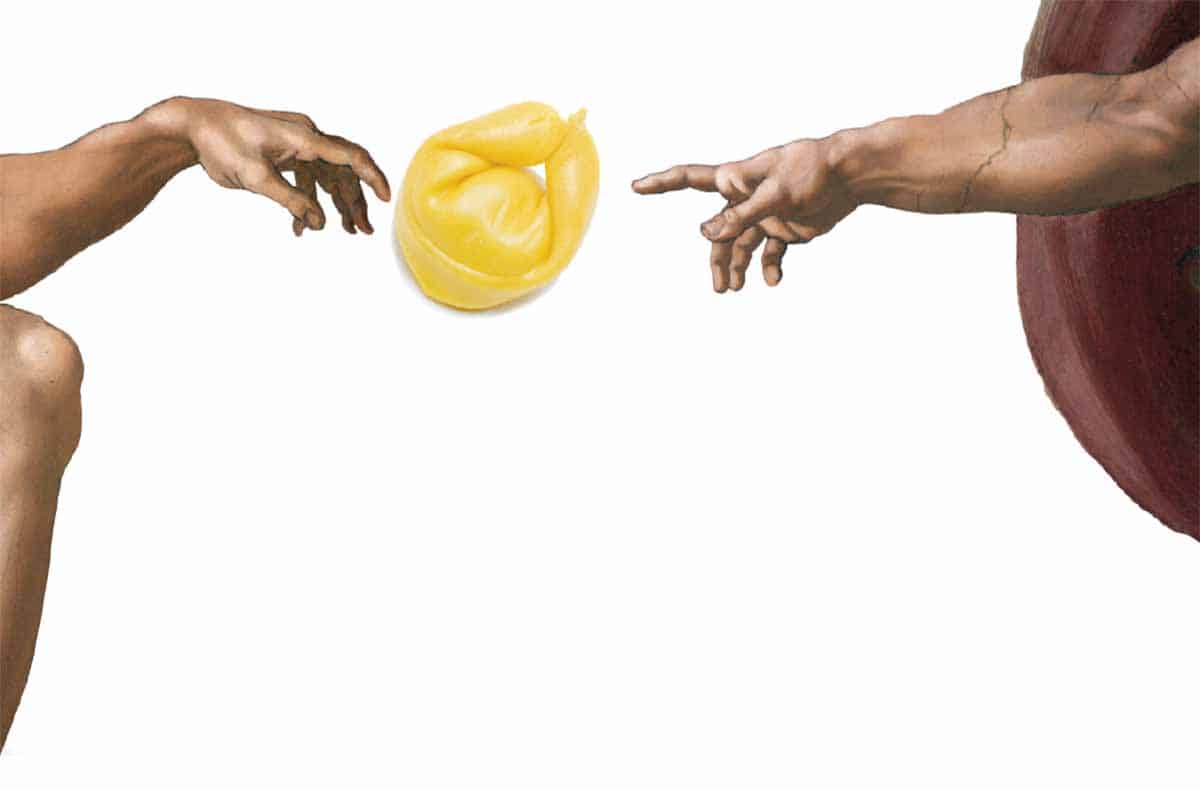


 Marco, che cosa ti ha colpito della storia di Filiz (“Avesta” era il suo nome di battaglia), tanto da decidere di scrivere un libro proprio su di lei e non su un’altra delle molte guerrigliere che conbattono nelle file del PKK curdo?
Marco, che cosa ti ha colpito della storia di Filiz (“Avesta” era il suo nome di battaglia), tanto da decidere di scrivere un libro proprio su di lei e non su un’altra delle molte guerrigliere che conbattono nelle file del PKK curdo?