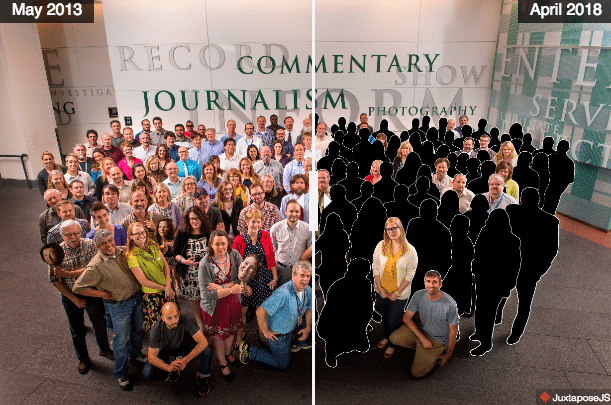“Reati in calo. Meno sbarchi nel 2017”. Diversi giornali l’11 aprile scorso hanno sintetizzato in questo modo alcune frasi pronunciate dal ministro dell’Interno, Marco Minniti, alla cerimonia per i 166 anni della fondazione della polizia di Stato. Si potrebbe pensare a una semplificazione giornalistica ma non lo è. Il ministro ha davvero messo uno accanto all’altro il calo dei crimini e la diminuzione dei flussi migratori dall’Africa attraverso il Mediterraneo. E gran parte della stampa non si è fatta problemi a rilanciare acriticamente il nesso. Contribuendo a far passare il messaggio che i migranti sarebbero una minaccia per la sicurezza degli italiani. Un’idea distorta della realtà che è stata, a vario titolo, il cardine della campagna elettorale di Lega e M5s e che anche il Pd ha cavalcato, pagando con la sconfitta la scelta di scimmiottare le destre. Ma cosa ha detto il ministro?
«Nel 2017 si è registrato il più basso tasso di reati degli ultimi 10 anni, un risultato straordinario che l’Italia farebbe male a dimenticare». E poi ha aggiunto: «Per il decimo mese consecutivo si è registrato un calo degli sbarchi di migranti. Dal 1 luglio a oggi sono arrivate 95.600 persone in meno rispetto al 2016 e si tratta di un colpo straordinario ai trafficanti di esseri umani». Questo appena descritto è solo un esempio di come media e istituzioni da anni contribuiscano a creare una falsa percezione dello straniero nell’opinione pubblica, creando un capro espiatorio (che guarda un po’, non ha diritto di voto) da “sacrificare” nella corsa al potere. Non è un caso che dal 5 marzo scorso la presunta e tanto sbandierata «emergenza immigrazione» sia scomparsa dai radar della politica e dai titoloni dei giornali. Eppure, come raccontiamo in questa storia di copertina, dalla Nigeria, dal Corno d’Africa, dalla Libia e da altri Paesi poveri o in guerra le persone continuano a scappare. Donne, bambini, uomini, che fine fanno? Perché ne arrivano di meno?
«Vorrei che ci liberassimo di una sorta di senso di colpa. Noi non abbiamo il dovere morale di accoglierli, ripetiamocelo. Ma abbiamo il dovere morale di aiutarli. E di aiutarli davvero a casa loro». Questa frase di Matteo Renzi fu prima pubblicata e poi eliminata dalla pagina Facebook del Pd il 7 luglio 2017 sollevando non poche polemiche. «Aiutiamoli a casa loro» era anche lo slogan (di pura matrice colonialista) di Salvini e della Meloni e in quelle parole c’era tutto il senso del cosiddetto «reato di solidarietà» introdotto con il codice di Minniti e dagli accordi con la Libia che di fatto vietano alle Ong di salvare i profughi alla deriva nel Mediterraneo. Noi di Left ci siamo chiesti: ne arrivano di meno perché iniziano a funzionare gli aiuti “a casa loro”? Siamo andati a vedere cosa succede in Nigeria e in Etiopia, due tra i più importanti crocevia africani dei flussi migratori verso l’Europa.
In questi due Paesi l’Eni e la Salini-Impregilo hanno siglato contratti miliardari rispettivamente per l’estrazione di petrolio e la costruzione di dighe. Con quali risultati in termini di ricadute sulle popolazioni locali ce lo raccontano in una lunga e articolata inchiesta Dino Buonaiuto e Luca Manes. Facendo il punto su due processi in corso a Milano che vedono in un caso i vertici dell’Eni imputati per corruzione di un vecchio governo nigeriano e nell’altro il Cane a sei zampe chiamato in solido con una controllata accusata di aver inquinato e non bonificato un’area del delta del Niger vitale per la popolazione indigena degli Ikebiri. Anche nel Paese più sviluppato del Corno d’Africa, la presenza italiana è al centro di un caso. La diga Gibe III, “battezzata” da Renzi nel 2015, ha gradualmente sommerso le coltivazioni e i territori d’allevamento da cui dipendono le tribù della Valle del fiume Omo, e ridurrà drasticamente il livello del Turkana in Kenya, il più grande lago desertico del mondo. Si calcola che circa 500mila persone in Etiopia e in Kenya si troveranno a dover fronteggiare una catastrofe umanitaria.
Torniamo alla nostra domanda: donne, bambini, uomini, che partono dall’Africa che fine fanno? Perché ne arrivano di meno? «La politica dell’Unione europea e dell’Italia in particolare di assistere la guardia costiera libica nell’intercettare e respingere i migranti nel Mediterraneo è disumana. La sofferenza dei migranti detenuti in Libia è un oltraggio alla coscienza dell’umanità». E ancora: «Gli osservatori sono rimasti sconvolti da ciò che hanno visto: migliaia di uomini, donne e bambini emaciati e traumatizzati, ammassati l’uno sull’altro, bloccati in capannoni e spogliati della loro dignità». Sono parole pesanti come macigni quelle che l’alto commissario Onu per i diritti umani (Unhcr) Zeid Raad al-Hussein pronunciò il 14 novembre 2017 puntando indirettamente il dito contro la legge Minniti-Orlando e il «codice Ong».
Dunque, arrivano meno profughi perché finiscono prigionieri e schiavi dei libici con cui lo Stato italiano ha siglato accordi di collaborazione? Stando a quanto detto dal ministro Minniti sempre l’11 aprile alla festa della polizia, non è così. «L’Unhcr lavora in Libia, visita i centri, è innegabile che qualcosa sia cambiata e stia cambiando».
Abbiamo allora chiesto, per completare il quadro, a Marta Bellingreri di raccontare cosa succede oggi nel Mediterraneo a chi riesce a imbarcarsi per tentare di entrare in Europa. E quel che emerge sembra smentire in pieno la versione di Minniti. Del resto qualche sospetto già lo avevamo, avendo raccontato sul Left del 23 marzo scorso la storia di Segen, il giovane eritreo di 21 anni giunto in fin di vita per denutrizione al porto di Pozzallo dopo essere stato detenuto per 18 mesi in uno dei suddetti centri. Purtroppo i medici non hanno potuto far nulla. Segen è morto letteralmente di fame poche ore dopo all’ospedale di Modica. Marta ci ha raccontato che sulla stessa nave Ong che lo aveva raccolto, la Proactiva open arms, c’erano almeno altri 15 giovani nelle sue stesse condizioni.

L’editoriale di Federico Tulli è tratto da Left in edicola
SOMMARIO ACQUISTA