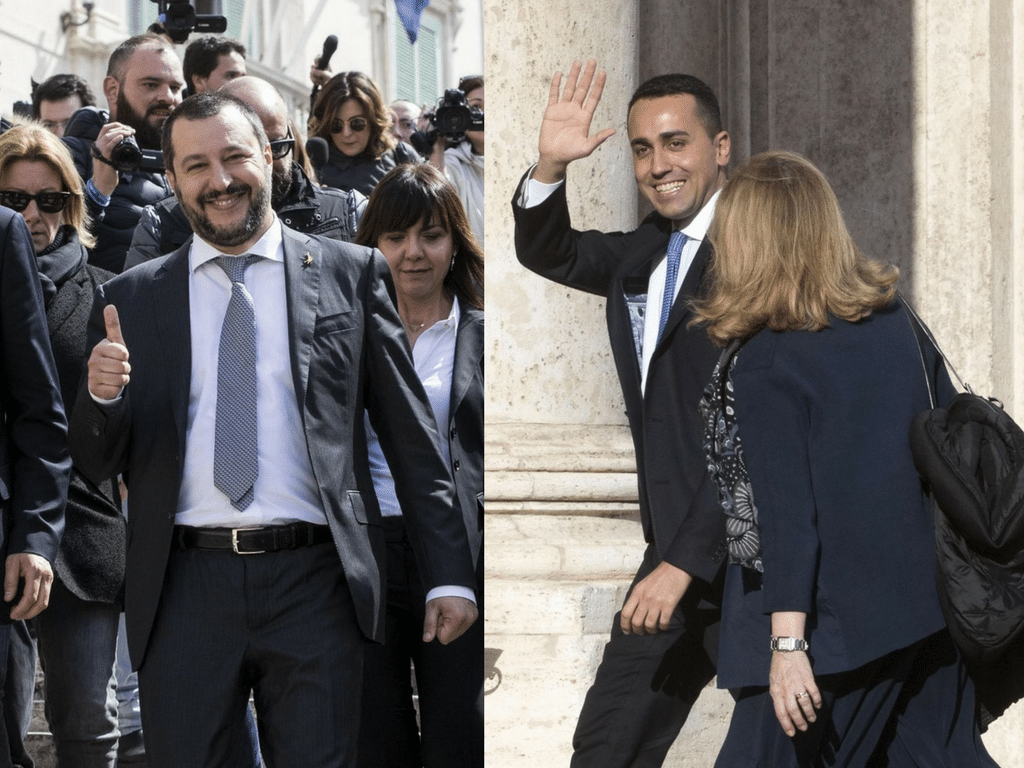Sicurezza. È stata la parola più usata durante la campagna elettorale. Non solo da esponenti del centrodestra leghista e xenofobo. Ma anche dal centrosinistra. Con il ministro dell’Interno Minniti, il governo Gentiloni ne aveva fatto la propria parola d’ordine. Paventando invasioni (inesistenti) di migranti, Lega, Forza Italia, Pd e M5S, all’unisono, hanno sostenuto la necessità di maggiori controlli prospettando soluzioni emergenzialistiche e securitarie. Non uno che abbia usato la parola sicurezza in senso proprio, riguardo alla sicurezza che davvero manca in Italia, quella sul lavoro. Con quali conseguenze lo denunciamo già in copertina attraverso l’opera dell’artista Alessio Ancillai dal titolo Testo unico sulla sicurezza del lavoro con scarpe. Solo nei primi tre mesi del 2018 sono già 151 gli operai che hanno perso la vita sul lavoro. Non chiamatele morti bianche, ci ricorda lo scrittore Marco Rovelli che nel 2008 ha dedicato a questo tema un toccante libro reportage, Lavorare uccide. Non si può parlare di fatalità. Le morti sul lavoro sono omicidi. Le cause sono da cercare nell’accelerazione dei cicli di produzione, in nome della massimizzazione del profitto. Si nascondono in politiche che hanno imposto la flessibilità e la precarietà, attraverso contratti a tempo determinato che ostacolano la formazione perché le aziende in quel caso la considerano una spesa inutile.
Le cause sono da cercare in un sistema industriale italiano che, in tempi di crisi, continua a produrre senza innovazione, con macchinari vecchi, per giunta risparmiando sulla sicurezza, approfittando degli scarsi controlli e del fatto che al più si rischia una multa. Sono pochissimi i casi in cui una denuncia porta all’apertura di un fascicolo e poi al processo. E anche quando si va a processo sono rare le cause vinte dai lavoratori e dai loro familiari. La disoccupazione è un’altra potente arma di ricatto. Chi ha un impiego anche se precario e sotto pagato, cerca di tenerselo stretto, anche accettando turni massacranti. Così chi ha un lavoro povero viene contrapposto a chi ne ha uno ancora più povero; come i migranti costretti a lavorare in nero, fino a condizioni di sfruttamento da schiavitù. Se il lavoratore protesta gli viene risposto che c’è un’intera fila in cerca di un posto come il suo. Così si viene spinti ad accettare condizioni di lavoro sempre più mortificanti, che negano la dignità, che impattano pesantemente sulla vita privata, sulle relazioni sociali, perfino su sogni e aspirazioni.
Pensiamo per esempio ai lavori a chiamata che non permettono di organizzare la propria vita. Oppure pensiamo ai giovani collaboratori delle piattaforme digitali che vengono considerati imprenditori di se stessi e per questo non avrebbero diritto neanche al sempre più fantomatico reddito di cittadinanza. Anche i giornali mainstream hanno riportato con evidenza il progressivo aumento dei morti sul lavoro. Nelle settimane scorse, a Catania due vigili del fuoco, a Livorno due operai, come a Treviglio, e drammaticamente la strage continua. Secondo l’ultima indagine del 2017, il 20% delle vittime sono agricoltori schiacciati dal trattore. Ma a morire più di tutti sul lavoro sono gli edili. Il 10% dei morti sul lavoro sono stranieri mentre il 25% delle vittime ha più di 60 anni. E aumentano anche le persone che preferiscono tacere, e non denunciare gli infortuni. Il quadro dettagliato e sconvolgente lo potete leggere in questo ampio sfoglio di copertina. Ci siamo interrogati sulle cause di questa drammatica e inaccettabile ecatombe ma ci siamo chiesti anche perché oggi prevalga la rassegnazione, che poi, troppo presto, diventa oblio.
Per contrasto torna alla mente il dolore, l’indignazione e l’incazzatura di cui raccontava Luciano Bianciardi dopo l’esplosione nelle miniere di Ribolla nel 1954. La disperazione delle famiglie si accompagnava a una vibrante denuncia da parte degli operai, con la ferma e determinata richiesta di un cambiamento. Dopo lo sciopero passarono all’occupazione dei pozzi della Montecatini. Il 28 giugno 1958 Bianciardi scriveva: «48 operai minacciati di licenziamento rimasero nel pozzo per 3 giorni. La polizia bloccò gli accessi, sperando di prenderli per fame, ma senza risultato. Allora l’azienda decise l’intervento armato, dirigeva le operazioni insieme al vice questore, il direttore della miniera, il dottor Riccardi, commercialista, direttore politico del gruppo delle miniere. Organizza circoli culturali per impiegati e tecnici, e ha istituito il prete di fabbrica, cioè un sacerdote che avvicina gli operai anche in fondo i pozzi e li “rieduca”. Anche il premio di crumiraggio è opera sua». Pretendevano giustamente quegli operai lavoro in condizioni di sicurezza. Allora non c’era la robotizzazione, ma oggi c’è, perché si continuano a mandare gli operai nelle cisterne? Allora non c’era ancora una avanzata legislazione sulla sicurezza, perché oggi non c’è una forte lotta per la sua piena applicazione?
Finita l’epoca fordista, il turbo capitalismo in cui viviamo ha portato con sé una frammentazione, atomizzazione della classe lavoratrice, mentre i sindacati sono stati bypassati da un centrosinistra che ha pensato di poter fare a meno della intermediazione. Basta tutto questo a spiegare l’indifferenza che circonda le morti sul lavoro in Italia? C’è molto su cui interrogarsi, molto da studiare e capire perché non si tratta di numeri ma di persone. Non ci arrendiamo all’idea che nel 2018 non si possa pensare un nuovo modello di società e di sviluppo che non sia basato sullo sfruttamento e sulla negazione dei diritti umani.

L’editoriale di Simona Maggiorelli è tratto da Left in edicola
SOMMARIO ACQUISTA