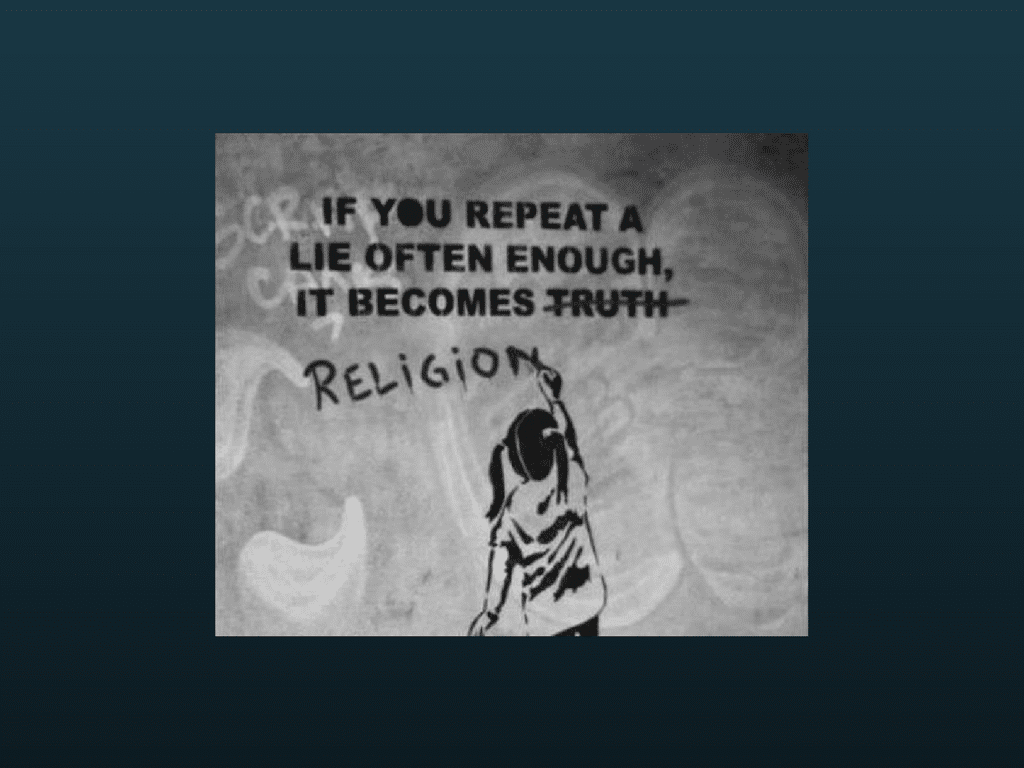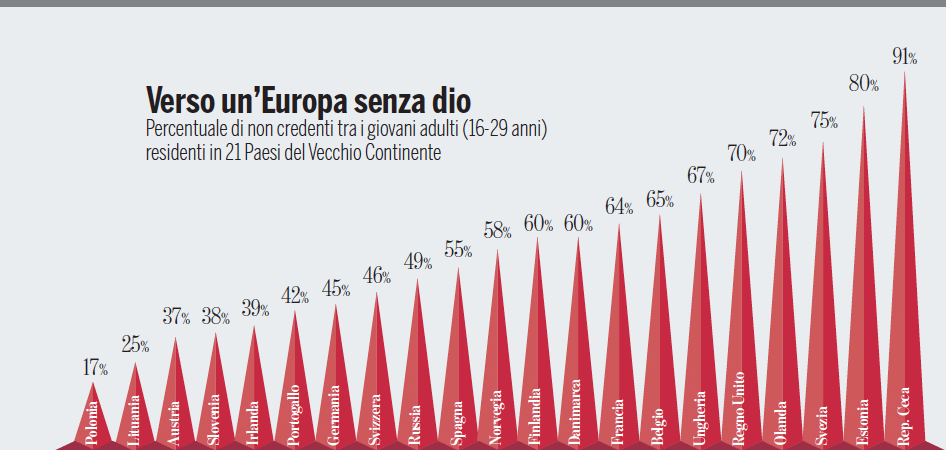Da 42 anni il 30 marzo per noi palestinesi è giorno molto importante perché celebriamo la “Giornata della terra” per ricordare la protesta in Galilea contro la confisca di terra palestinese da parte dello Stato d’Israele che fu soffocata nel sangue con il massacro di 7 palestinesi ed il ferimento di centinaia. D’allora il popolo palestinese in questa data celebra la sua identità ed unità ricordando la sua lotta contro l’occupazione e denunciando i crimini contro la libertà e l’autodeterminazione che Israele purtroppo continua ancora a praticare .
Quest’anno per i palestinesi questo anniversario si colora di un significato particolare perché gli accadimenti degli ultimi e dei prossimi mesi hanno riportato all’attenzione della comunità internazionale la causa palestinese e soprattutto richiedono un necessario rafforzamento della sua lotta .
Infatti, lo scorso 6 dicembre Trump con la sua dichiarazione di riconoscere Gerusalemme capitale d’Israele ha riacceso i riflettori sul dimenticato conflitto israelo-palestinese, oscurato negli ultimi tempi da altri conflitti regionali, facendo un regalo sia al sionismo e agli israeliani ma anche noi palestinesi.
Ha fatto un regalo al sionismo che è da sempre alla ricerca di una legittimazione alle sue aspirazioni di occupare tutta la Palestina facendo di Gerusalemme la capitale eterna dello stato ebraico. Infatti, riconoscere Gerusalemme capitale di Israele significa riconoscere anche l’annessione degli insediamenti israeliani nei pressi di Gerusalemme e quindi anche l’annessine degli altri insediamenti israeliani nell’intera Cisgiordania nonostante siano giustamente considerati illegali dalla comunità internazionale in quanto sono una aperta violazione della IV Convenzione di Ginevra che vieta alla potenza occupante di trasferire parte della sua popolazione nel territorio occupato. Ma se Israele si annette Gerusalemme che da sola rappresenta un terzo dell’intera Cisgiordania ed i territori espropriati per la costruzione di insediamenti nella restante Cisgiordania, vuol dire nella ripresa di una futura trattativa ai noi palestinesi verrebbe concesso ben poco e di fatto verrebbe cancellata l’idea della costituzione di due Stati così come disegnata con la risoluzione 181.
Tutto ciò non è fantapolitica ma purtroppo sono previsioni molto attendibili dal momento che il primo gennaio il Likud (partito del primo ministro israeliano Netanyahu) ho votato quasi all’unanimità (1499 voti favorevoli contro 1) un documento che impegna i deputati del Likud a far approvare dal parlamento israeliano (knesset) una legge sull’annessione allo stato ebraico degli insediamenti in Cisgiordania, che sicuramente potrà contare anche sull’appoggio del partito di estrema destra xenofobo Baituna e dei partiti religiosi che rappresentano la lobby dei coloni.
La dichiarazione di Trump è stato un regalo al sionismo anche perché contribuisce far accettare dall’opinione pubblica internazionale come un dato di fatto che Gerusalemme è la capitale d’Israele, per cui se è riconosciuta come tale dagli Stati Uniti dovrebbe essere normale anche per gli altri Paesi riconoscerla e trasferirvi le loro ambasciate.
Inoltre, la dichiarazione di Trump è stato un regalo personale a Netanyahu, da mesi sotto incessante pressione da parte della magistratura perché accusato di corruzione e che lo scorso luglio aveva subito una pesante sconfitta politica e di immagine con la vittoriosa protesta dei palestinesi di Gerusalemme Est che sono riusciti ad ottenere la rimozione dei metal detector dagli ingressi della moschea di Al Aqsa. Grazie all’inatteso regalo di Trump Netanyahu può così tirare un sospiro di sollievo e restare alla guida di una coalizione che lo sta portando sempre più a destra.
Ma la dichiarazione di Trump ha contribuito a fare chiarezza, cioè con questa dichiarazione gli Stati Uniti sono usciti allo scoperto, hanno dimostrato a tutti la loro vera faccia, cioè quella di mediatori di parte nel processo negoziale, e lo hanno dimostrato anche a quei palestinesi che avevano creduto al processo di pace a guida Usa. Questa dichiarazione di Trump dimostra che gli Stati Uniti in tutti questi anni non hanno mai svolto il ruolo di mediatori imparziali, bensì quello di sponsor della politica colonizzazione e di occupazione di Israele, e come è stato detto da qualcuno, «di avvocati difensori d’Israele».
Non dimentichiamo che il congresso Usa aveva dato mandato al presidente Bill Clinton di farsi sponsor degli accordi di Oslo e che è lo stesso Clinton ad intavolare in mondo visione la sceneggiata della firma ufficiale degli accordi nel cortile della Casa Bianca il 13 settembre 1993 con un sorridente Arafat che stringe la mano di un riluttante Rabin consegnando alla storia una delle immagini più significative del novecento.
Ma è sempre Clinton che appena due anni dopo, l’8 novembre 1995 (dimenticando che Gerusalemme, secondo gli accordi di Oslo del 1993 doveva essere oggetto di futuri negoziati insieme ad altre questioni spinose quali quella dei profughi, e, secondo la risoluzione 181 del 1947 , che prevede la costituzione di uno stato ebraico accanto ad uno stato palestinese, doveva costituire un corpus separatum sotto il controllo internazionale), firma il cosiddetto Jerusalemm Embassy Act approvato dal Congresso con il quale , sostanzialmente, gli USA riconoscono di fatto, con un abile esercizio retorico, Gerusalemme come capitale di Israele («The United States conducts official meetings and other business in the city of Jerusalem in de facto recognition of its status as the capital of Israel») e prevedono il trasferimento dell’ambasciata consentendo però di rinviare la decisione sullo spostamento effettivo ogni sei mesi per «interessi di sicurezza nazionale» e così è avvenuto per 22 anni fino alla dichiarazione di Trump dello scorso 6 dicembre 2017.
La dichiarazione di Trump, sebbene illegittima ed inopportuna, ha avuto il merito di fare aprire gli occhi alla dirigenza palestinese e ai suoi sostenitori e riconoscere il fallimento di Oslo. Si è trattato, però, di un riconoscimento tardivo perché oramai gli accordi di Oslo sono un cadavere putrefatto, o meglio sono già nati morti perché sono stati una svendita dei diritti di libertà ed autodeterminazione del popolo palestinese, accettando il principio non del rispetto del diritto internazionale ma della trattativa con il soggetto più forte, lo stato d’Israele, che non poteva che imporre le sue condizioni.
Altro indiscusso merito della dichiarazione di Trump è stato quello di riaccendere la protesta popolare, dentro e fuori la Palestina occupata e della solidarietà internazionale, con le tante manifestazioni che si sono avute non solo nei territori palestinesi occupati ma anche nei Paesi arabi, Islamici ed in occidente.
Trump ha giustificato la sua dichiarazione dicendo che questa si limita a riconoscere “una realtà di fatto” dimenticando di dire che questa realtà è stata creata anche con il sostegno complice delle varie amministrazioni americane (da Clinton ad Obama fino ad arrivare a Trump) alla politica di occupazione israeliana, sostegno fornito non solo in termini di finanziamenti ma anche in termini di veto Usa contro la risoluzioni Onu di condanna di Israele.
Di fronte a questa realtà mentre Trump preme sull’acceleratore ricorrendo non solo alla diplomazia ufficiale ma anche ad una diplomazia di tipo casereccio affidando al genero Jared Kushner il compito di andare nei vari Paesi arabi per raggiungere un “accordo estremo” per Israele-Palestina e quindi creare una potente coalizione anti Iran con al centro Israele, Usa ed Arabia Saudita (particolarmente fruttuosi sono i contatti che Kushner sta avendo con il suo nuovo amico del cuore, il principe ereditario saudita Mohamed bin Salman), la dirigenza palestinese sembra guadagnare tempo, andando alla ricerca di consensi ed appoggi alla causa palestinese in mezzo mondo ed anche presso l’Onu.
Infatti, mentre a dicembre si parlava del trasferimento della ambasciata israeliana entro il 2019, a metà febbraio è arrivato l’annuncio dell’apertura il 14 maggio di una sede provvisoria nella struttura che attualmente ospita il consolato americano a Gerusalemme Ovest.
I motivi di questa accelerazione sono da ricercarsi non solo nella necessità di non sfarsi sfuggire una occasione simbolica dal momento che quest’anno la data del 14 maggio ricorderà 70 anni dalla proclamazione dello stato d’Israele che invece i palestinese considerano come la loro “Nakba” (catastrofe), ma anche nei finanziamenti messi a disposizione dal miliardario israelo-americano Sheldon Adelson, e, soprattutto, per motivi strategico-politici in quanto si dice che sia a breve la presentazione del cosiddetto “accordo del secolo” tra israeliani e palestinesi, cioè il piano di pace della Casa Bianca.
L’ambasciatrice Usa all’Onu Nikky Aley ha detto che questo «piano non sarà amato da entrambe le parti e non sarà odiato da entrambi le parti». Parole molto vaghe ma sicuramente il riconoscimento di Gerusalemme come capitale d’Israele attribuisce agli israeliani un’arma in più nella futura contrattazione con i palestinesi, soprattutto se entrerà in gioco il fattore tempo (come è avvenuto per Oslo con trattative rimandate all’infinito), cioè se passa del tempo ed altri Paesi vi trasferiscono le loro ambasciate oltre agli Stati Uniti mentre Gerusalemme sarà accettata come dato di fatto come capitale d’Israele, questo, invece, sarà un incubo per i palestinesi dal quale sarà difficile uscirne per il principio che se si accetta il grosso, la perdita di Gerusalemme , perché non accettare il piccolo, l’annessione degli insediamenti in Cisgiordania. Sarà un incubo per i palestinesi soprattutto se verrà offerto loro il principio della compensazione dei territori, cioè al posto di Gerusalemme e degli insediamenti in Cisgiordania la costituzione di uno stato palestinese a Gaza, secondo la proposta del nuovo segretario della difesa nazionale Jhon Bolton, appena nominato da Trump.
L’“accordo del secolo” del presidente nordamericano nasce dall’esigenza di tutelare gli interessi strategici ed economici principalmente di Arabia Saudita, Stati Uniti ed Israele le cui diplomazie da mesi si sono messe in moto per costruire un fronte comune anti Iran.
Infatti, l’Arabia Saudita dell’ambizioso e spregiudicato principe ereditario Mohamed bin Salman vuole sempre più affermarsi non solo come unico punto di riferimento per il mondo islamico ma anche come moderna potenza economica. Lo scorso ottobre Mohamed bin Salam ha presentato il progetto Neom, un futuristico programma di rinnovamento dell’economia saudita che mira a garantirne la sopravvivenza anche dopo l’era dell’oro nero, puntando sulle energie alternative, sulle biotecnologie, sulle scienze tecnologiche e digitali. Il progetto Neom prevede investimenti per 500 miliardi per la costruzione di un gigantesco polo industriale sulle sponde del Mar Rosso, nei pressi del Golfo di Aqaba. Solo una parte degli investimenti (230 miliardi) è coperta dal Fondo Pubblico di investimenti saudita, gli altri dovrebbero provenire da investitori stranieri e si sa che i grossi investitori a livello internazionale sono in qualche modo legati ad Israele.
Gli Stati Uniti, già presenti nell’area con numerosi soldati in Siria, Iraq e Libano e basi militari nei Paesi del Golfo, voglio rafforzare e legittimare la loro presenza anche per contrastare il sempre maggiore ruolo che sta avendo la Russia in Medio Oriente. Vogliono inoltre soddisfare i loro interessi economici basti pensare che in occasione del viaggio di Trump in Arabia Saudita dello scorso maggio l’America si è impegnata a vendere armamenti per 350 miliardi in 10 anni (100 subito e gli altri a seguire).
Israele, invece, potenza occupante ma anche potenza nucleare, non accetta non solo chiunque osi criticare e condannare la sua politica di occupazione ma anche non accetta un’altra potenza rivale … L’Iran non è mai stato morbido nei confronti di Israele che ha bocciato l’accordo sul programma nucleare iraniano firmato a Vienna il 14 luglio 2015, dopo più di 10 anni di trattative, da Theran e dal cosiddetto “5+1” cioè i Paesi membri del consiglio di Sicurezza con diritto di veto (Usa, Russia, Cina, Francia e Regno Unito) più la Germania, dimenticando che il programma nucleare israeliano non è sottoposto a nessuna forma di controllo nonostante già da anni Israele sia in possesso della bomba atomica. La bocciatura dell’accordo sul programma nucleare iraniano da parte di Israele è avvenuta fin dall’inizio ed ora, insieme alle potenti lobby ebraiche nordamericane che hanno sostenuto e sostengono Trump, preme sull’amministrazione statunitense affinché faccia altrettanto.
Dunque, Arabia saudita, Stati Uniti ed Israele per soddisfare i loro rispettivi interessi strategici ed economici hanno deciso di creare un fronte comune contro l’Iran cercando di coinvolgere però anche altri Paesi della regione (Egitto, Giordania, Paesi del Golfo). E per raggiungere questo obiettivo l’unica strada percorribile è la normalizzazione dei rapporti con Israele sapendo che tre cose gli israeliani non sono disposti ad accettare, cioè 1) la costituzione di uno Stato palestinese in Cisgiordania accanto ad Israele e di più con Gerusalemme Est capitale; 2) lo status di corpus separatum sotto il controllo internazionale di Gerusalemme perché vogliono eliminare qualsiasi traccia di non appartenenza; 3) il ritorno dei profughi perché temono lo scoppio della cosiddetta bomba demografica palestinese.
Trump queste cose le conosce bene, ecco perché ha fatto la sua dichiarazione il 6 dicembre regalando Gerusalemme agli israeliani e successivamente ha prima minacciato di tagliare gli aiuti USA all’agenzia Onu (Unrwa) che assiste i profughi palestinesi poi li ha dimezzati perché non dare più soldi ai profughi palestinesi significa non riconoscere più loro lo status di profughi e quindi titolari di quel famoso diritto di ritorno riconosciuto invece dalla risoluzione 194 del 1948 dell’Assemblea generale dell’Onu. In questa ottica va letta la proposta americana, sostenuta da Israele, di sostituire l’Unrwa, agenzia appositamente istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1948 per i profughi palestinesi, con l’Unhcr cioè l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, il che significherebbe equiparare i profughi palestinesi a tutti gli altri profughi, quindi scavalcare la risoluzione 194 e il diritto dei profughi palestinesi.
Trump sa che per favorire il processo di normalizzazione tra Israele ed i Paesi arabi occorre rimuovere l’ostacolo più spinoso, cioè la questione palestinese. Ecco perché per il presidente Usa l’importante non è la soluzione a due o uno Stato ma la soluzione ed ecco perché sta elaborando il suo cosiddetto “accordo del secolo”.
Per realizzare questo accordo del secolo Trump si sta circondando di uomini che condividono il suo pensiero, e per certi versi lo superano e lo esprimono senza pudore. Infatti (il 23 marzo) ha nominato come nuovo responsabile per la sicurezza nazionale John Bolton al posto del generale McMaster che in questi mesi di presidenza Trump aveva cercato, insieme al capo dello staff John Kelly e del Pentagono James Matthis, entrambi già sostituiti, di tenere a freno le mire guerrafondaie del presidente preferendo la via diplomatica per la soluzione delle varie crisi. Bolton, invece, è considerato un falco duro e puro, infatti, ha progettato la guerra all’Iraq quando era ambasciatore Usa all’Onu sotto la presidenza di George Bush, ed ora si è schierato apertamente per una guerra preventiva contro la Corea del Nord ed ha definito «un furto» l’accordo sul nucleare iraniano voluto da Obama. Per cui, secondo Bolton, gli Stati Uniti devono abbandonare l’accordo, reimpostare le sanzioni economiche contro l’Iran e rovesciare il regime di Theran. E sicuramente quando Trump il 9 aprile dovrà decidere se rinnovare o meno la firma all’accordo farà sentire la sua voce. Anche per quanto riguarda la questione palestinese Bolton si è già espresso ed in modo molto chiaro. Secondo Bolton, la soluzione a due Stati è morta, opinione condivisa anche dal nuovo capo del Pentagono Mike Pompeo e da tantissimi altri ma Bolton è andato oltre esprimendo la sua opinione per quanto riguarda la soluzione della questione palestinese, che secondo lui sarebbe un espediente di cui si servono i nemici di Israele, per minacciare la sua sicurezza. Per Bolton la soluzione è quella a tre Stati, cioè ovviamente Israele, Gaza che passerebbe all’Egitto e la West Bank (Cisgiordania) tornerebbe a far parte della Giordania, esclusi tre grossi blocchi di insediamenti che rientrerebbero nei confini dello Stato ebraico.
La soluzione di Bolton non prende minimamente in considerazione la posizione dell’Egitto né quella della Giordania che non l’hanno accolta con entusiasmo in quanto presi dai loro problemi interni dovuti anche alla presenza di numerosi profughi palestinesi. Ma soprattutto non prende in considerazione i diritti del popolo palestinese, la sua aspirazione ad avere Gerusalemme come sua capitale, il diritto dei palestinesi ad avere uno Stato riconosciuto dalla famosa risoluzione Onu 181 votata anche dagli Stati Uniti.
Prima di Bolton, Trump per poter portare avanti il suo piano di pace, l’accordo del secolo, il 13 marzo ha licenziato via twitter il segretario di stato Rex Tillerson per nominare al suo posto il capo della CIA Mike Pompeo. «Siamo in disaccordo su tutto» si è giustificato Trump. Verissimo ma soprattutto perché Tillerson l’estate scorsa aveva raggiunto un accordo con il Qatar sul terrorismo internazionale di matrice islamica e sulle sue fonti di finanziamento suscitando l’ira dell’Arabia Saudita che invece accusava l’emiro del Qatar di appoggiare Hamas ed i Fratelli Musulmani e di aver descritto l’Iran come “potenza islamica”, cosa inaccettabile per il credo wahabita di Riad per il quale lo sciismo di Teheran è una sorta di peccato di apostasia e soprattutto perché la monarchia saudita è sempre più preoccupata dell’affermarsi del Qatar come potenza economica con il più grande giacimento di gas al mondo ed è preoccupata dei rapporti dell’emirato qatariota con l’Iran. Quindi il licenziamento di Tillerson va letto in questa ottica, cioè come regalo di Trump all’Arabia Saudita che si sta proponendo come rappresentante degli interessi strategici ed economici americani nella regione, affiancandosi quindi ad Israele in questo suo ruolo e questo lo si era capito già con l’accordo sulla vendita di armi dello scorso maggio, che è sembrato a tutti essere un accordo di più ampio respiro, una specie di investitura della leadership saudita come capofila del processo di normalizzazione dei rapporti con Israele in chiave anti iraniana voluto e sostenuto da Trump perché considerato strumentale per realizzazione dell’accordo del secolo.
Trump dunque sta preparando il terreno per la realizzazione del suo piano, infatti, dopo il suo viaggio in Medio Oriente dello scorso maggio, ha inviato nella regione suo genero Jared Kushner e il segretario James Mattis, e, in questi giorni è in ancora in atto la visita in America del principe ereditario saudita Mohammed Bin Salman e sono in calendario anche le visite del presidente egiziano Al Sisi e del re giordano Abdullah II e degli emiri dei Pesi del Golfo, tutti in sorta di pellegrinaggio a Washington alla ricerca della benedizione Usa.
L’Arabia Saudita vuole avere la benedizione nordamericana non solo per la sua politica estera ma anche per quella interna in quanto l’appoggio Usa permettere di oscurare la sanguinosa guerra saudita contro lo Yemen e la continua violazione dei diritti umani (ogni giorno l’aviazione di Riad bombarda ripetutamente il Paese yemenita, un Paese poverissimo, oramai ridotto all’estremo dove la gente muore perché non riesce a curarsi neanche una banale gastroenterite e per mancanza di viveri). Inoltre, l’appoggio americano alla guerra alla corruzione e all’ammodernamento della società saudita (ad esempio con il permesso finalmente riconosciuto alle donne di guidare o quello riconosciuto ai giovani, uomini e donne, di partecipare insieme a concerti) permette all’ambizioso e spregiudicato principe Bin Salman, da un lato, di sbarazzarsi in modo indolore dell’opposizione interna e, dall’altro, di guadagnarsi il consenso non solo delle nuove generazione ma anche delle frange più reazionarie della società saudita non indifferente però alla tutela dei propri interessi economici (se l’ammodernamento della società è il prezzo che si deve pagare per fare affari con gli americani che ben venga). Queste sono le cose che stanno a cuore a Bin Salman, ecco perché finora nei suoi vari incontri con diversi personaggi dell’amministrazione Trump e nelle varie conferenze non c’è stato nessun accenno alla questione di Gerusalemme, al riconoscimento americano dello scorso 6 dicembre di capitale di Israele.
Gli emiri dei Paesi del Golfo a loro volta andranno a Washington alla ricerca della benedizione americana per tutelare la loro posizione di potenze economiche e partner strategici in quando sedi di importanti basi militari americane, contro le mire egemoniche di Bin Salman che aspira a fare dell’Arabia Saudita con il suo futuristico progetto Neom l’unica superpotenza della zona. Pertanto anche per gli emiri dei Paesi del Golfo il ricevimento alla Casa Bianca sarà un’occasione per rinnovare alleanze e stringere nuovi accordi economici, non certo per discutere di Gerusalemme e sostenere le legittime rivendicazioni dei palestinesi.
Più delicata è la posizione del presidente egiziano Al Sisi e di re giordano Abdullah II in quanto più direttamente coinvolti con migliaia di profughi palestinesi che oramai fanno parte integrante delle loro rispettive popolazioni, pertanto sicuramente nel loro prossimo viaggio a Washington non potranno ignorare la questione palestinese alla luce del fatto che i loro Paesi sopportano il peso anche economico di questa situazione e alle luce anche del proposta di soluzione a tre Stati di Bolton. Sicuramente questi due Paesi, Egitto e Giordania, chiederanno e riceveranno aiuti e finanziamenti per fare tirare un sospiro alle loro povere economie, ma sicuramente gli aiuti ed i finanziamenti americani avranno un costo, cioè acconsentire alle richieste americane per la realizzazione dell’accordo del secolo.
Ecco perché Abbas prima che questo avvenga deve confermare, in modo netto e deciso, il suo no categorico all’accordo del secolo e chiamare in causa solo l’Onu affinché decida alla luce del diritto internazionale non solo su Gerusalemme ma sull’intera questione palestinese, condizionando così le posizioni degli altri Paesi arabi.
Allo stato attuale non si conosce nei dettagli la proposta del secolo americana ma molto probabilmente essa prevede che Israele fermi la costruzione di nuovi insediamenti in nuovi territori, ma questo non significa che Israele non possa migliorare e/o aumentare gli insediamenti già esistenti, e questo sarà una sorta di legittimazione dei vecchi insediamenti. Inoltre, si prevede che Israele restituisca alcuni territori della Cisgiordania. Nello specifico si parla dei territori rientranti nella cosiddetta area A (che rappresenta l’8% dell’intera Cisgiordania) ed area B (che rappresenta il 20% della Cisgiordania) al netto di Gerusalemme che gli Israeliani vogliono come capitale. Quindi al massimo ai palestinesi sarà restituito il 28% della Cisgiordania perché l’area C (che corrisponde al 72% della Cisgiordania) è già completamente sotto il controllo israeliano sia dal punto di vista amministrativo sia dal punto di vista della sicurezza, così come previsto dagli accordi di pace di Oslo, all’epoca di Arafat, prima della seconda Intifada. Oggi, invece, tutti i territori palestinesi sono, dal punto di vista della sicurezza, sotto il controllo israeliano, per questo Abbas nel suo discorso all’Onu ha detto che l’Anp è una «autorità senza authority, e i palestinesi lavorano per gli israeliani».
Ma se le cose stanno così la politica dilatoria intrapresa dall’Anp dopo la dichiarazione di Trump fa il gioco israeliano ed americano. Infatti, Abu Mazen partecipando al vertice straordinario dei Paesi della cooperazione islamica (Oic), convocato il 13 dicembre ad Istambul da Erdogan che ha condannato la decisione «pericolosa», «illegale» ed «illegittima» di Trump, ha sostenuto che «d’ora in poi i palestinesi non accetteranno più alcun ruolo di mediazione degli Usa nel processo di pace in Medio Oriente».
Questo concetto è stato espresso anche nel corso del Consiglio centrale palestinese (14 gennaio) dove Abu Mazen ha affermato che «gli israeliani hanno ucciso gli accordi di Oslo, perciò Oslo è finito». Di qui la necessità di fermare la collaborazione per quanto riguarda i coordinamento di sicurezza previsto appunto dagli accordi di Oslo .
Dopo la riunione del consiglio Centrale palestinese Abbas ha partecipato in Egitto alla conferenza di Al Azhar (17 gennaio) dopo di che, il 20 febbraio, ha tenuto un discorso al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nel corso del quale ha chiesto che si organizzi una conferenza di pace per il Medio oriente entro la metà del 2018 con il compito di stabilire un meccanismo internazionale multilaterale che possa risolvere la questione palestinese.
Poi Abbas è andato presso i singoli Paesi europei ma nessuno di questi Paesi si è proposto come mediatore. Nessuno cioè ha detto di sì ma neanche nessuno ha detto no, perché nessuno di questi Paesi può fare pressione su Israele in quanto privi degli strumenti per fare pressione (come i finanziamenti delle potenti lobby ebraiche americane) e nessun Paese può fare da mediatore senza il consenso degli americani.
Trump non si muove neanche di una virgola dalla sua decisione anzi la rafforza con la decisione di inaugurare il 14 maggio l’apertura dell’ambasciata a Gerusalemme.
Abu Mazen, invece, sembra prendere e soprattutto perdere tempo, nella speranza forse che gli americani cambino qualche cosa, probabile che Trump per accontentare Abbas accetti la partecipazione di altri mediatori a condizione però che gli USA siano determinanti nella scelta di altri mediatori. Ma in confronto il sovrano non sarà più la legittimità internazionale ma la trattativa nella quale prevarrà una sola legge, cioè la legge del più forte, cioè Israele.
Per noi palestinesi, invece, per la difesa dei nostri diritti, in difesa di Gerusalemme e di tutta la sua terra illegittimamente occupata e devasta, senza perdere tempo, si dovrebbe:
- Chiedere la cancellazione di Oslo e di tutti i suoi effetti,
- Fare assumere ad Israele la responsabilità di gestire i territori occupati,
- Rinviare l’intero fascicolo della causa palestinese all’Onu affinché venga affrontato dall’Onu alla luce del diritto internazionale,
- Organizzare una conferenza internazionale per far si che decidano tutti i soggetti internazionali alla luce del diritto internazionale,
- No a trattative dirette e al ruolo di unico mediatore degli Stati Uniti.