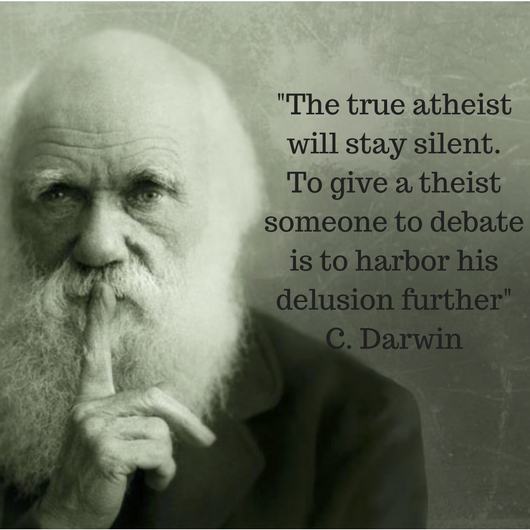Marco Revelli spiega le origini del populismo e analizza i tre populismi italiani (Berlusconi, Grillo e Renzi)
Marine Le Pen e Emanuel Macron, i due sfidanti alla presidenza della Repubblica francese sono populisti, in forma diversa, ma populisti. E mentre i due volano verso il ballottaggio del 7 maggio, i partiti tradizionali si sfaldano e la sinistra non ce la fa a proporre ai cittadini delusi una propria visione del mondo. Le notizie dalla Francia confermano le tesi sostenute da Marco Revelli nel suo ultimo libro, Populismo 2.0 (Einaudi), una analisi che permette di «tracciare confini concettuali e cronologici» di un fenomeno mai stato così esteso. Di questio Revelli parla il 7 settembre al festival Con-Vivere a Carrara
Intanto, Marco Revelli, per fare chiarezza, quali sono gli elementi che caratterizzano il populismo?
Credo che possano essere tre gli indicatori, direbbero i chimici, del populismo. In primo luogo, l’orizzontalità del taglio che crea la discriminazione. Cioè il populismo è sempre un basso contro l’alto, che taglia trasversalmente il cosmo politico senza differenze culturali o ideologiche e che tende a rappresentare un popolo contro una élite o una oligarchia o un piccolo gruppo di usurpatori. Questo è il primo elemento che ha come corollario il “né di destra né di sinistra”. Il secondo aspetto è un atteggiamento “morale”: questa distinzione trasversale corrisponde in termini un po’ manichei a un bene contro il male. Da una parte sta il bene: l’onestà, il patriottismo, per certi versi, una comunità che si riconosce nella propria identità mentre dall’altra parte c’è il male: i traditori, gli stranieri, gli usurpatori. Il terzo elemento è la personalizzazione. I populismi devono costruirsi una figura nella quale identificarsi per transfert, un capo più o meno carismatico.
Usi il termine al plurale, perché?
Il termine populismo dice tutto e dice niente. È un gravissimo errore trattare il populismo come se fosse una forma politica tradizionale, un ismo come erano gli ismi novecenteschi, il comunismo, il socialismo, il fascismo e così via, cioè una forma politica strutturata in movimento o partito con una identità di cultura politica stabile. Non è questo. È uno stile, un atteggiamento, un mood, rispetto al quale pensare di confrontarsi da partito a partito o da soggetto politico a soggetto politico, non fa altro che portare acqua al populismo. La polemica che sia i partiti che i media mainstream fanno contro il populismo, senza accorgersene, sono tutti spot a favore. La sintesi di questo errore è averlo definito antipolitica. Questo termine mostra tutta la coda di paglia di chi l’ha usato, perché in realtà è una forma della politica, anzi oserei dire, è la forma che la politica assume oggi.
Allora esaminiamo la portata del fenomeno. Vediamo oggi un Trump che affonda le sue origini nel People’s Party di fine Ottocento, poi la Brexit, Le Pen, Orban e il gruppo di Visegrad… Si può dire che il populismo non era mai stato un fenomeno così esteso come nell’ultimo secolo?
Sì, nel senso che questo stile politico, questo mood, dilaga in tutto l’Occidente delle democrazie mature. È un sintomo, come la febbre lo è di una infezione, di una malattia grave della democrazia matura. Il populismo esprime un disagio della democrazia. Prima, come malattia infantile, quando la democrazia non rappresentava tutto il popolo e quindi il populismo rappresentava il desiderio degli esclusi di partecipare. Oggi invece è una malattia senile della rappresentanza, perché quelli che erano inclusi e spesso che erano anche il baricentro dei sistemi democratici e ne garantivano il fattore di stabilità – il ceto medio e un pezzo del mondo del lavoro – ora si sentono messi al margine perché le decisioni vengono prese fuori dai meccanismi delle istituzioni democratiche, cioè dalle tecnocrazie, dai mercati, ecc. Gli esclusi avvertono che il loro voto non conta più niente, per cui si esprimono con il rifiuto e con l’astensione – che i politologi chiamano exit – oppure, se continuano a star dentro, votano per far male a quelli che a loro parere li hanno traditi. Il voto populista è un voto di vendetta, il voto anti estabilishment.
Nel tuo libro con le mappe dimostri che c’è una perfetta sovrapposizione tra coloro che hanno votato per Trump e per il Leave della Brexit e quei cittadini che si sono sentiti deprivati dalla politica e dalla sinistra, in particolare. Che cosa ha determinato l’abbandono da parte della sinistra: l’incapacità, l’obbedienza alle regole del mercato, perdendo la sua capacità trasformativa per abbracciare una posizione conservativa?
È il punto centrale del libro. La sinistra è il vero convitato di pietra di tutto questo discorso. Il fenomeno è trasversale in tutto l’Occidente, passa come uno tsunami dalla West Coast americana verso Oriente, dall’Inghilterra della Brexit alla Francia e all’Italia arrivando fino all’Ungheria e anche alla Turchia. Questa grande “livella” che sta attraversando l’Occidente e che sconvolge gli schieramenti politici, passa come una lama di un aratro dentro i partiti consolidati e rinvia a un grande vuoto lasciato nella politica, quello a sinistra. Quella forza, in forme molto diverse dagli Stati Uniti all’Europa, rappresentava la tutela del mondo del lavoro e degli strati più deboli della società promuovendo diritti, reddito, politiche economiche di redistribuzione, sistemi sanitari nazionali ma anche cultura, identità dignità, organizzazione del lavoro. Tutto questo è scomparso lasciando un gigantesco vuoto e in politica come in natura non può esistere il vuoto, c’è subito qualcuno che lo riempie. Il populismo è la forma informe che assume il vuoto lasciato dalla sinistra.
Ma perché è accaduto?
Perché le élite, le sue rappresentanze, le sue forme organizzate sono passate dall’altra parte, cioè da chi stava in alto, non da chi stava in basso. Questo lo si è visto a cominciare dall’apologia della globalizzazione di cui è stato presentato solo un volto illusorio e ottimistico, facendola passare come redistribuzione globale della ricchezza. Invece era concentrazione in alto su ogni scala nazionale, della ricchezza di pochi privilegiati e al tempo stesso lo scivolamento verso il basso, di buona parte della società, del ceto medio e del mondo del lavoro che è rimasto ai margini. Trump non è stato votato dai poveri – anche perché i poveri in America non vanno a votare – ma dagli impoveriti della upper class fino ad arrivare alla old working class, alla vecchia classe operaia, i minatori del Kentuky, i lavoratori del West Virginia che la globalizzazione e la delocalizzazione ha impoverito, che odiano la green economy sposata dai “fighetti” del partito democratico della East Coast di Boston. Sono quelli che avevano sempre votato democratico, facendo eleggere Bill Clinton e Obama e adesso hanno votato Trump, il peggiore dei miliardari, figlio di un immobiliarista corruttore che ha vissuto di rendita. È uno degli uomini più ricchi d’America, in cui però si sono identificati per la rozzezza stessa del linguaggio e perché era inviso ai salotti buoni e alla stampa di Washington. L’hanno votato con un voto di vendetta, sapendo, come ha detto uno in una intervista che “Trump è uno stronzo” ma che gliele canterà ai fighetti, alla palude di Washington. La stessa cosa è successa con la Brexit, la mappe del voto lo dicono. Hanno votato il Remain gli appartenenti agli strati fast, quelli dei settori finanziari, comunicativi, mentre hanno votato Leave quelli slow, delle aree a lenta velocità, dei distretti industriali manifatturieri e agricoli..
Il populismo che nasce dentro il neoliberismo poi però lo affossa se si rinchiude in politiche protezionistiche?
Sì, perché questo non è un voto di rappresentanza. È un voto di rappresentazione e di vendetta. Per punire qualcuno, non per realizzare un progetto organico di alternativa. Questo fa sì che poi a gestire politicamente questi voti sono le Terese May, gli iperconservatori, i miliardari immobiliaristi, i demagoghi alla Orban, i fascistoidi. In qualche caso utilizzeranno una apologia della Nazione senza lo Stato che redistribuisce la sua ricchezza perché non sono in grado di fermare i flussi globali. Si limitano solo a una rappresentazione demagogica.
I tre populismi italiani di cui parli nel libro, quello televisivo di Berlusconi, quello della rete di Grillo e quello della rottamazione di Renzi, hanno contribuito a distruggere i partiti o sono i partiti che si sono suicidati e hanno permesso la formazione di questi populismi?
L’Italia in questa luce, è una precorritrice dei tempi. Noi abbiamo avuto non un solo populismo – nel senso di populismo 2.0 come abbiamo detto – ma ben tre. L’inventore precoce è Berlusconi. Il suo è un perfetto stile neopopulista, con il suo linguaggio politico in cui metteva la sua intimità, la famiglia, una comunicazione da bar sport. Un populismo da tempi ancora del benessere, da edonismo reganiano, con il suo baricentro nell’uso della televisione, allora mezzo potentissimo. Poi è venuto il grillismo, prima ancora dei 5 stelle, un cyberpopulismo per l’uso della rete. Ma Grillo, come ha fatto notare Carlo Freccero, sa ricombinare tutti i media, anche la televisione. E poi usa benissimo la piazza e il corpo, pensiamo solo alla nuotata nello stretto di Messina. L’ultimo è il populismo più subdolo, e assai antipatico, di Renzi. Subdolo perché si esprime in alto, è un populismo di governo che mima lo stile di chi rivendica le ragioni del basso. Ed è quello della rottamazione, in questo simile a Salvini con le immagini delle ruspe, il nuovo insomma, che seppellisce il vecchio. È un populismo – come le bugie – un po’ dalle gambe corte perché fingersi rappresentanti del basso stando in alto, manovrando le banche, i meccanismi del sottogoverno e del governo mettendo gli amici nei posti che contano, costituendo nuovi cerchi o gigli magici, è un discorso che rischia di bruciarsi in fretta, come è avvenuto con il referendum sulla riforma costituzionale, la madre di tutte le battaglie politiche. Allora lui ha tentato di mettere in campo uno stile populista con il ribattere sui costi della rappresentanza, in realtà il taglio delle poltrone, un argomento che cavalcava l’onda di rabbia populista. Ma è stato travolto nel modo clamoroso. Anche in questo caso le mappe del voto aiutano a comprendere. La mappa del risultato elettorale fa combaciare il voto con la distribuzione territoriale e sociale del disagio: nel rapporto Nord Sud, sul piano generazionale – i giovani plebiscitariamente per il no – nel divario sul reddito. Nelle mappe urbane solo i centri borghesi, i Parioli a Roma e la Crocetta a Torino superano di poco il 50 per cento.
Sulla Francia al voto e i candidati cosa ci puoi dire?
I quattro candidati accreditati dai sondaggi sul filo di lana fino alla vigilia, sono in fondo tutti e quattro portatori di uno stile populista. Sicuramente quello di Le Pen è dichiaratamente di destra, in cui l’antieuropeismo si intreccia con il neonazionalismo, dall’altra parte Mélenchon ha uno stile di populismo, di sinistra, certo, ma anche questo diretto a costruire un “noi” accogliente, pacifico ma nazionale. Macron è un portatore di stile populista anche se filoeuropeo, né di destra né di sinistra, si pone per il superamento dell’intermediazione dei partiti e per la loro dissoluzione e perfino Fillon che è pure un pezzo di estabilishment di lunga durata, rappresenta una sfida alla topografia tradizionale.
Un’ultima domanda sul mood, sullo stato d’animo del populista. Nel libro tu scrivi che «se la paura muove tutto allora significa che qualcosa si è rotto nel profondo».
Sì, una sorta di patologia del sociale e della politica.
Allora vorrei proporti una riflessione. Nel libro di Elisabetta Amalfitano, Le gambe della sinistra, lo psichiatra Massimo Fagioli, da uomo di sinistra, sosteneva la necessità da parte della sinistra di “una ricerca su una nuova realtà umana”. Cioè i bisogni sono fondamentali, ma forse occorrerebbe un approfondimento sulle esigenze, cosa di cui la sinistra non si è mai occupata. Per evitare quindi il vuoto populista la sinistra dovrebbe aprire di più gli occhi su ciò che le persone vorrebbero a livello umano?
Non ho nessun dubbio sul fatto che la radice principale della malattia delle nostre democrazie, è sicuramente psicoantropologica. Nasce da un profondissimo disagio dell’essere delle persone e del loro sistema di relazioni che è andato in sofferenza. Stiamo male nella vita quotidiana, ripetiamo che dobbiamo pensare positivo, dobbiamo dire che ci divertiamo da matti, che siamo felici e che ci vogliamo bene. E invece no, è tutto il contrario. Basta vedere l’immaginario occidentale che emerge dalla letteratura e dal cinema, o le statistiche dell’uso dei farmaci per avere la dimensione di questo malessere. Pensiamo che le persone possano stare male e la politica possa stare bene oppure pensiamo che la politica possa curare il malessere delle persone? Non è così, ovviamente. L’idea che occorrerebbe reinventare una “pianta uomo”, cioè un essere umano capace di vivere la propria umanità in modi diversi, questo è il primo punto. Come quell’idea dell’uomo nuovo che c’era in quei momenti creativi di stato nascente dei movimenti nel ’68. Non c’è dubbio che questo è importante, sapendo però che tutta la cultura economica e sociale va nella direzione opposta, con la creazione di esseri umani pensati come atomi competitivi. Da qui deriva quella incertezza che il neoliberismo considera il motore dello sviluppo e che invece è la radice del disagio.
E quindi cosa dovrà fare la sinistra?
La sinistra da questo punto di vista è malata di pigrizia. Orribilmente pigra.