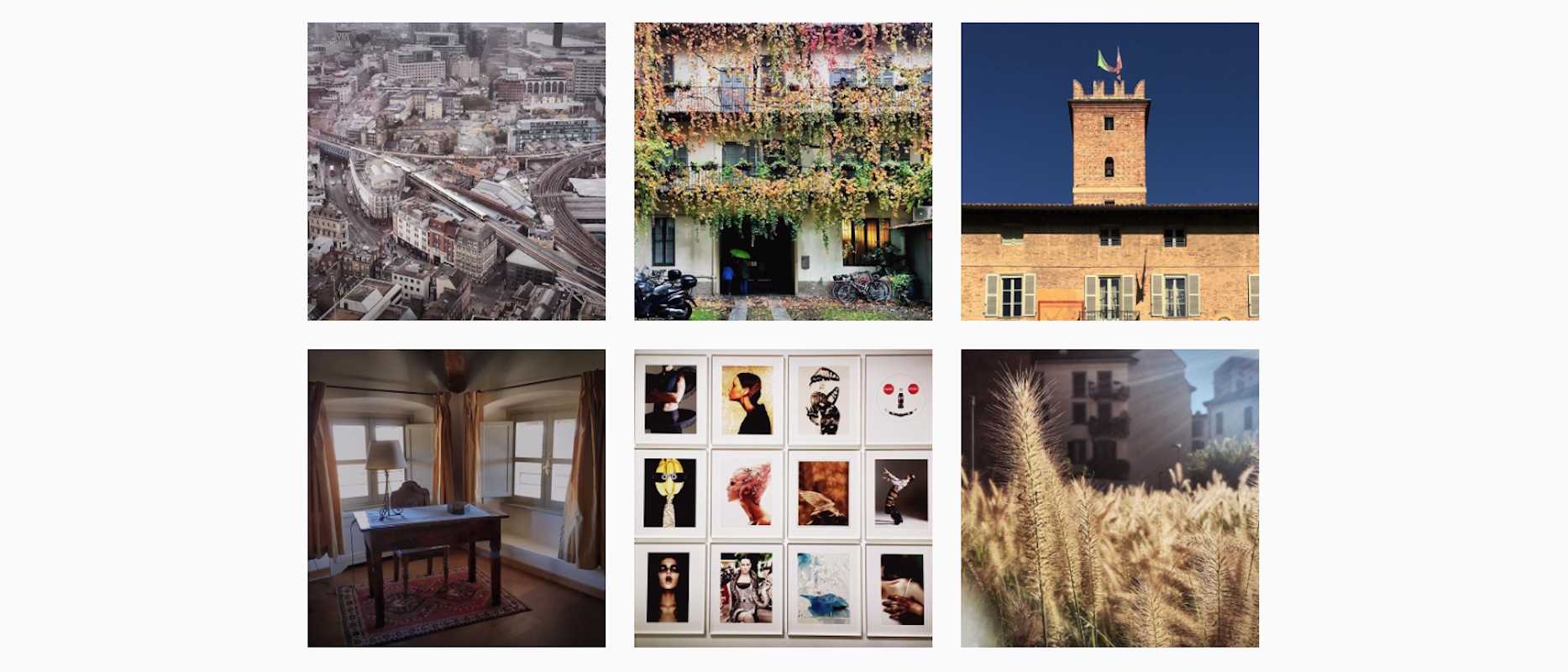Ecco il governo Gentiloni, che nascendo chiude rapidamente la crisi aperta con le dimissioni di Matteo Renzi, sconfitto in un referendum che doveva esser costituzionale e che lui stesso ha però voluto impostare come un giudizio su di sé, una prova da superare per restare a palazzo Chigi. Una prova persa.
La crisi di governo si risolve così rapidamente, per «responsabilità», dicono dal Pd, che in una direzione, nel pomeriggio, ha accordato all’unanimità la fiducia al presidente incaricato. Ma anche perché, nei fatti, alla fine, la maggioranza è sempre la stessa (salta solo Zanetti, ormai in quota Verdini, che doveva esser ministro, ed è il tributo alla «discontinuità» chiesta dalla minoranza dem) e anche il più dei ministri, anche quelli sono sempre gli stessi.
E centrale è il ruolo dei nomi più pesanti del renzismo, Boschi e Lotti. Verrebbe da dire che anche il governo è lo stesso, un Renzi bis senza Renzi. Non fosse che, se questa è sicuramente l’idea di Renzi (che così, senza lasciar spazio a un competitor, può dedicarsi a rigenerare la sua leadership), non è detto che poi sia così veramente.
Renzi – sempre durante la direzione dem – ha messo una sorta di data di scadenza sulla fronte di Gentiloni. «C’è un appuntamento imminente con le elezioni, che noi non temiamo», ha detto Renzi, subito coperto da Matteo Orfini secondo cui siccome la legislatura non è più costituente non avrebbe senso farla arrivare a scadenza naturale. Ma non è detto che la scadenza immaginata da Renzi si avveri. Lui pensa a giugno 2017; non in pochi vorrebbero però arrivare al 2018. E dettare i tempi da fuori il parlamento, anche se sei il segretario del primo partito della coalizione di governo, è complicato. Ecco perché Renzi vuole un rapido congresso e rapide primarie. Per fare avere qualche argomento in più.
Buon lavoro a Paolo Gentiloni e al Governo. Viva l’Italia
— Matteo Renzi (@matteorenzi) 12 dicembre 2016
Ma ecco la lista.
Angelino Alfano va agli Esteri e il sottosegretario ai servizi Marco Minniti sarà invece ministro dell’Interno. Orlando resta alla Giustizia, Pinotti alla Difesa, Padoan ovviamente all’Economia, Calenda allo Sviluppo economico, Madia alla Pubblica amministrazione. Resta anche Franceschini alla Cultura, Galletti all’ambiente, Poletti al Lavoro, Delrio alle Infrastrutture. Resta Lorenzin alla Salute e Martina all’Agricoltura, mentre cambia l’Istruzione, dove arriva Valeria Fedeli.
Maria Elena Boschi cambia solo ruolo, ma resta centrale e resta a palazzo Chigi: aveva detto anche lei, come Renzi, che avrebbe lasciato la politica, non solo la poltrona al governo, e invece sarà sottosegretario alla presidenza. I Rapporti col parlamento vanno a Anna Finocchiaro, senatrice e – volendo – “nonna” della riforma bocciata, se Boschi ne era la madre. Proseguendo le conferme c’è Enrico Costa agli Affari regionali, promosso invece De Vincenti per cui torna la Coesione territoriale. Luca Lotti, infine, già sottosegretario sarà ministro dello Sport (ma anche al Cipe e all’Editoria).