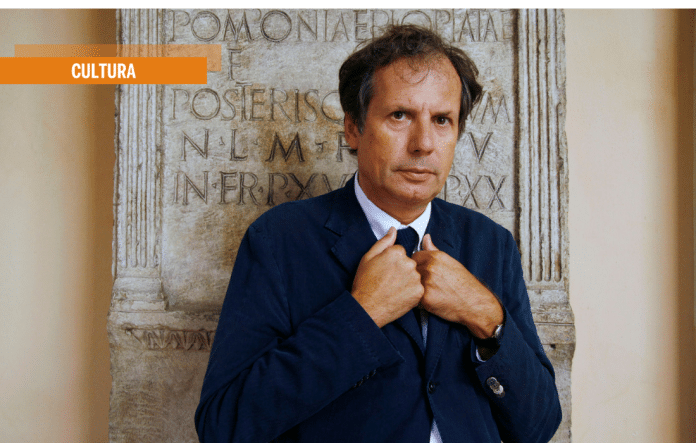Il mattino dell’11 settembre 1973 la città di Santiago si svegliava al suono di bombe e spari. L’esercito cileno guidato dal generale Augusto Pinochet stava assediando con carri armati e caccia La Moneda, il palazzo presidenziale e sede del governo. Poche ore dopo si suicidava il presidente Salvador Allende, democraticamente eletto nel 1970 e primo presidente socialista del Cile.
Pinochet si insediò alla guida del Paese instaurando una dittatura militare che sarebbe durata diciassette anni, fino al 1990. Il governo militare assunse il controllo di tutti i mezzi di comunicazione, sciolse l’Assemblea Nazionale, mise fuori legge i partiti che avevano fatto parte del governo di Allende, e instaurò un regime di repressione del dissenso: nel giro di qualche mese erano già migliaia gli oppositori politici arrestati, imprigionati, torturati e uccisi.
La violenta repressione del dissenso politico continuò per tutta la durata della dittatura: nei diciassette anni di potere di Pinochet, più di 3mila persone furono uccise o fatte sparire – ufficialmente sono ancora 1.162 i desaparecidos, le vittime ancora disperse, della dittatura – circa 40mila persone furono torturate, e oltre 200mila furono costrette a fuggire dal Paese (circa il 2% della popolazione cilena del 1973).
In questi giorni, il Paese celebra il cinquantenario del golpe con una serie di iniziative, tra cui il primo programma ufficiale per ritrovare i desaparecidos, sotto lo slogan “democrazia è memoria e futuro”. Eppure, l’eredità della dittatura è ancora presente nelle istituzioni cilene e molti nel Paese sono reticenti a condannare apertamente Pinochet. Inoltre, molte questioni relative al golpe, primo fra tutti il ruolo degli Stati Uniti in esso, rimangono non del tutto chiare.
«Il Cile, oggi, è un Paese molto diviso» dice Paulina Pavez-Verdugo, ricercatrice all’Università del Cile che ha approfondito la questione del rapporto dei cileni con il golpe e con la dittatura di Pinochet. «Una parte importante della società cilena ha una visione non solo negazionista, ma apologetica, della dittatura: è preoccupante la percentuale di cileni che non ha una visione negativa del colpo di Stato e delle violazioni dei diritti umani negli anni della dittatura». Secondo un recente sondaggio dell’istituto Cerc-Mori, il 36% dei cittadini cileni ha una visione positiva del golpe e ritiene che Pinochet abbia «liberato il Cile dal marxismo»; è il dato più alto misurato in 28 anni di sondaggi. La stessa percentuale di cittadini ritiene che i militari «avevano ragione» a realizzare il golpe. Inoltre, solo il 64% della popolazione ritiene che Pinochet fosse un dittatore: per il 39% dei cileni Pinochet è l’uomo che ha modernizzato l’economia cilena, mentre per il 20% è uno dei migliori governanti che il Cile abbia avuto nel ventesimo secolo.
Anche molti politici cileni portano avanti una narrativa negazionista rispetto alla dittatura. Recentemente, la deputata di destra Gloria Naveillán ha dichiarato che il fatto che le detenute durante la dittatura subissero violenze sessuali è una «leggenda metropolitana» e che si tratta di «accuse per le quali non ci sono prove», nonostante le numerose condanne e la vasta documentazione a riguardo. Il 22 agosto, inoltre, la sessione del Parlamento cileno è iniziata con la lettura – promossa da una coalizione di destra ed estrema destra – di una dichiarazione del 22 agosto 1973 che denunciava una «grave violazione dell’ordinamento giuridico e costituzionale della Repubblica» da parte del governo di Allende. A inizio settembre, il partito di destra Chile Vamos si è rifiutato di firmare il “Compromesso di Santiago” proposto dal governo, un accordo per la celebrazione congiunta dell’anniversario del golpe e un documento di condanna della dittatura e di impegno per la difesa della democrazia.
L’attuale presidente di sinistra Gabriel Boric, eletto nel 2021 contro il candidato di estrema destra e nostalgico di Pinochet José Antonio Kast, ha cercato in molti modi di cancellare l’eredità di Pinochet: in primo luogo con il tentativo di sostituire la costituzione del 1980 ancora in vigore. Questa costituzione, adottata sotto la dittatura, è forse il lascito più importante del regime di Pinochet; essendo fortemente incentrata su un modello economico neoliberale, è fra l’altro considerata la base delle enormi disuguaglianze della società cilena che hanno portato a proteste di massa tra il 2019 e il 2020. Eppure, una nuova costituzione redatta sotto il governo Boric è stata respinta dai cittadini cileni in un referendum nel 2022.
Dietro al rifiuto della nuova costituzione, secondo Pavez-Verdugo, così come dietro alle posizioni apologetiche verso Pinochet, c’è una narrativa fortemente sospettosa nei confronti della sinistra, assimilabile alla campagna anticomunista della guerra fredda, «il tipico ritornello che Pinochet ci ha salvato dal comunismo e che senza di lui saremmo come Cuba, il Venezuela o l’Unione Sovietica; c’è un elemento emotivo molto grande nel fantasma del comunismo». Questa narrativa è portata avanti dai rappresentanti di un’élite che concentra il potere economico e il controllo dei principali mezzi di comunicazione del Paese; nel caso del referendum costituzionale, secondo la ricercatrice, «la destra ha portato avanti una campagna fortemente ideologica contro la nuova costituzione sui principali mezzi di comunicazione quando il testo non era stato ancora scritto».
Pavez-Verdugo ritiene inoltre che il sistema educativo abbia un ruolo nella scarsa consapevolezza storica verso gli anni della dittatura. In Cile, il golpe militare del 1973 è diventato parte ufficiale del curriculum scolastico solamente nel 2009: anche adesso, secondo la ricercatrice, «la questione della memoria storica e delle violenze della dittatura non viene discussa in modo serio e approfondito».
Inoltre, secondo la ricercatrice, la poca consapevolezza è legata al fatto che in Cile non ci sia stato uno stacco dopo la dittatura militare: «C’è una continuità tra la dittatura e la democrazia, dal momento che abbiamo ancora la stessa costituzione e che figure di rilievo della dittatura sono rimaste al governo nel periodo democratico; al termine della dittatura militare non c’è stato nessun processo contro i criminali, non c’è stato un taglio netto, e Pinochet è morto senza mettere piede in tribunale: uno dei dittatori più violenti e autoritari al mondo è morto senza essere processato». Pinochet, dopo essersi dimesso dalla carica di presidente, ha infatti continuato a servire come capo dell’esercito per anni, ed è rimasto senatore fino al 2002, prima di morire di infarto a 91 anni, in Cile. «Il risultato è una classe politica che non è mai riuscita a staccarsi con decisione dalla dittatura, così come le istituzioni, a partire dalla costituzione, dal Parlamento, dalla magistratura, e dalle forze dell’ordine».
Una legge d’amnistia approvata durante la dittatura ha inoltre bloccato per decenni le indagini e i processi: le accuse di omicidi, torture, stupri e rapimenti contro militari e forze dell’ordine cilene iniziarono ad essere indagate solo nel 2000. Ad oggi, circa 250 persone sono in carcere per le violenze commesse durante la dittatura; molte delle sentenze per i più importanti casi di abusi e violazioni di diritti umani sono però state emesse solamente quest’anno.
Ma non solo le violazioni dei diritti umani e i crimini commessi durante la dittatura restano senza giustizia e verità: anche alcune questioni legate al golpe non sono ancora del tutto chiare. In particolare, il ruolo che gli Stati Uniti e la Cia hanno avuto in esso. Alla fine di agosto, la Cia ha declassificato alcuni documenti ufficiali dell’8 settembre 1973, che confermano che l’allora presidente Nixon era stato informato della possibilità di un colpo di stato. Altri documenti resi pubblici durante l’amministrazione Clinton hanno rivelato che gli Stati Uniti hanno attivamente tentato di rovesciare Allende già nel 1970, e hanno sostenuto economicamente e militarmente Pinochet durante la dittatura.
Il coinvolgimento diretto di Cia e Stati Uniti nel golpe del 1973 non è però mai stato dimostrato, e in molti chiedono la declassificazione di altri documenti potenzialmente rilevanti, ancora segreti, che potrebbero far luce sulle circostanze del colpo di Stato e sul ruolo giocato dagli Stati Uniti. Anche la deputata statunitense Alexandria Ocasio-Cortez ha sollecitato la declassificazione dei documenti relativi al golpe cileno, sostenendo che aiuterebbe l’avvicinamento tra i due Paesi così come la creazione di una consapevolezza e memoria storica più forte in Cile, contrastando il revisionismo e il negazionismo.
D’altra parte, anche il coinvolgimento degli Stati Uniti nel golpe è oggetto di negazionismo da parte di molti cileni, spiega Pavez-Verdugo: «Anche per quanto riguarda le cose che già si sanno, che la Cia ha reso pubbliche, tanti cileni negano i fatti e sostengono che siano bugie della sinistra, che le fonti di queste informazioni non sono affidabili e che il coinvolgimento degli Stati Uniti è una bugia».
In questo contesto, la celebrazione del 50esimo anniversario del golpe rischia di essere un evento che polarizza ulteriormente la società cilena piuttosto che un’occasione per unificare il Paese. «Siamo nel mezzo di una battaglia di memoria, una battaglia di rappresentazione e di significato, e soprattutto una battaglia politica per riconoscere la nostra storia», conclude Pavez-Verdugo.
Nella foto, il bombardamento della Moneda e una immagine di Salvador Allende (wikipedia)
Leggi anche: Andrea Mulas, L’utopia concreta di Salvator Allende, Left, settembre 2023