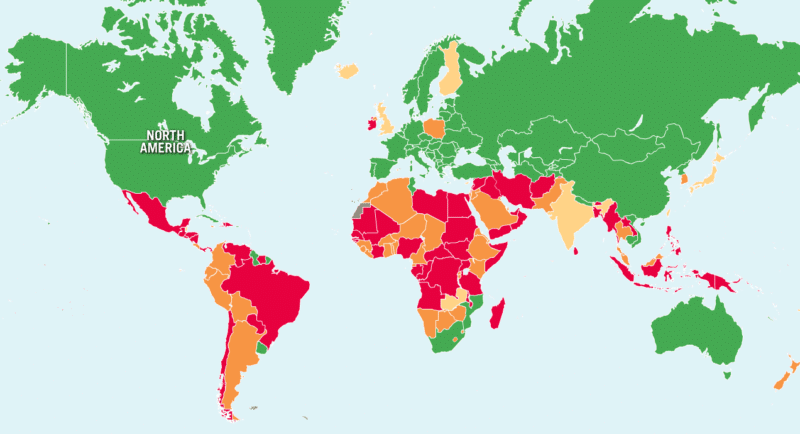Pubblica, laica, pluralista, democratica. Aggettivi semplici, a cui non dobbiamo cessare di assegnare l’alto valore di principi irrinunciabili, ciascuno con la propria portata di profonda civiltà, e che vanno associati ad un altro, altrettanto fondamentale: gratuita. È il ritratto di una scuola che è stata costruita intenzionalmente come strumento dell’interesse generale perché, solo grazie a quelle peculiarità, essa risponde al mandato che la Costituzione le assegna: formare cittadini consapevoli, in grado cioè di compiere delle scelte motivate dalla conoscenza e dalla capacità di selezionare informazioni e di metterle utilmente in relazione; configurare, sulla scorta del comma 2 dell’art. 3 della Carta, lo strumento privilegiato che la Repubblica ha in mano per rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Leggere e riflettere su queste peculiarità altissime e significative rappresenta quotidianamente uno stimolo per non cessare di mobilitarsi sul tema dell’istruzione, pur – o, forse, soprattutto – nella consapevolezza di quanto la normativa degli ultimi 20 anni abbia intenzionalmente decostituzionalizzato la scuola, prona come è stata alla logica (che investe tutto lo Stato sociale) del pensiero unico dettato dall’Europa: giustapporre criteri economici e di profitto ai diritti fondamentali delle persone. Se il 4 dicembre 2016 abbiamo difeso la Costituzione, lo abbiamo fatto anche perché i principi in essa contenuti abbiano un’attuazione concreta. Perdere su questo fronte, assecondare l’oblio del senso profondo di quegli aggettivi, ridurli a orpello retorico e non a esigenza irrinunciabile significherebbe non solo tradire le premesse della nostra storia nazionale, ma arrenderci ad una società che immobilizza i destini degli individui per diritto di sangue. Non solo. Significherebbe anche arrenderci a un abbandono della riflessione, del tempo disteso della conoscenza, del pensiero critico-analitico e delle istanze che da questi presupposti possano consentire di interpretare un mondo sempre più complesso; alla rottura del principio dell’unitarietà del sistema scolastico, amplificando divari tra scuola e scuola; alla perdita della libertà di insegnamento, principio di tutela universale, alla acquiescenza rispetto alle scorribande dei privati nella scuola “aperta a tutti” e alla precedente costruzione, nel luogo dell’equiordinazione tra organi collegiali, di un sistema gerarchico. E ancora, significherebbe arrenderci alla ghettizzazione dei “diversi”, prerequisito oggi nelle scuole che hanno smarrito il senso del proprio mandato, per garantire l’apprendimento dei “normali” (il famoso caso del Rav del Visconti a Roma, con il violento carico di rassicurazioni sul fatto che in quella scuola non ci siano migranti o disabili); ad una valutazione incapace di guardare all’individuo come al contesto (si tratti di studenti o di scuole), con l’unico scopo di stimolare la competizione. Significherebbe soggiacere ad un’idea di innovazione che sconfina nella barbarie; assecondare il pensiero unico – sia esso dei poteri forti, che dell’oltranzismo confessionale – che vuole consumatori acritici e/o dogmatici. Sudditi, non cittadini.
L’8 settembre 2017 la legge di iniziativa popolare Per la Scuola della Costituzione è stata depositata in Cassazione e da 2 mesi è iniziata la raccolta delle firme per proporne la discussione parlamentare. Si tratta di 37 articoli che abrogano gran parte della normativa degli ultimi 15 anni, dalla riforma Moratti, alla Gelmini, alla Buona scuola, tentando di riportare la scuola al modello dettato dagli articoli 3, 9, 33 e 34 della Carta. Non solo abrogare, dunque, ma anche ri-costruire e ri-portare la scuola all’altissimo rango di organo costituzionale, quale fu pensata – non a caso – nell’Italia che risorgeva sui principi dell’antifascismo.
La Lip non si propone di intervenire su tutti gli aspetti della normativa scolastica, ma di disegnare un’idea di scuola. Vi si parla di gratuità, di inclusione, di laicità (sono vietate le cerimonie di culto negli edifici scolastici; l’insegnamento della religione cattolica è in orario extracurricolare; viene abolito l’inserimento delle scuole paritarie private nel sistema nazionale di istruzione); si prevede un rapporto alunni-docente che scongiuri per sempre le classi pollaio; l’unico insegnamento obbligatorio esplicitamente previsto (la legge non si occupa di programmi e discipline) è quello di Costituzione e cittadinanza.
E ancora la Lip prevede: diritto allo studio e all’apprendimento, sapere disinteressato ed emancipante. Si rende poi obbligatorio il terzo anno di scuola dell’infanzia, in previsione della generalizzazione; si abrogano i test Invalsi e il voto numerico alla primaria e alle medie, si ripristinano tempo pieno e prolungato; si riconducono alla loro centralità gli organi collegiali, riaffidandogli prerogative che sono espressione della democrazia scolastica. Nella Lip il biennio è unitario, posticipando così la scelta della scuola superiore – troppo spesso compiuta su base socio-economica – di due anni e garantendo i saperi imprescindibili per tutti più a lungo; viene esteso l’obbligo al termine della scuola superiore, in modo che la scuola riprenda ad essere ascensore sociale e garanzia di pari opportunità per tutti, nessuno escluso. E ancora: un presidente del collegio, eletto dai docenti, affiancherà il dirigente scolastico, che continuerà ad avere funzioni solo amministrative; l’autonomia scolastica viene riportata nel suo alveo costituzionale, quello del principio della libertà dell’insegnamento, strumento dell’interesse generale. Si prevedono poi “percorsi di cultura del lavoro”, obbligatori per tutti gli indirizzi di scuola superiore, gestiti dalle singole istituzioni scolastiche: si tratta della creazione di anticorpi negli istituti che oggi stanno subendo l’alternanza scuola lavoro, che mercifica il lavoro e ne sdogana la possibilità di essere gratuito, non normato, svincolato dai diritti, sulla scia del modello Jobs act; che sottrae gli studenti allo studio e alla cultura emancipante, per proiettarli in una dimensione di svilente generico apprendistato, slegato dall’indirizzo di studio che hanno intrapreso. Di tutto questo la scuola della Costituzione deve farsi carico per ribadire il tema della dignità del lavoro. Grande attenzione, nel testo, al linguaggio di genere e alla purificazione da anglicismi e tecnicismi di matrice anglofona ed economicista.
La Lip prevede che all’istruzione vada il 6 per cento del Pil nazionale, come da media dei Paesi europei: anche per questo la raccolta di firme si affianca a quelle – promosse dal Coordinamento democrazia costituzionale – per ripristinare il testo originario dell’art. 81 della Costituzione, eliminando l’equilibrio di bilancio e per una revisione del Rosatellum in senso proporzionale. L’obiettivo è risanare tre ferite che gli ultimi parlamenti hanno inflitto alla democrazia nel Paese.
Perché, dunque, questa campagna di raccolta firme è così importante? Un motivo su tutti: il nuovo regolamento del Senato prevede l’obbligo di discutere entro 3 mesi i testi depositati. Non più, dunque, leggi di iniziativa popolare dimenticate in un cassetto e mai prese in considerazione (la Lipscuola, la cui prima redazione risale al 2006, quell’anno raccolse 100mila firme – il doppio delle necessarie – ma non fu mai discussa) ma strumenti che (tenendo conto anche di quanto il presidente della Camera, Fico, ha assicurato) avranno ascolto e considerazione, una volta presentate. Si tratta in questo momento di provare con convinzione a riaccendere i riflettori su temi fondamentali: la democrazia, i tagli allo stato sociale, la scuola della Costituzione, sui quali si potrebbero, qualora le firme venissero raggiunte, riaprire mobilitazione, dibattito, iniziativa. È per questo che è necessaria l’attenzione, ma – soprattutto – un piccolo impegno da parte di ciascuno di noi: diamo gambe ed energia a queste grandi idee e alla speranza di avere speranza. Firmiamo e facciamo firmare. Ribaltare il paradigma corrente, privatistico e classista, disinfestare lo spazio culturale dal dominio del mercato, ricostruire l’equilibrio di diritti e poteri, restituire il sistema scolastico alla funzione di promozione del pensiero critico e della cittadinanza consapevole: questo e altro nel testo della legge Per la Scuola della Costituzione.
da Left n.15 del 13 aprile 2018
È in corso la campagna di raccolta firme per la Lip. L’obiettivo è raggiungere quota 50mila – e oltre, per sicurezza, sostengono i promotori – entro la fine di luglio 2018. Il 6 agosto è prevista la consegna delle firme. Esistono comitati che si stanno mobilitando, per questa Lip e per le altre due sull’art.81 e la legge elettorale. Il testo della Lip scuola e il materiale informativo, oltre che gli indirizzi e i nomi dei reponsabili dei comitati promotori qui