La potenza narrativa dell’epos l’ultimo romanzo del colombiano Santiago Gamboa Ritorno alla buia valle (Edizioni e/o). E uno sguardo aperto a tutto raggio sul mondo di oggi e sulle sue più brucianti contraddizioni: il divario Nord Sud, l’odissea dei migranti, la discriminazione, la xenofobia, l’egoismo dell’Occidente sempre più arroccato e in crisi, la corruzione e la violenza delle destre al potere in America Latina e la voglia di riscatto della popolazione. Una esigenza profonda di riscatto che nella giovanissima Manuela, violentata dal compagno della madre e oppressa da istituzioni clerico-religiose, si esprime attraverso la poesia.
 Anche Tertuliano figlio mai riconosciuto di papa Bergoglio, nato quando era a capo dei gesuiti in Argentina, è in cerca della verità e di un pizzico di giustizia. Come lo sono i diversi e numerosi personaggi che popolano questo romanzo, in cui si intrecciano infinite storie. Per questo Vázquez Montalbán paragonò i libri di Gamboa a quelli di Márquez, anche se appaiono lontani dal realismo magico tipico di Gabo. Piuttosto qui si potrebbe parlare di realismo visionario, capace di scavare a fondo nell’animo umano, di raccontare sogni, paure, di indagare le cause della violenza esprimendo un profondo rifiuto. Anche per questa sua particolarissima capacità di intrecciare storia personale e collettiva, all’indomani delle elezioni in Colombia che hanno portato al governo il leader del centrodestra Ivan Duque, abbiamo rivolto a Santiago Gamboa alcune domande.
Anche Tertuliano figlio mai riconosciuto di papa Bergoglio, nato quando era a capo dei gesuiti in Argentina, è in cerca della verità e di un pizzico di giustizia. Come lo sono i diversi e numerosi personaggi che popolano questo romanzo, in cui si intrecciano infinite storie. Per questo Vázquez Montalbán paragonò i libri di Gamboa a quelli di Márquez, anche se appaiono lontani dal realismo magico tipico di Gabo. Piuttosto qui si potrebbe parlare di realismo visionario, capace di scavare a fondo nell’animo umano, di raccontare sogni, paure, di indagare le cause della violenza esprimendo un profondo rifiuto. Anche per questa sua particolarissima capacità di intrecciare storia personale e collettiva, all’indomani delle elezioni in Colombia che hanno portato al governo il leader del centrodestra Ivan Duque, abbiamo rivolto a Santiago Gamboa alcune domande.
Nel suo ultimo romanzo parla dei molti italiani che vanno a lavare i piatti all’estero, in Inghilterra o nel Nord Europa, mentre peruviani, ecuadoregni, filippini, colombiani approdavano in Italia per lavare i loro piatti. Lei ha vissuto a Roma, cosa pensa di quel che sta accadendo in Europa e del governo che vorrebbe chiudere i porti ai migranti?
La situazione in Europa mi pare sempre più compromessa. La crisi economica ha investito il progetto sociale e ideale dell’Unione europea. Cosa significa essere europei oggi? Significa essere solidali con chi sta peggio? Significa comportarsi in modo responsabile nei confronti del resto del mondo? Significa credere nel progresso e nei diritti umani, nella società multietnica e multirazziale? Quei valori rischiano di finire in mille pezzi. La coesione tra gli europei sta già subendo un’enorme frattura: i Paesi ricchi del Nord si dicono stufi di aiutare il Sud: Grecia, Portogallo, Spagna, Italia. La Brexit esemplifica questa mancanza di solidarietà e la volontà di non condividere la ricchezza accumulata, considerandola solo propria. Anche l’indipendentismo catalano è un modo per sottrarsi all’impegno di aiutare il resto della Spagna (e dell’Europa).
Alcune vicende narrate si svolgono negli anni degli attentati terroristici in Spagna e in concomitanza della strage al Bataclan in Francia, a cui è seguita una forte criminalizzazione dei migranti.
La violenza terroristica, con le ricadute che ha avuto anche sulla crisi dei rifugiati, ha pesato e rischia di rompere l’idea di una società multietnica e multirazziale, non solo in Italia, che è stato il Paese in cui più tardivamente si è fatta strada questa crisi di ideali. Xenofobia e razzismo sono più forti che mai in Francia, Germania, Olanda, Belgio, perfino in Svezia. La politica anti-europea e individualista è cresciuta ed oggi è molto forte. Cresce una sorta di “trumpismo” europeo che punta al nazionalismo, che predica la salvezza individuale in ogni Paese.
L’Europa è diventata una fortezza. Accetta soltanto immigrati selezionati, i più forti e qualificati. Purché arrivino in ginocchio, indebitati, disposti ad accettare qualsiasi tipo di lavoro. Sta accadendo una cosa simile in America divisa dal muro con il Messico?
Il trumpismo avanza nel mondo. È la fine del neoliberismo inteso come capitalismo senza frontiere. Ma non produce un sistema migliore. Dire America first significa tornare a innalzare muri per proteggere l’economia interna a furia di dazi. Le frontiere diventano insormontabili, le barriere sempre più crudeli e difficili da superare, perché il migrante con la sua forza lavoro è mal visto dalle società in crisi che soffrono di disoccupazione e si stringono intorno al totem regressivo della tribù. Per questo le forze reazionarie della società vedono il migrante come potenziale delinquente e quel violento messaggio rischia di essere accettato da tutti a causa della crisi stessa. Con ciò negano il fatto che siamo migranti da moltissime migliaia di anni e che nascere, in fondo, è entrare in un mondo sconosciuto.
Anche in America Latina sta soffiando forte il vento di destra. Il Messico sta cambiando rotta?
La sinistra vince in Messico. I sondaggi hanno parlato di un vantaggio di Lopez Obrador di circa 20 punti. È una grande speranza per l’America Latina, perché il Messico è il Paese più influente della regione, il più popoloso e il più ricco (a lato del Brasile). Questa vittoria significa un forte rifiuto della corruzione e della violenza in cui i partiti tradizionali hanno gettato il Messico, dove il problema del narcotraffico ha raggiunto enormi proporzioni. La corruzione e la violenza derivate dal traffico di droga sono un problema di sicurezza nazionale, che contamina anche le relazioni con gli Stati Uniti e si espande verso l’America centrale e il Sud. L’origine è la Colombia, ma l’attività del narcotraffico è quasi al 100% messicana. I cartelli messicani rappresentano la vittoria del capitalismo illegale.
Il processo di pace in Colombia e la rinascita culturale del Paese rischiano uno stop con il nuovo governo di centrodestra?
La violenza degli ultimi 50 anni ha trasformato la Colombia in una società conservatrice, di destra. Per paura molti preferiscono le forti opzioni nazionaliste che promettono unità e sicurezza. È simile a quanto accade in Europa, solo che in Colombia va avanti da almeno cinque decenni. Il processo di pace è stato un grande risultato, una seconda indipendenza per il Paese, chi è contro la paura è a favore del cambiamento. E nulla spaventa di più dei cambiamenti se la società è conservatrice. Il discorso di destra dell’ex presidente Alvaro Uribe (che è indagato per la sua vicinanza ai gruppi paramilitari) ha trovato in questo clima un terreno fertile per far crescere paura e odio. E ha finito per vincere il centrodestra. La sinistra ha perso, ma ha avuto il 42 per cento dei voti; quindi la lotta continua. Ci saranno sicuramente grandi movimenti di protesta nei prossimi 4 anni. Ciò è positivo, perché significa rafforzare un movimento politico ma anche civile che protegga gli accordi di pace dalle piazze e dalle strade del Paese.
In questo suo nuovo libro dall’articolata architettura si parla molto di poesia, attraverso due storie parallele: quella attuale della giovane Manuela (alla quale vengono rubati versi di una donna che dice di amarla) e quella storica e tormentata di Rimbaud. La poesia può essere rivoluzionaria, un elemento di riscatto, un’oasi per resistere alla violenza?
La poesia protegge le persone e le salva. Salva anche le società. Ma accade che i poeti vengano ascoltati sempre di meno. Ai tempi di Erodoto e di Omero, poesia e vita quotidiana erano molto vicine. Oggi le metafore che governano la vita dell’Occidente non provengono più dalla poesia, ma dal razionalismo e dalla tecnica. Vengono anche dalla solitudine. Le nostre società, orfane di grandi idee, si rifugiano nell’individualismo. Pertanto, quando una persona ha difficoltà a trovare il proprio posto nel mondo, diventa depressa. Incolpiamo noi stessi perché siamo diventati sfruttatori di noi stessi. Fino a non molto tempo fa si facevano rivoluzioni per trasformare società oppressive, oggi si prendono antidepressivi. Abbiamo barattato la rivoluzione con la depressione. Ma la poesia è lì, a ricordarci che ogni sofferenza della vita può avere senso se sappiamo come trasformarla in una parola.
La letteratura permette di vivere molte vite a un tempo. È anche questa la sua forza?
Una vita, da sola, è davvero poca vita. La letteratura ci consente di moltiplicare quella meravigliosa sensazione di vivere, e anche di farlo in tutte le direzioni: verso il passato o il futuro, in altre regioni, lasciandoci cambiare genere, storia o condizione. La letteratura ci rende persone migliori, perché ci permette di sperimentare il dolore e le realizzazioni degli altri, ci insegna la vita in un modo più ampio e più democratico, ma ci fa anche capire cosa origina la violenza e la crudeltà. La letteratura ci protegge anche perché ci mostra le conseguenze di determinate scelte e ciò che accade in strade piene di ombre. Ci aiuta a capire meglio il mondo perché è una versione infinita e irrazionale dello stesso mondo.

L’intervista di Simona Maggiorelli a Santiago Gamboa è tratta da Left
SOMMARIO ACQUISTA

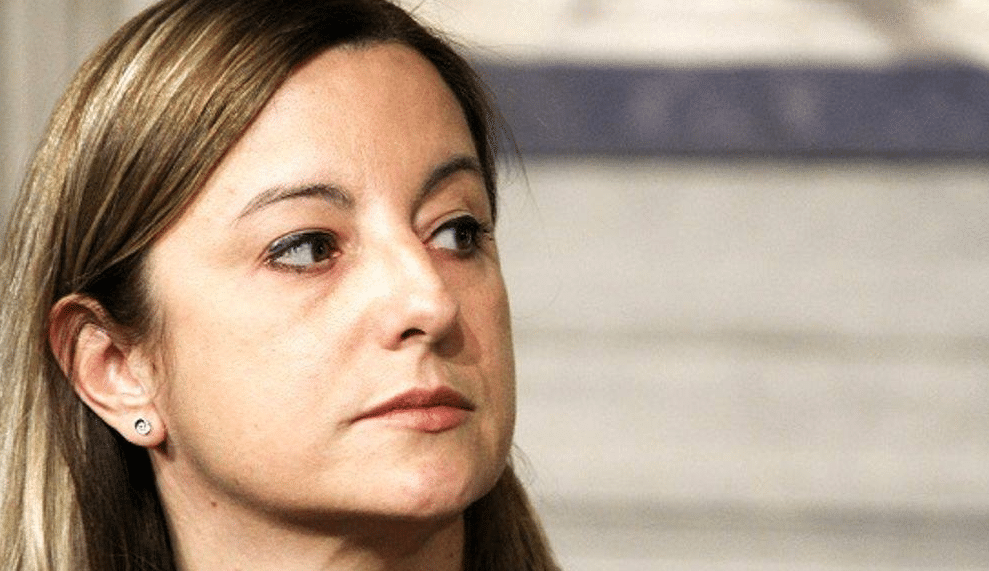


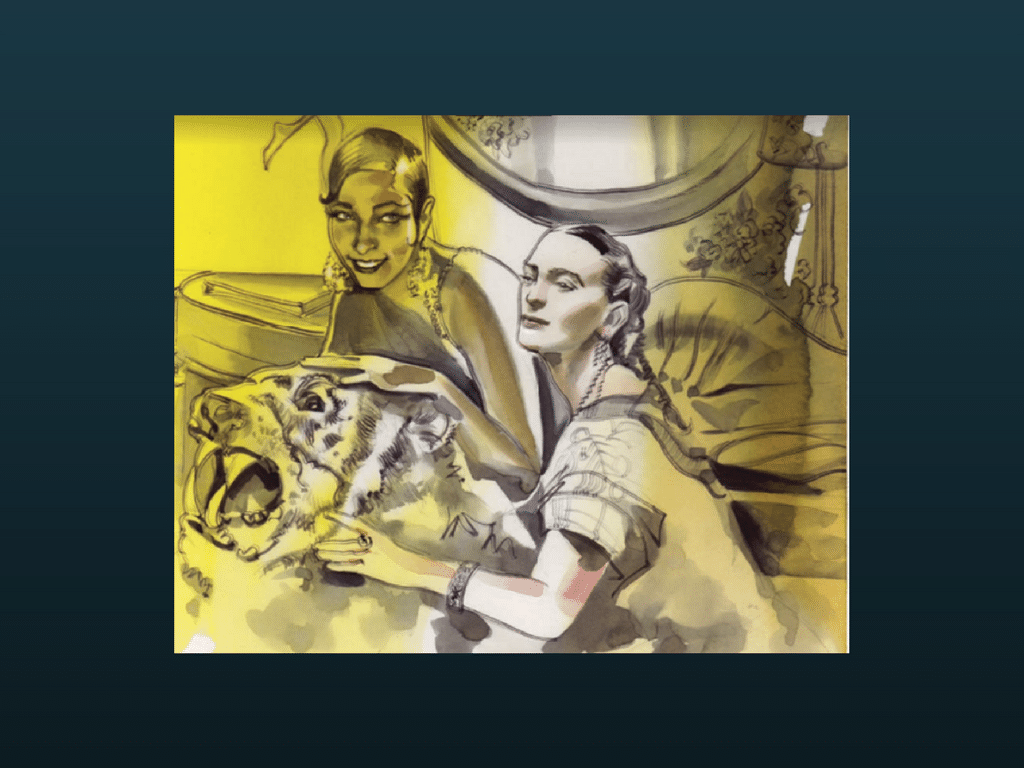




 Anche Tertuliano figlio mai riconosciuto di papa Bergoglio, nato quando era a capo dei gesuiti in Argentina, è in cerca della verità e di un pizzico di giustizia. Come lo sono i diversi e numerosi personaggi che popolano questo romanzo, in cui si intrecciano infinite storie. Per questo Vázquez Montalbán paragonò i libri di Gamboa a quelli di Márquez, anche se appaiono lontani dal realismo magico tipico di Gabo. Piuttosto qui si potrebbe parlare di realismo visionario, capace di scavare a fondo nell’animo umano, di raccontare sogni, paure, di indagare le cause della violenza esprimendo un profondo rifiuto. Anche per questa sua particolarissima capacità di intrecciare storia personale e collettiva, all’indomani delle elezioni in Colombia che hanno portato al governo il leader del centrodestra Ivan Duque, abbiamo rivolto a Santiago Gamboa alcune domande.
Anche Tertuliano figlio mai riconosciuto di papa Bergoglio, nato quando era a capo dei gesuiti in Argentina, è in cerca della verità e di un pizzico di giustizia. Come lo sono i diversi e numerosi personaggi che popolano questo romanzo, in cui si intrecciano infinite storie. Per questo Vázquez Montalbán paragonò i libri di Gamboa a quelli di Márquez, anche se appaiono lontani dal realismo magico tipico di Gabo. Piuttosto qui si potrebbe parlare di realismo visionario, capace di scavare a fondo nell’animo umano, di raccontare sogni, paure, di indagare le cause della violenza esprimendo un profondo rifiuto. Anche per questa sua particolarissima capacità di intrecciare storia personale e collettiva, all’indomani delle elezioni in Colombia che hanno portato al governo il leader del centrodestra Ivan Duque, abbiamo rivolto a Santiago Gamboa alcune domande.



