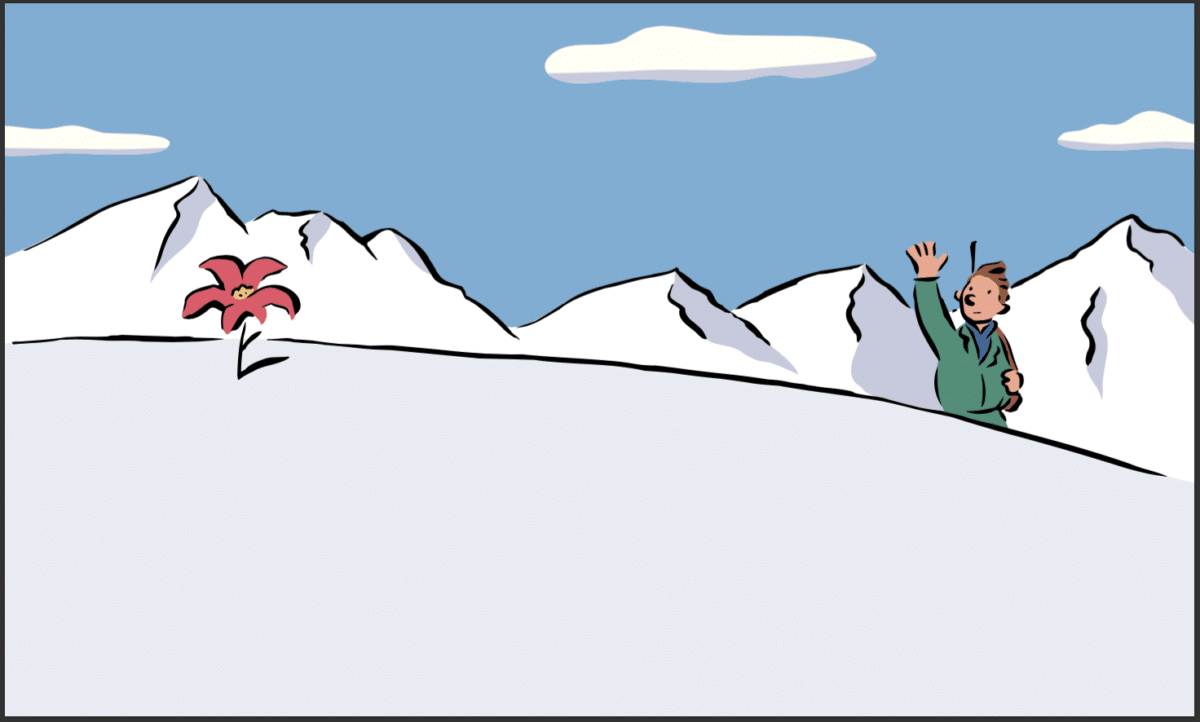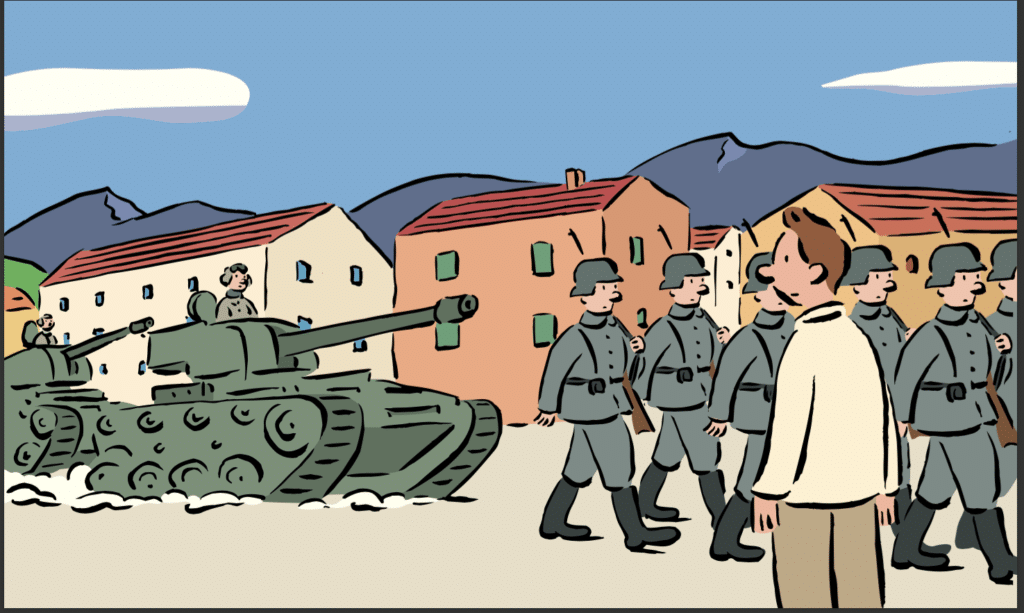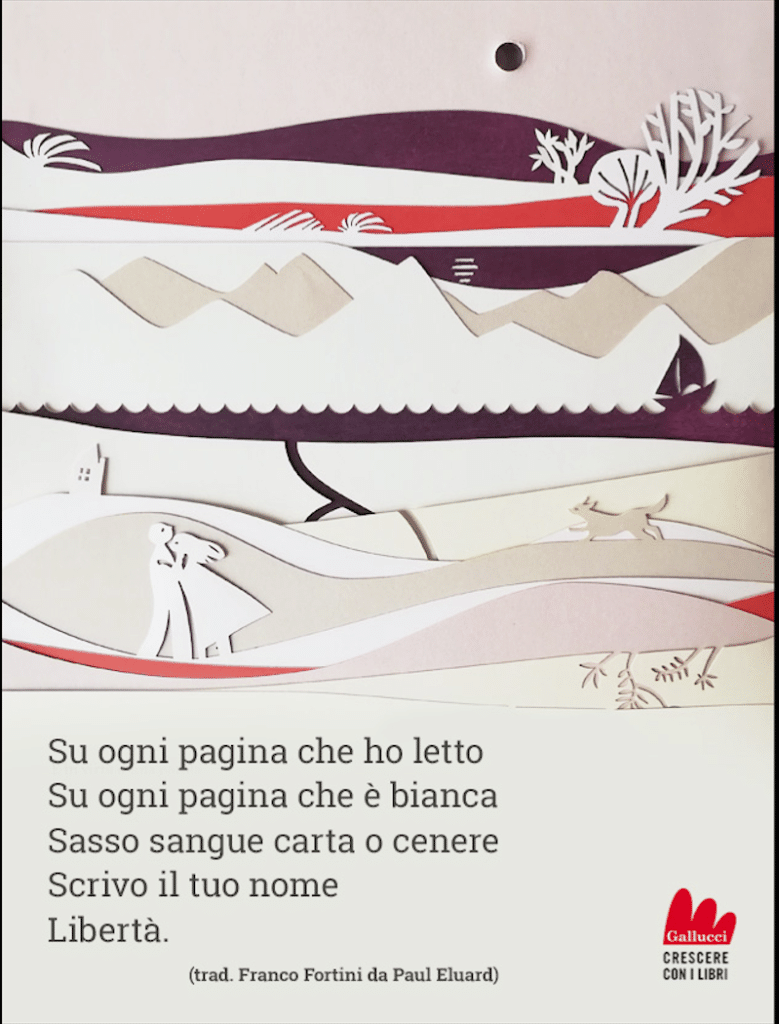«Per noi precari della scuola storici questo bando è una trappola». Non usa mezzi termini Roberto Truglia, che fa parte del coordinamento dei docenti abilitati di seconda fascia delle graduatorie di istituto, quando parla del bando “transitorio” per l’assunzione degli insegnanti. I docenti hanno infatti diffuso un comunicato in cui esprimono tutta la loro contrarietà al bando d’assunzione lanciato con la riforma della Buona scuola e propongono delle soluzioni al loro problema. Passano anche alla protesta e infatti le sigle sindacali Anief e Saese hanno indetto uno sciopero per il 2 e il 3 maggio. Inoltre, dal 28 aprile al 3 maggio tocca al Coordinamento nazionale dei diplomati magistrale abilitati: le insegnanti delle elementari che da mesi protestano perché escluse dalle Graduatorie a esaurimento (Gae) da una sentenza del Consiglio di Stato faranno un sit in di protesta e sciopero della fame davanti al Miur.
Professor Truglia cosa c’è che non va in questo bando?
Il concorso dovrebbe servire a stabilizzare i precari storici della scuola come me, ma, per come è stato pensato, è nel migliore dei casi uno spreco di soldi, nel peggiore una trappola. Inizialmente erano ammessi soltanto i docenti abilitati di seconda fascia come me (la prima fascia comprende gli insegnanti iscritti nelle Graduatorie ad esaurimento, e che quindi diventeranno di ruolo; la terza fascia è composta da insegnanti in possesso di un titolo di studio valido per l’insegnamento ma non abilitati, ndr), poi il Tar del Lazio ha deciso che al bando può partecipare anche chi ha un dottorato di ricerca ma non è abilitato all’insegnamento.
In che senso è una trappola per i precari storici?
È una trappola per noi perché, secondo i termini del concorso, viene riconosciuto un massimo di 30 punti guadagnati con l’esperienza di insegnamento maturata negli anni, e nel caso di molti di noi si parla di decine di anni. Anni di esperienza sia lavorativa che personale, a contatto ogni giorno con la scuola ed i suoi problemi. Con un limite così basso di punti riconosciuti, veniamo quindi equiparati a chi ha cominciato solo pochi anni fa. Inoltre, non solo può partecipare anche chi ha concluso un dottorato, ma esserne in possesso fa guadagnare molti punti, pur senza avere alcuna abilitazione all’insegnamento e quindi senza avere alcuna esperienza educativa. Ma le problematiche non finiscono qui: una volta vinto il bando si accede al Fit, formazione iniziale e tirocinio. Il Fit si svolge in tre anni: i primi due anni sono composti da tirocini e supplenze, mentre al terzo anno viene assegnata una cattedra vacante. Nel caso il Fit non venisse superato, si viene cancellati dalle graduatorie e la propria storia lavorativa annullata. In tal caso, un precario come me, l’anno successivo dovrebbe ripartire da zero e vedersi annullati anni di insegnamento. C’è poi un’ulteriore discriminazione, sempre in termini di punteggio, tra l’abilitazione tramite Tfa, tirocinio formativo attivo, e Pas, percorsi abilitanti speciali.
C’è differenza tra questi due percorsi?
No, entrambi provengono dalla stessa normativa e il percorso è molto simile. Rispetto al Tfa, il Pas è un percorso specializzante per insegnanti di laboratorio delle superiori, ma a questo ultimo percorso vengono assegnati ben 19 punti in meno rispetto al Tfa, una differenza che può pesare molto quando si partecipa al bando “transitorio”.
Cosa propone il coordinamento di cui fa parte per risolvere la vostra situazione?
Noi chiediamo la riapertura delle graduatorie ad esaurimento, chiuse dal 2008. Oppure, per le classi di concorso per cui le graduatorie sono già esaurite, passare direttamente all’assunzione degli insegnanti abilitati in seconda fascia rispettando i punteggi individuali acquisiti fino ad ora. Sarebbe una soluzione molto semplice e che non richiederebbe alcun bando o concorso. Abbiamo comunque organizzato delle mobilitazioni: le sigle sindacali Anief e Saese hanno indetto uno sciopero per il 2 e il 3 maggio.