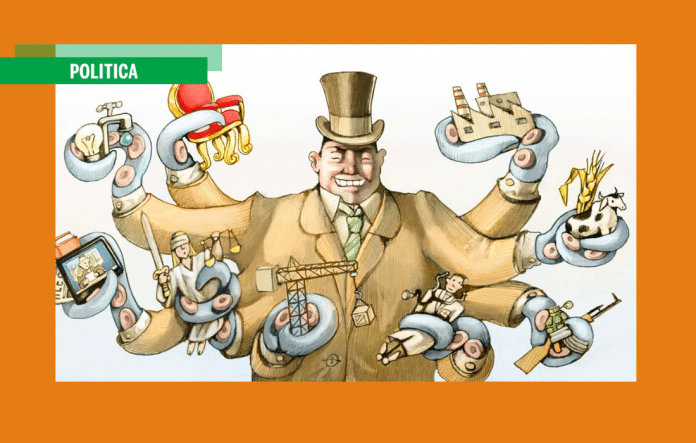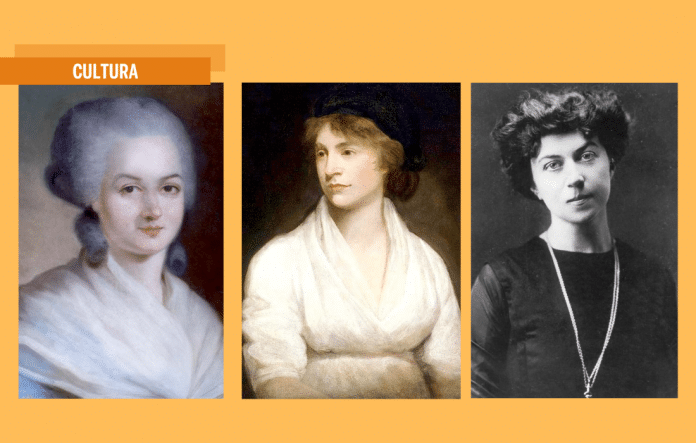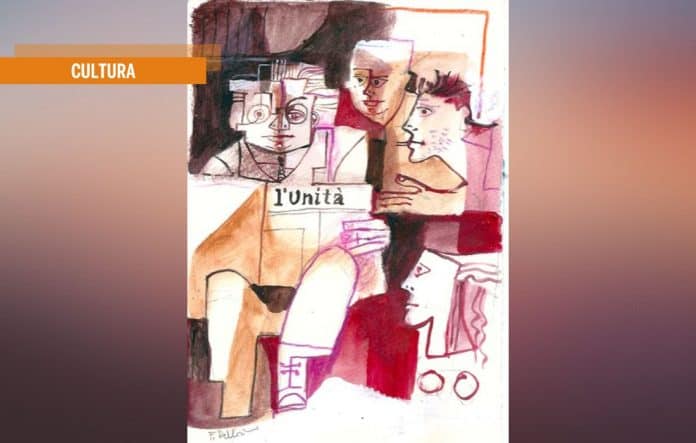Se guardiamo indietro nel tempo, la condizione femminile attuale non è essenzialmente cambiata. Per tutto il secolo scorso le donne hanno avuto scarsissimo accesso all’istruzione di base e all’istruzione superiore. Solo negli ultimi decenni, per la prima volta nella storia, e non solo nei Paesi sviluppati, secondo i dati dell’Unesco, l’educazione secondaria e terziaria delle donne eguaglia e supera spesso il livello di educazione maschile. È una rivoluzione silenziosa, che cambia logiche e costumi consolidati. È una discontinuità con il passato, un cambio di paradigma, un mutamento rapido e irreversibile che, consolidandosi, potrebbe portare ad una radicale trasformazione culturale e sociale. Questo cambiamento potrebbe modificare non solo la struttura delle società che fino ad ora hanno affidato agli uomini e alle donne ruoli culturalmente prestabiliti da millenni, ma il senso dei rapporti fra gli esseri umani.
Tutta la nostra cultura, infatti, discende da un’eredità che risente fortemente del controllo maschile. Per questo motivo, per sbarazzarsi del pensiero che è stato a lungo dominante, bisogna ricostruire storicamente i passaggi da cui deriva la nostra formazione sociale e intellettuale che si origina dalla cultura greco-romana. Il fine è abbattere un modello che per troppi secoli è rimasto invariato: la donna passiva e subalterna, il cui ruolo principale è quello di essere madre oppure oggetto di piacere. Platone era ambivalente e ambiguo nei riguardi delle donne: nel V libro della Repubblica considera la donna pari all’uomo per le potenzialità intellettive, nell’opera le Leggi la considera un essere inferiore adatta a generare figli e condannata ad essere subalterna al marito.
Per Aristotele «il maschio rispetto alla femmina è tale che per natura l’uno è migliore, l’altra peggiore, e l’uno comanda, l’altra è comandata», «l’uomo è un essere umano completo, la donna è un essere umano imperfetto». Anche nella procreazione è «l’uomo a imprimere la forma, il movimento, l’anima, mentre la femmina fornisce la materia inerte, paragonabile alla cera, o al legno, che tocca all’artigiano plasmare». La visione di Aristotele ha influenzato per secoli la storia. La riscoperta dei suoi scritti nel Medioevo avrà una grandissima influenza sulla concezione della donna, contribuendo alla ricomparsa di pregiudizi e odio e diventando agli occhi degli uomini medievali una figura demoniaca. Infatti la filosofia greca adottata nel Cristianesimo fu quella che riteneva le donne inferiori agli uomini secondo natura. La cultura greca aveva relegato la donna all’interno del matrimonio al solo ruolo di procreatrice di figli legittimi: dopo le cure dei primi anni di vita da parte delle madri essi venivano affidati per l’educazione ai padri e agli amanti adulti.
Questo era il destino dei figli maschi, mentre le femmine non ricevevano alcuna educazione e non avevano alcun diritto di ereditare il patrimonio paterno, ma di ricevere una dote se spose: matrimoni combinati già in tenera età. I mariti potevano avere all’interno della casa concubine e figli illegittimi e un giovane amante, l’adulterio della moglie veniva punito con la vita. Le donne greche non solo erano prive di alcun diritto in famiglia e nella società, ma attraverso la paideia veniva cancellata l’identità femminile e la possibilità che potesse emergere negli adolescenti il rapporto uomo-donna. La pederastia era d’obbligo sia a Sparta che ad Atene. I greci temevano la realtà psichica delle donne e di conseguenza la loro sessualità: per loro era «l’inconoscibile».
La cultura romana fu influenzata da quella greca, ma fin dal suo nascere si era confrontata con quella etrusca le cui donne erano più libere. La società romana era sostanzialmente centrata sulla figura maschile «il pater familias» al quale erano garantiti sia i diritti civili che politici. In età arcaica e repubblicana il posto riservato alle donne era quello della domus cioè delle mansioni domestiche e dell’educazione dei figli alla «mos maiorum» cioè la morale romana. Un ruolo che alle donne greche non veniva neanche riconosciuto in quanto i figli le venivano tolti dopo la prima infanzia e affidati ad educatori. Nel primo e secondo secolo a.C., in epoca imperiale, alle donne romane di ceto elevato era consentita l’istruzione e ereditavano il patrimonio al pari dei maschi. Nonostante ciò non potevano rivestire ruoli pubblici e qualunque atto giuridico dovessero intraprendere, era necessaria la tutela maschile. Le figure femminili a noi note sono ricordate con la denominazione della gens di origine e non con il prenome.
Le interpretazioni sono molteplici, ma probabilmente quella più realistica è che esse pubblicamente assumevano la sola identità della famiglia e non ne avevano alcuna individuale. I romani consideravano le donne non adatte a rivestire ruoli decisionali e di responsabilità. L’emancipazione ottenuta in epoca imperiale era il prezzo di compromessi che non alteravano il predominio maschile che si basava su un’etica costruita sulla razionalità, che prendeva origine dalla filosofia greca e si proponeva come legge universale. Le donne accettavano e si identificavano con quella cultura del dominio e della sopraffazione e nell’epoca imperiale alcune donne di potere si comportarono con la stessa violenza degli uomini.
I Padri della Chiesa prima e successivamente la Scolastica considerarono il cristianesimo una conseguenza naturale della filosofia greca. I tentativi maldestri di ribellione delle donne romane in epoca imperiale furono completamente debellati poi dalla funesta alleanza tra fede e ragione che continuò l’annullamento delle donne, che molte volte arrivava fino all’annientamento fisico. È doveroso a questo punto chiederci quale sia la causa di tanta violenza pluri-millenaria che si è perpetuata fino ai giorni nostri e che viene liquidata dalla cultura attuale come un evento ineluttabile, al quale non si riesce a porre rimedio. Le donne oggi hanno conquistato un livello di istruzione pari agli uomini e ottengono risultati importanti sia nella ricerca scientifica che nelle arti, anche se i risultati vengono loro riconosciuti con difficoltà a livello di ruoli istituzionali.
Le donne non devono ripetere gli errori del passato e accettare per sopravvivere compromessi e identificazioni con una cultura violenta che per millenni ha negato e annullato la loro identità. Ma non è nella vita pubblica che si esplica la massima violenza, ma nel privato, nel rapporto uomo-donna. Per la cultura greca le donne appartenevano ad una categoria a parte «inconoscibile», e per secoli è stata temuta e annullata la loro realtà umana. La ragione astratta non ha immaginazione, non comprende la realtà dell’uguaglianza dell’uomo e della donna e la possibilità di un rapporto reale. Se non si riconosce nell’essere umano una realtà psichica e in particolar modo non si accetta la realtà della donna questo rapporto sarà sempre violento. Chi appartiene al genere femminile in virtù della diversità della propria realtà psichica rappresenta per il pensiero razionale il pericolo di perdere il dominio violento dell’uomo sull’uomo. Annullare per millenni la donna ha significato precludersi la ricerca sulla dimensione psichica umana e il raggiungimento di quella conoscenza che rende il rapporto stesso trasformativo e creativo.
Il controllo e il cambiamento della realtà materiale operato dalla ragione e dalla coscienza può avvenire senza che emerga nessun contenuto nuovo nell’ambito delle relazioni sociali in genere e in quello del rapporto uomo donna in particolare. Il progresso tecnologico può avvenire, come vediamo nella storia attuale, senza che ad esso corrisponda un rispetto dei fondamentali diritti umani. Non sono peraltro sufficienti istruzione, lavoro, e indipendenza economica: essi fanno parte di un processo di emancipazione della donna mentre l’obiettivo è raggiungere la liberazione di tutte le sue potenzialità oltre gli stereotipi culturali della mentalità maschile.
È necessario il coraggio di pensare e immaginare un modo nuovo di vivere il rapporto uomo donna che sia il punto di partenza di una trasformazione delle istituzioni e della società. La sinistra deve occuparsi della realtà psichica e di ciò che è trasformativo e creativo. Non si possono accettare compromessi con una cultura basata sulla violenza e la sopraffazione e sull’annullamento del diverso. La sinistra sarà effettivamente tale se proporrà una politica improntata ad un cambiamento radicale che liberi le donne da un’oppressione millenaria e sia in grado di far emergere un nuovo modo di pensare e di vivere le relazioni personali.
L’autrice: Maria Gabriella Gatti è psicoterapeuta e docente della scuola Bios Psychè