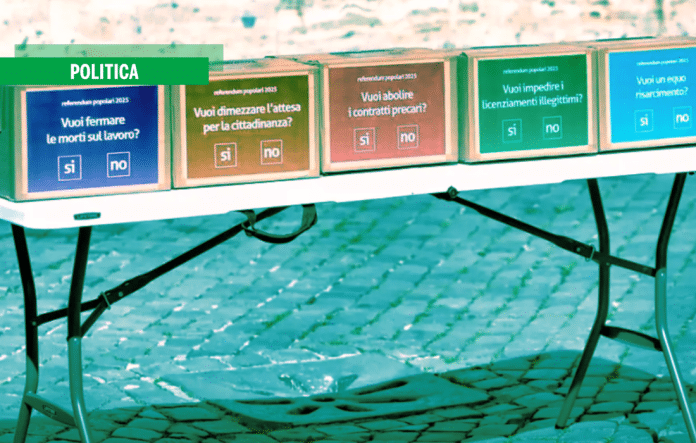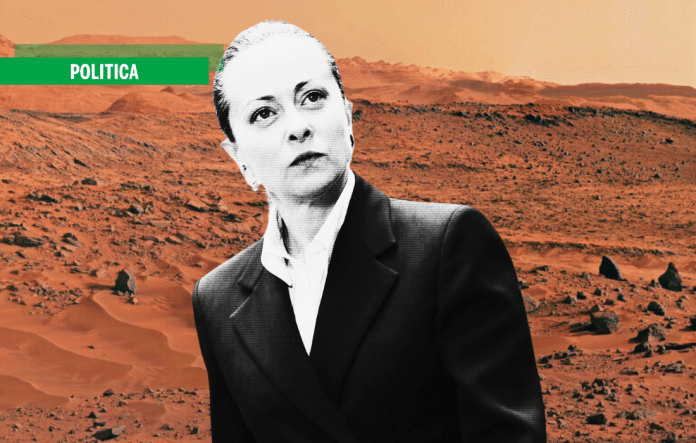Ilaria Pilar Patassini è una cantautrice ed interprete che si è mossa in maniera eclettica muovendosi in un terreno nel quale influenze diverse, provenienti dalla musica folk, dal Mediterraneo e anche dal Brasile e dal sud America, si fondono con un approccio assai libero molto vicino al Jazz ed alla musica improvvisata in generale, come brillantemente dimostrato nelle sue collaborazioni con partner eccellenti come Peppe Servillo, Fabrizio Bosso e Daniele Di Bonaventura.
Canto Conte è il suo nuovo lavoro da poco pubblicato su cd (Parco della Musica Records-2025) nel quale si cimenta questa volta come interprete affrontando il repertorio del grande Paolo Conte, affiancata da un ensemble assai particolare, caratterizzato dal suono avvolgente della Medit Orchestra, un’orchestra d’archi di ben quindici elementi arrangiata e diretta dal Maestro Angelo Valori, nonché dalla presenza di solisti quali Manuel Trabucco al clarinetto e sassofono, Danilo Di Paolonicola alla fisarmonica e, come ospite speciale, Alessandro d’Alessandro all’organetto.
L’album si snoda lungo ben diciotto tracce in cui trovano posto sia grandi classici come Alle prese con una verde milonga, Gli impermeabili, la immancabile Via con me, ma anche pezzi meno frequentati come Reveries, Elisir, Spassiunatamente.
Pilar ci presenta una chiave di lettura totalmente inedita, un nuovo punto di vista al femminile del mondo poetico di Paolo Conte, nel quale la spiazzante ironia, sottolineata dalla voce dell’autore, invariabilmente roca e scavata dal fumo, ha da sempre disegnato un universo un po’ demodé, quasi felliniano, che nell’immaginario collettivo rimane ancorato all’idea di un vissuto profondamente maschile.
Ilaria invece, senza dimenticare la sensualità elegante che pervade la poetica del Maestro, con la sua voce va a mettere a nudo il lato più lirico e malinconico delle sue composizioni, andando a recuperare quelle canzoni, non troppo famose, in cui i sentimenti più intimi vengono scoperti con delicatezza, ma senza infingimenti o autoindulgenze. Una voce luminosa, ricca di sfumature, capace di sottolineare i significati più reconditi delle liriche del Maestro. Ecco allora brani di disarmante bellezza come “Un vecchio errore”, “Dal loggione” o la stessa “Una giornata al mare”, nei quali bruciano, come sale sulle ferite, la tristezza e il rimpianto “di tutta una vita passata a guardare”. L’abbiamo incontrata.
Sei anche musicista ed autrice di canzoni, ma in questa occasione hai voluto recuperare il tuo ruolo di interprete, come mai questa scelta?
Il mio percorso artistico è assai articolato, in realtà io nasco come interprete sia di canzoni d’autore che di standard di Jazz, successivamente lo studio in conservatorio mi ha permesso di approfondire il melodramma, la musica antica e la musica da camera, arricchendo il mio bagaglio di conoscenze. Da sempre canto e scrivo versi, e a partire dal mio secondo disco – Sartoria Italiana Fuori Catalogo – grazie alla fiducia dei miei produttori ho cominciato a scrivere dapprima i testi delle canzoni, acquistando nel tempo consapevolezza e fiducia nei miei mezzi anche nella composizione musicale. Il terzo album – “L’Amore è dove vivo” – conteneva già tre miei brani originali, mentre i successivi lavori – “Luna in Ariete” e “Terra Senza Terra” sono totalmente cantautorali e contengono tutti miei brani originali. In realtà la mia ispirazione parte sempre dalla voce, per me viene sempre prima la voce e poi la scrittura.
Come mai proprio Paolo Conte?
Si tratta di un progetto che, titolo compreso, avevo in testa da anni, e che nasce dal mio grande amore per Paolo Conte, questo amore, insieme ad una buona dose di incoscienza, mi ha portato ad affrontare, non senza difficoltà e con molti ripensamenti, una scelta di ben diciotto canzoni, un’autentica sfida in cui si cimenta la mia cifra interpretativa.
Nella scelta dei brani hai seguito qualche criterio particolare o ti sei semplicemente affidata alla tua sensibilità emotiva?
L’insieme di questi brani vuole creare un’immagine complessiva che in qualche modo mi somiglia, anche se l’approccio alle singole canzoni non è sempre lo stesso, di alcune sono totalmente innamorata e mi immergo in esse anima e corpo, mentre altre, magari le più note al grande pubblico, come “Via con me”, le “vesto” su misura con la mia voce.
L’album se vogliamo contiene una panoramica generale di tutta la produzione contiana nell’arco di quasi mezzo secolo, che va da “Azzurro” del 1968 fino a “Snob” del 2014. Inoltre, c’è anche un aspetto quasi divulgativo nel voler proporre, assieme a brani famosi, canzoni meno conosciute ma non per questo meno belle.
Entrare nella poesia di Paolo Conte è come aprire le porte di un mondo intero, qual è stata la tua personale chiave di lettura ?
Prendo spunto dalla mia “lettera aperta” indirizzata al “Gentile Maestro” che ho voluto inserire nelle note di copertina, nella quale mi ponevo il problema dell’interpretazione dell’universo contiano, apparentemente tutto maschile, visto da un punto di vista femminile. Se andiamo ad analizzare Paolo Conte, come pochi altri grandissimi cantautori, è capace di condensare la scenografia di un intero film in una canzone di tre minuti, ed in questo modo, come un regista, spesso racconta la storia come ripresa da un osservatore esterno. Ed è proprio questa la chiave di lettura che ho voluto adottare e, come ho scritto nelle note di copertine, “dei brani che ho scelto ho voluto farmi soggetto e oggetto”, mantenendo assolutamente inalterati i testi originali, lungi da qualsiasi tentazione di adattamento “al femminile”.
La tua presenza scenica e la naturalezza con cui ti muovi sul palco suggeriscono una componente teatrale nella tua interpretazione?
Devo ammettere che, se non avessi fatto la cantante avrei voluto fare l’attrice, e, anche se in realtà non ho mai recitato veramente, è tuttora un sogno che mi è rimasto nel cassetto, e, nelle mie intenzioni è un’inclinazione certamente nelle mie corde, per cui…mai dire mai!
Dal punto di vista musicale, l’impatto complessivo è caratterizzato dalla presenza di una grande orchestra d’archi.
Tutto risale ad un concerto tenutosi a Pescara alla fine del 2023 con il Maestro Angelo Valori, che mi mise al corrente dei suoi progetti con la Medit Orchestra, una formazione di soli strumenti ad arco da lui diretta. Il mio manager Roberto Catucci prese la palla al balzo e suggerì l’idea di realizzare “Canto Conte” con il supporto dell’’orchestra. Partì così questa bella e ambiziosa avventura.Nell’affrontare questa sfida mi è stata molto utile la mia formazione di conservatorio nell’ambito della musica operistica e da camera che in realtà non ho mai abbandonato. Le canzoni di Paolo Conte somigliano spesso a dei recitativi in cui la parola sembra prendere il sopravvento sulla frase musicale, salvo poi aprirsi ad arie melodiche fortemente melodrammatiche. Come, ad esempio, accade in “Reveries” che si svolge in un’atmosfera sospesa nella quale il tempo sembra essersi fermato.
Avete fatto delle scelte particolari per portare a buon fine la realizzazione di un lavoro così complesso?
Il progetto si è sviluppato tenendo sempre presente la struttura e l’impostazione armonica originale dei singoli brani, con un grandissimo lavoro da parte di Angelo Valori, che ha curato tutti gli arrangiamenti e la direzione dell’orchestra, le sue capacità professionali e la sua esperienza sono state poi determinanti nella successiva fase di registrazione in studio. Proseguendo con il lavoro abbiamo condiviso insieme alcune scelte decisive: mantenendo il minimo indispensabile di strumenti squisitamente “contiani” come il clarinetto e la fisarmonica, abbiamo sostanzialmente lavorato “per sottrazione” eliminando totalmente la sezione ritmica e tutti gli altri strumenti armonici, in modo da dare il massimo risalto alla voce ed al respiro dell’orchestra d’archi. L’anteprima si è svolta con una sorta di “data zero” il 12 dicembre scorso a Pescara, grazie alla collaborazione di Musica Per Roma e del Centro Adriatico di Produzione Musica che hanno co-prodotto il progetto. È seguito poi un intensissimo lavoro di registrazione del disco, svoltosi tra gennaio e febbraio – prima allo studio Spheres di Pescara e poi alla Casa del Jazz a Roma – fino ad arrivare alla presentazione ufficiale del 28 marzo scorso all’Auditorium Parco della Musica in concomitanza alla pubblicazione del disco.
Sarà difficile poter andare in tour con un ensemble di ben diciotto elementi?
Le difficoltà ci saranno sicuramente, ma, preso atto che per chi fa musica dal vivo le difficoltà ci sono sempre, di fronte alla realizzazione di un sogno inseguito da oltre dieci anni, tenuto conto della qualità delle canzoni proposte ed avendo la consapevolezza di aver lavorato sodo e con il massimo impegno, sono convinta che il lavoro e la qualità alla fine pagano sempre. Inoltre, ci sarà la possibilità di presentare la formazione al completo tramite accordi con orchestre stanziali presso i vari teatri stabili. In alternativa il progetto potrà essere proposto con un più agile ensemble accompagnato da un quintetto d’archi, ovvero con una formazione con solo voce, pianoforte e organetto, come già sperimentato nel brano “Come mi vuoi”.
In Tour: Il 7 giugno a Milano, per Rai Radio 3, Piazza Verdi: Canto Conte – Live e Intervista. Il 10 giugno a Lugano per RSI – Radio Svizzera Italiana: Canto Conte – Live e Intervista.
l’autore: Roberto Biasco è critico musicale