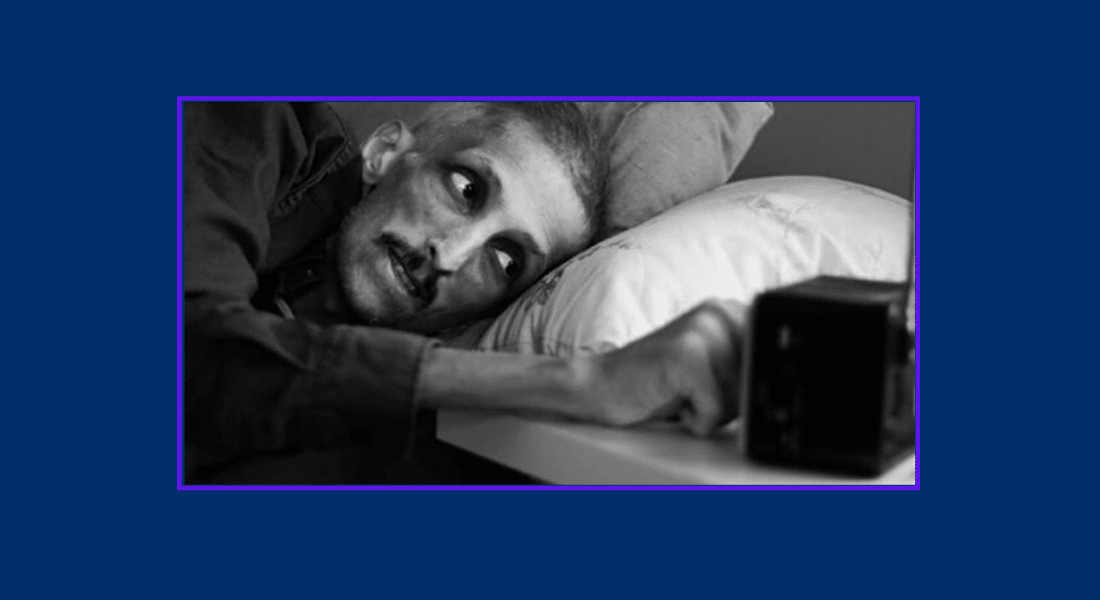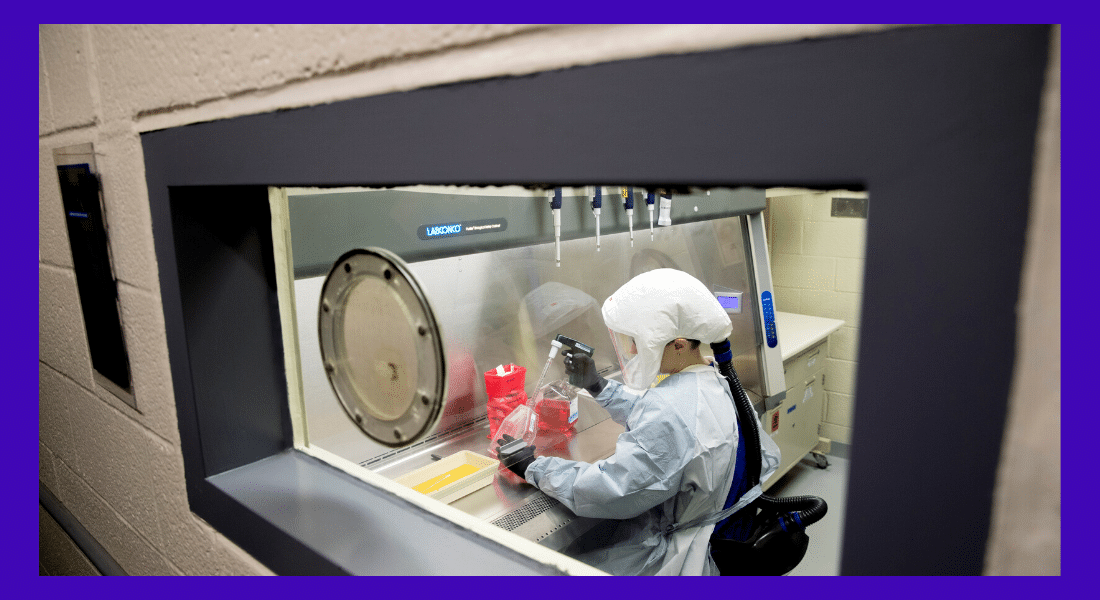È tutta nostra la città. È tempo di tornare dall’io al noi, è venuto finalmente il momento di riprendersi la polis, di esercitare la democrazia, in tutte le sue forme, avendo bene a mente che non siamo ancora fuori dalla pandemia e che dobbiamo muoverci nel massimo rispetto delle misure di sicurezza.
Fare della città un teatro vivo di democrazia, tornare ad essere anche concretamente una collettività è un’esigenza irrinunciabile come dice lo storico dell’arte, archeologo e accademico dei Lincei Salvatore Settis in questo sfoglio, perché è nel sociale, è nel rapporto con gli altri, che si realizza il pieno sviluppo della persona umana, come recita il bellissimo articolo 3 della nostra Costituzione. Dopo un periodo protetto, necessario per fermare il contagio, ora si tratta di affrontare una fase nuova di “svezzamento”: con fiducia torniamo a muoverci all’esterno e con grande senso di responsabilità. Tenendo gli occhi ben aperti perché i diritti di chi è tornato al lavoro siano tutelati in sicurezza. Perché siano rispettati i protocolli, i contratti collettivi, perché la riapertura non avvenga in deroga del codice degli appalti e delle garanzie costituzionali.
Se il 25 aprile – la festa più bella di tutte perché ricorda la liberazione partigiana dal nazifascismo – ci passavamo papaveri di terrazzo in terrazzo, come abbiamo raccontato con una fresca luminosa copertina di Left, ora ripensando al primo maggio ci torna in mente la bella immagine di una ragazza che impugna un garofano rosso con un guanto, manifestando in piazza ad Atene, insieme a tanti compagni, distanti ma idealmente vicini. Un’immagine potente quella che ci è arrivata dalla Grecia, tanto più pensando a come fu strangolata dalla Troika durante una crisi economica non troppo diversa da quella che purtroppo si prospetta ora. Non ci saranno le stesse condizionalità del Mes promette il ministro Gualteri; ormai lasciati alle spalle gli Eurobond, il presidente del Consiglio Conte insiste sul Recovery fund, di cui ancora non sono chiari i contorni. Ma è certo che su questa strada bisogna insistere, perché senza un’Europa solidale nessuno ne esce vivo.
Certo ci saremmo aspettati che la Unione europea, sulla via aperta da Danimarca, Polonia e Francia, vietasse aiuti alle aziende con sede in paradisi fiscali (come accade per la Fca, per le aziende di Berlusconi ecc.) ma così non è stato. Non smettiamo tuttavia di lottare per un’Europa dal volto più umano, non ci arrendiamo. Così come non smettiamo di vigilare sull’operato del governo.
È stata decisa una ripartenza più sulla base di motivazioni economiche che sulla base di evidenze scientifiche. Aspettiamo che i dati sull’andamento della pandemia affluiscano dalle Regioni, che siano diffusi più ampiamente alla cittadinanza che chiede una comunicazione chiara, trasparente, coerente. Mentre continuiamo a documentare e monitorare quel che avviene sui territori (a cominciare dall’area più colpita della Lombardia), in copertina torniamo ad occuparci di un tema a noi molto caro: la città come organismo vivente, come pubblica agorà. Un tema a cui abbiamo dedicato qualche mese fa un agile libro che ha ricevuto molta attenzione da parte dei lettori e splendide presentazioni, che – per chi volesse – si possono rivedere sulla nostra pagina Facebook. Frutto di anni di lavoro di Left il libro Le mani sulle città documenta la crescita delle disuguaglianze, l’esclusione di intere fasce sociali dai centri storici, anche attraverso l’istituzione di zone rosse – quando non ce n’era alcun bisogno – e un perverso armamentario di architettura ostile.
Abbiamo denunciato questa deriva in nome del diritto di tutte le persone all’abitare e ad avere accesso al patrimonio d’arte. Con la pandemia purtroppo le disuguaglianze sono aumentate, come documentano gli economisti Salvatore Monni e Paolo Brunori insieme a un gruppo di studiosi dell’Irpet. Con tutta evidenza, una cosa è stato vivere il lockdown in 70 metri quadri ai Parioli, ben altra è stata farlo in quattro persone chiuse dentro 30 metri quadri in periferia non avendo nessuna altra casa dove riparare. Le mappe di Roma di Monni lo mostrano in modo inconfutabile.
Ripensare la città in modo più umano e sostenibile è la grande sfida che oggi hanno davanti architetti, urbanisti e politici. La dura lezione che ci ha inferto la pandemia ci obbliga a scelte non più rinviabili. Tutti ci siamo meravigliati dei cigni nei navigli, dei delfini nei porti, di spicchi di natura che hanno ripreso vita nei centri urbani. Perché non trarne una lezione duratura, provando a ripensare le città abbattendo le barriere architettoniche, disegnando più piste ciclabili, per evitare di tornare ad affollare i mezzi pubblici e ad intasare le strade con i mezzi privati? Perché approfittando del crudele distanziamento fisico a cui ci obbliga il rischio di contagio non ne approfittiamo per restituire musei, gallerie, palazzi centri storici al piacere della conoscenza e al tempo lento e interiore della fruizione dell’arte? Perché non immaginare maggior spazi verdi e una buona architettura sostenibile, tornando a recuperare e a rigenerare l’antico (quando necessario) e a costruire ex novo, rilanciando la sfida di un progresso a dimensione umana?
In questo momento così duro per tutti sono fondamentali investimenti pubblici a fondo perduto, misure di sostegno come l’estensione del reddito di cittadinanza (ma senza condizionalità), come il varo di un reddito di resistenza, sono utili anche i bonus spesa, ma in prospettiva più che misure assistenziali serve creare nuovi posti di lavoro.
Allora perché non sfruttare questa situazione di crisi per cercare di mettere in atto quella rigenerazione urbana in senso green di cui tanto si è parlato? Perché non investire nel cablaggio di città e paesi per consentire a tutti pari accesso alla rete e alle possibilità di didattica a distanza che, necessariamente, dovremo sviluppare ancora fino a quando non sarà trovato un vaccino efficace per il Covid-19?
Qui c’è in gioco il futuro dell’Italia che non si risolve vagheggiando il ritorno al piccolo mondo antico e agreste, ma puntando sulla modernizzazione della città, sulla qualità e sicurezza degli spazi di vita e di lavoro, sulla ricerca, sulla formazione e su un nuovo modello di sviluppo a dimensione umana. La sfida è aperta.

Leggilo subito online o con la nostra App
SCARICA LA COPIA DIGITALE