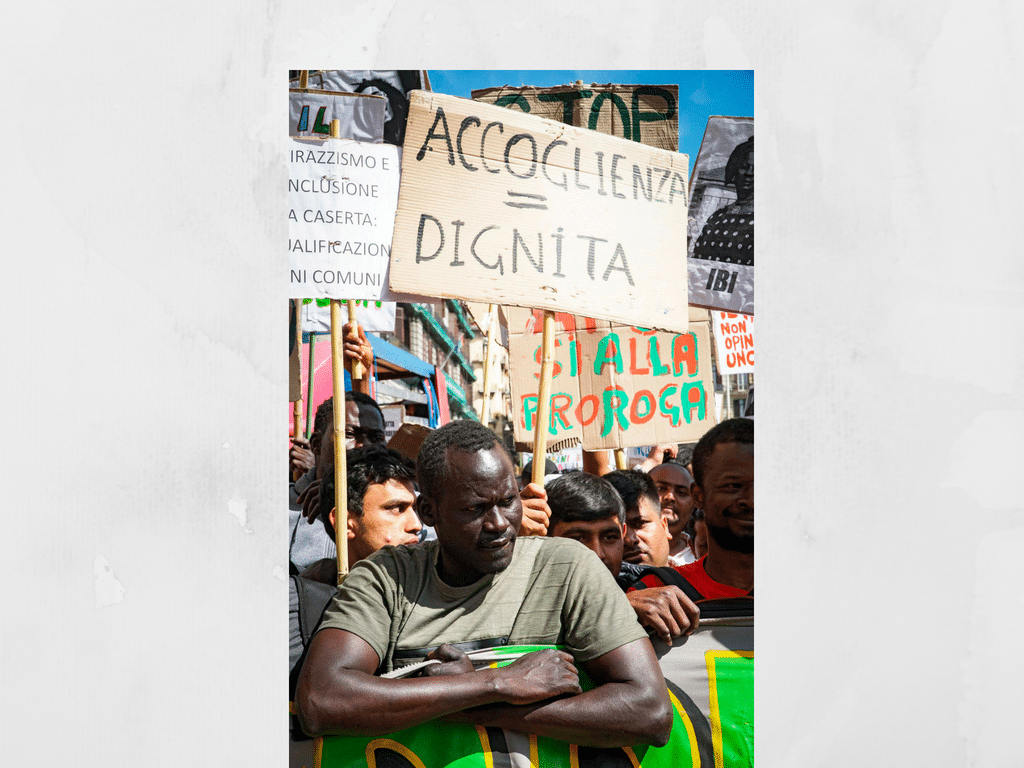«Ci tengo a fare questa diretta perché voglio che si venga a sapere quello che mi sta succedendo…». Appare in divisa su un noto social network , l’appuntato dei carabinieri che, il 15 maggio scorso ha testimoniato al processo Cucchi. Ora il militare denuncia pubblicamente il mobbing nei suoi confronti fornendo uno spaccato inquietante delle condizioni di lavoro nell’Arma. Storie che già sono accadute nei confronti dell’appuntato che volle denunciare l’esistenza di milioni di schedature illegali nelle caserme dei carabinieri (è stato radiato dal corpo), o dell’ispettore della digos che osò scrivere una lettera aperta, sotto forma di lettera a Federico Aldrovandi, durante il processo per l’omicidio di quel diciottenne, a Ferrara, che lui aveva conosciuto da piccolo, aveva accompagnato a scuola e che gli era toccato riconoscere stecchito dalla violenza di quattro suoi colleghi.
«La sto facendo in divisa perché a questa divisa ci tengo – spiega Casamassima nella diretta – me la sono sudata e adesso per aver fatto il mio dovere, come uomo, come carabiniere per aver testimoniato al processo dove un giovane, Stefano Cucchi, è morto perché pestato dai miei colleghi, mi ritrovo a subire un sacco di conseguenze, e sono tutte negative». Alla vigilia di quel 15 maggio, Casamassima era impaurito, scoprirà che «non erano fobie ma si sono concretizzate: mi è stato notificato un trasferimento alla Scuola, sarò allontanato da casa, demansionato dopo vent’anni per strada. Abbiamo subito di tutto, nessun rappresentante di Cobar e Cocer è voluto stare dalla nostra parte e mi hanno detto di stare attento perché dal Comando generale c’erano troppe pressioni.
È giusto che una persona onesta debba subire questo trattamento? Domani alle 8 di mattina cercherò di incontrare il comandane generale, ho presentato diverse istanze che non sono mai state accolte, ho ancora fiducia che possa cambiare qualcosa dopo di che sarò costretto a rivolgermi alla procura, a denunciare ai magistrati perché il processo Cucchi è ancora aperto, ci sono altri carabinieri che devono essere sentiti, ogni azione nei miei confronti va a compromettere l’andamento del processo».
Quel giorno in tribunale, dopo la scoperta di verbali contraffatti per minimizzare le condizioni di Cucchi, Casamassima ha confermato i dubbi di sempre sulle violenze subite da parte di chi lo aveva arrestato e dei depistaggi che si sono innescati nella fase successiva. Al banco dei testimoni, l’appuntato Riccardo Casamassima e sua moglie, Maria Rosati, parigrado nei carabinieri. Ecco perché nel video l’appuntato usa il plurale.
Nell’ottobre 2009, il maresciallo Roberto Mandolini «si è presentato in caserma – disse Casamassima – mi confidò che c’era stato un casino perché un giovane era stato massacrato di botte dai ragazzi, quando si riferì ai ‘ragazzi’, l’idea era che erano stati i militari che avevano proceduto all’arresto». È la conferma del pestaggio del giovane geometra romano, arrestato nell’ottobre 2009 e poi morto una settimana dopo in ospedale, che emerge dalla voce di uno dei teste chiave del processo, oggi davanti alla prima Corte d’assise di Roma. La decisione di raccontare questo episodio arrivò qualche anno dopo la morte di Cucchi, nel 2015, «perché pensavo che Mandolini volesse fare lui stesso qualcosa. Avevo paura di ritorsioni – ha aggiunto Casamassima – dopo la mia testimonianza hanno cominciato a fare pressioni pesanti nei miei confronti. Ho avuto anche problemi perché ho rilasciato interviste non autorizzate; si stava cercando di screditarmi, e io dovevo far capire che tutto quello che dicevano non era vero». «Il figlio del maresciallo Mastronardi, anche lui carabiniere, mettendosi le mani sulla fronte mi raccontò che nella notte dell’arresto vide personalmente Cucchi e lo vide ridotto male a causa del pestaggio subito. Disse che lui non aveva mai visto una persona combinata così». Casamassima ha detto anche che «il nome di Stefano Cucchi come del massacrato di botte fu percepito dalla mia compagna, Maria Rosati, che era dentro quell’ufficio e aggiunse che stavano cercando di scaricare la responsabilità sulla polizia penitenziaria».
«Mandolini – ha detto poi Rosati – disse che era successa una cosa brutta, un casino con un ragazzo che si chiama Cucchi, lo avevano massacrato», che stavano cercando «di scaricarlo, ma non se lo voleva prendere nessuno». La decisione di raccontare questo episodio qualche anno dopo – nel 2015 – ha accumunato entrambi i testimoni: entrambi pensavano che spettasse al maresciallo Mandolini relazionare sulla vicenda, e comunque avevano paura di ritorsioni. E quando Casamassima consigliò a Mandolini di andare dal Pm a raccontare quanto sapeva, la risposta fu: «No. Il Pm ce l’ha a morte con me».
E ora Casamassima si appella a tutte le cariche dello Stato. A «Salvini, Di Maio, al presidente del Consiglio» poiché ritiene «inammissibile che in una istituzione come l’Arma dei carabinieri quando denunci qualcosa ti trovi a subire trasferimenti, punizioni e vessazioni». Infine legge «che scrivono su di me i miei superiori nelle note caratteristiche: carabiniere poco esemplare, inadeguato al senso della rendimento appena sufficiente… vi terrò aggiornati».
«Il carabiniere Riccardo Casamassima ha testimoniato – scrive Ilaria Cucchi su fb – così come lo ha ha fatto la carabiniera Maria Rosati, oggi sua compagna e madre dei suoi figli. Furono loro a dare il via a questo processo per l’uccisione di Stefano Cucchi. Sono stati sentiti dopo che alcuni loro colleghi dissero di aver visto mio fratello estremamente sofferente dopo quel feroce pestaggio subito alla caserma della Casilina durante il foto segnalamento. Sono stati sentiti dopo che alcuni loro colleghi avevano ammesso, davanti ai giudici, di essere stati convocati dai superiori, dopo la morte di mio fratello, per modificare le loro annotazioni. Casamassima oggi è stato trasferito alla scuola allievi con demansionamento umiliante e consistente decurtazione dello stipendio. L’ho sentito in lacrime, disperato. Cari Generali Nistri e Mariuccia, era proprio necessario tutto questo, dopo quanto è emerso durante il processo sino ad ora? La scuola allievi Carabinieri aveva proprio bisogno, oggi, di Riccardo Casamassima? Proprio oggi?».
«Alla prossima udienza dell’11 luglio dovranno sfilare di fronte ai Giudici tanti colleghi del povero Casamassima – spiega -. Saranno ben consci di quel che gli è successo oggi. D’altronde la Scuola allievi aveva bisogno improcrastinabile di lui. Da più parti, dopo quanto sta emergendo al processo, ci viene raccomandata cautela e prudenza. Ci viene letteralmente detto di stare attenti. Lei, generale Nistri, ci ha detto che ‘tutti hanno scheletri nell’armadio’. Noi non li abbiamo, a meno che qualcuno non ce li metta. Ma questa è fantascienza».
«Massima solidarietà al carabiniere che ha fatto il suo dovere raccontando al magistrato quel che sapeva sulla morte di Stefano Cucchi – commenta Maurizio Acerbo, segretario di Rifondazione -. È stato declassato e trasferito mentre meriterebbe una medaglia. Non è tollerabile che in una Repubblica democratica si ostacoli la ricerca della verità da parte dell’Arma dei Carabinieri. Non è accettabile che colpendo Casamassima si lanci un segnale omertoso e intimidatorio a tutti gli uomini in divisa: non denunciate abusi. Si tratta di una mentalità mafiosa incompatibile con la nostra Costituzione democratica. Il presidente della Repubblica e il governo hanno il dovere intervenire. Non confido nel ministro degli Interni che, per raccattare voti dei settori più corporativi delle forze dell’ordine, ha più volte sostenuto il loro diritto all’impunità. Non lasciamo solo Riccardo Casamassima. I responsabili del mobbing nei confronti di Casamassima vanno rimossi, i vertici dell’Arma devono immediatamente fare chiarezza. È su questi problemi che le vecchie rappresentanze militari sono sempre state silenziose mentre con sindacati autonomi e indipendenti, come sancito dalla Corte costituzionale, il diritto, lo Stato di diritto, può e deve entrare nelle caserme italiane».