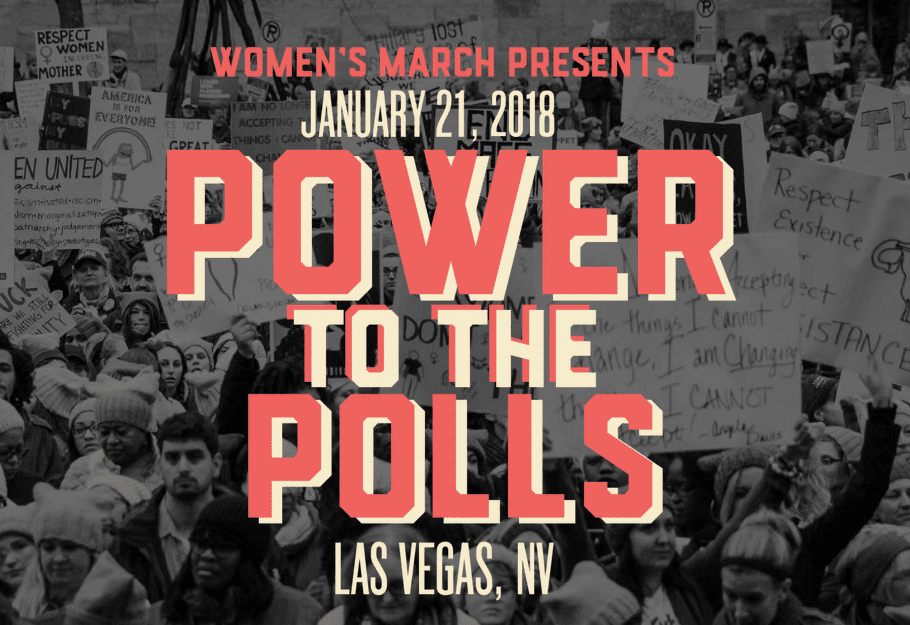La proposta avanzata da Potere al popolo di abolire l’ergastolo e il 41 bis è stata accolta con scandalo. Perché, ci siamo chiesti, dal momento che questo tema percorre buona parte della storia della sinistra del Novecento? Una figura cardine dell’antifascismo come Altiero Spinelli, che aveva subito il carcere di Mussolini, era arrivata persino a parlare di abolizione del carcere.
Certo, è complessa e spinosa la questione del 41 bis (così come rinnovato dopo le stragi mafiose del 1992 con la legge 356) che riguarda gli ergastolani condannati per delitti di mafia. Ma perché questa levata di scudi, prima ancora di cominciare la discussione? A rendere urgente un dibattito pubblico sul tema del carcere è la non rimandabile questione dei diritti umani. L’Italia è stata condannata dalla Cedu anche a questo riguardo. Per le disumane condizioni di sovraffollamento nelle carceri e, nel 2016, per l’ingiusta detenzione di migranti (che non hanno commesso alcun reato!) nei Cie, i Centri di identificazione ed espulsione. Sulle nostre spalle, come cittadini, grava una grande quantità di sentenze della Cedu mai attuate da governi di diverso colore. La civiltà di un Paese si giudica anche dal suo sistema carcerario. E in Italia la situazione è drammatica. Le percentuali parlano chiaro. E raccontano la discriminazione in atto.
Il 37 per cento della popolazione carceraria è composta da stranieri per effetto di una legge razzista come la Bossi-Fini. Chi finisce dentro per piccoli reati in genere è indigente e non può permettersi un buon avvocato. Moltissime sono le persone recluse affette da malattie psichiche e tossicodipendenti. Il 2018 si è aperto tragicamente con un suicidio nel carcere di Uta a Cagliari. Un uomo di 46 anni, algerino, con problemi di dipendenza da droghe si è tolto la vita. Nel 2017 sono stati 52 i suicidi su 123 morti in carcere. Molte associazioni, a cominciare da Antigone, denunciano la mancanza di assistenza sanitaria adeguata e la totale assenza di cure psichiatriche: al più vengono somministrati psicofarmaci, ma senza psicoterapia, al più, servono per tenere sotto controllo i sintomi. La domanda allora ritorna: a cosa serve il carcere? Secondo la legge dovrebbe avere come obiettivo la reintegrazione sociale. Il che implica una presa in carico complessiva della persona, considerando anche la sfera dell’affettività, oltre al lavoro, alla salute ecc. Ma a 18 anni di distanza dal primo tentativo di riforma, ancora oggi il regolamento non considera la vita affettiva dei detenuti. Benché sia un diritto inviolabile della persona.
Allora viene da chiedersi: quale pensiero è sotteso all’attuale sistema carcerario? C’è l’idea di una condanna eterna? Di una pena da espiare che non ha a che fare con la giustizia ma con la vendetta? Abbiamo rivolto questa e altre domande alle forze politiche che si presentano alle elezioni. Ed è emersa la profonda differenza che separa la sinistra “radicale” dal centrosinistra e dalle destre. Se la demagogia violenta e forcaiola delle destre e dei leghisti è nota (Berlusconi è arrivato perfino a dire che «la colpa dei crimini è dei 476mila clandestini africani»), colpisce la traiettoria sempre più conservatrice del centrosinistra: “ordine”, “sicurezza” sono diventate parole care al Pd, ormai da tempo. Lo notavamo, su Left, già una decina di anni fa.
Con il decreto Minniti nel 2017 si è aggiunta la parola “decoro”. E si è fatto di tutto per respingere sempre più ai margini della società migranti, senza tetto e chi è senza mezzi di sussistenza. Arrivando addirittura a realizzare inferriate e panchine per impedire di fermarsi a riposare. Se CasaPound brandisce il fantasma della «sostituzione etnica», la Lega non esita a fare propri temi propri del nazismo come la difesa della razza bianca. Lo fa per voce del suo candidato a governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Un lapsus dice lui. Un lapsus che rivela un pensiero condiviso, rilancia Renato Brunetta di Forza Italia, aggiungendo che «il politically correct», a lui, «fa abbastanza schifo». Anche il Pd, d’altro canto non si fa mancare nulla. Dopo l’onorevole Pristipino che si è lanciata nella difesa del dipartimento mamme «perché gli italiani rischiano l’estinzione», ora tocca a Maurizio Sguanci, che da Firenze in nome del più cieco “fare per il fare” si è lanciato in difesa delle riforme di Mussolini. Affidereste a costoro una riforma carceraria e le chiavi del Paese?