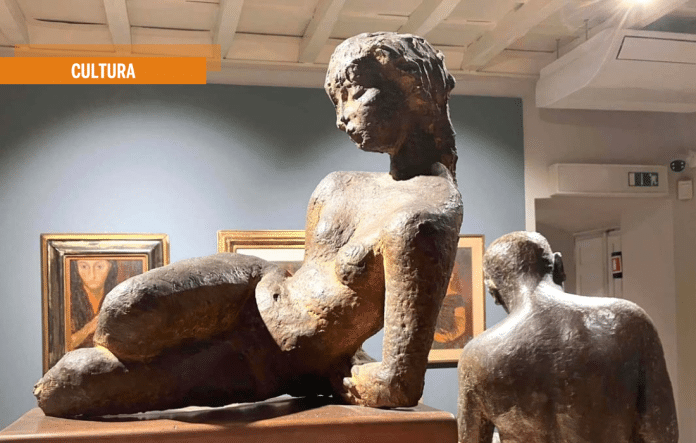Maria Rosa Cutrufelli è scrittrice da sempre particolarmente interessata ad affrontare le tematiche legate alla condizione della donna. Narratrice, critica letteraria, curatrice di antologie di racconti, sceneggiatrice di radiodrammi per la Rai, insegnante di scrittura creativa presso l’Università La Sapienza di Roma, Maria Rosa Cutrufelli nel suo ultimo romanzo Il cuore affamato delle ragazze (Mondadori), ambientato tra New York e Philadelphia agli inizi del secolo scorso, narra la drammatica vicenda dell’incendio che distrusse i locali della fabbrica Triangle e che costò la vita a centocinquanta giovani operaie, molte delle quali emigrate dalle zone più povere dell’Italia. La potente colla che tiene insieme il racconto è però la capacità delle donne – al di là del singolo, tragico episodio – di solidarizzare e di impegnarsi anima e corpo in una forma nuova di lotta, la creazione di un sindacato per la difesa di una categoria sin lì senza tutele e senza diritti. A scandire lo storico periodo, le vicende di Etta, americanizzazione decurtata di Marietta, una giovane figlia di immigrati italiani, il cui padre è un esule politico di solide radici socialiste. Una volta tagliato il cordone ombelicale con la famiglia, la protagonista si getta a capofitto nell’impegno politico, scoprendo il valore dell’amicizia, della solidarietà, della lotta e anche dell’amore per una sua compagna.
Dunque, Maria Rosa, partirei dalla fine, e cioè da una particolarità che riporti nelle note a fine romanzo. Cito: «…Vorrei rispondere a una domanda che mi viene fatta spesso: Perché, nei tuoi libri, scrivi tanto di donne?». Come i tuoi lettori sanno, al centro dei tuoi romanzi – mi limito agli ultimi in ordine di tempo, I bambini della Ginestra, Il giudice delle donne, L’isola delle madri, la bellissima biografia di Maria Giudice – c’è sempre una figura femminile, o un gruppo di donne, a movimentare l’azione narrativa. Da dove e quando nasce questa sorta di tua “missione” letteraria?
A dire il vero non è una “missione”, ma qualcosa, un impulso, che mi viene naturale. Sono una donna… E questo in realtà vuol dire poco, perciò devo specificare: sono una donna attenta al mondo in cui vive. Un mondo