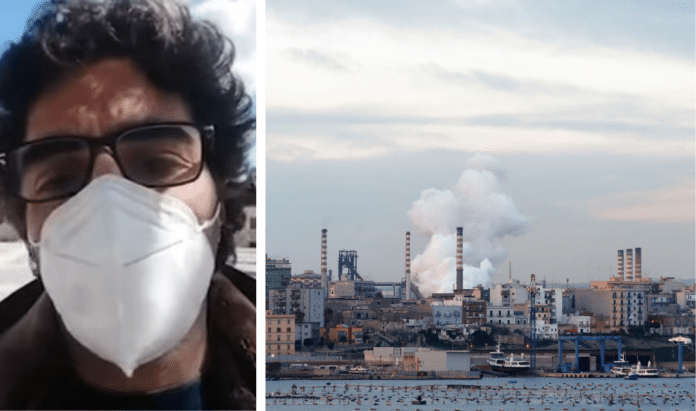«Nonostante la pandemia i conflitti in Africa sono aumentati. Assistiamo a una crescita esponenziale dei fenomeni legati alle formazioni islamiste che si innervano su tutta una serie di situazioni preesistenti e spesso svincolate da un’unica matrice», racconta Francesco Strazzari della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa, docente di Scienze politiche e fra i massimi esperti di conflitti in Africa. «Ne è un esempio il conflitto etiope, che ha colto quasi tutti di sorpresa perché è divampato in un Paese che, almeno nominalmente, registrava dinamiche positive. Il conflitto nel Tigray – approfondisce Strazzari – è innestato su una questione islamica (perché il fronte di liberazione Oromo ambisce a rappresentare la maggioranza della popolazione etiope che è di religione musulmana) ma a ben vedere non c’entra nulla. L’oromia ha una matrice musulmana ma non è connessa al Jihādismo internazionale».
Il nostro sguardo sull’Africa tende ad appiattire la complessità?
C’è un po’ la tendenza a osservare l’Africa come fosse un unico Paese, in realtà sono più di 50 Stati. La popolazione e il prodotto lordo africano sono più o meno equivalenti a quelli dell’India e con dinamiche comparabili. Ma il punto è che stiamo parlando di 55 sistemi economici differenti che si riflettono nelle dinamiche di sviluppo, sugli investimenti in infrastrutture e su tutto ciò che serve per avvicinarsi agli obiettivi del millennio che l’Unione africana stessa ha sottoscritto. Anche, se diversamente dall’Unione europea, l’Unione africana è una organizzazione intergovernativa senza elementi sovranazionali, i fenomeni interessanti su larga scala internazionale si rifanno in larga parte a quella agenda di integrazione economica. I primi pourparler cominciarono del 2015 ma poi i passaggi decisivi si sono avuti nell’ultimo paio di anni e sono stati rallentati dalla pandemia che ha riportato l’Africa in recessione, dopo anni di crescita ininterrotta. Con costi enormi sul piano sociale perché il distanziamento fisico in economie che sono ampiamente informali ha gettato a terra varie fasce della popolazione.
Si è detto che il Covid-19 abbia fatto meno vittime in Africa per la bassa età media. Quali riscontri ha?
Sul coronavirus in Africa andrebbero dette molte cose. I media hanno parlato di un tasso di mortalità relativamente basso ma se per esempio guardiamo alle élite di governo vediamo che il Covid è molto presente e miete vittime eccellenti in diversi Paesi, anche per il fatto che chi governa ha un’età più ragguardevole. Questa idea che in Africa siano auto-vaccinati o che abbiamo sistemi immunitari più forti per via degli antimalarici e dell’idrossiclorochina sono ipotesi molto speculative. La verità è che si tratta di un continente giovanissimo ma anche che non abbiamo dati. Quando in Guinea hanno fatto delle autopsie all’obitorio hanno visto che 4 morti su 5 erano deceduti per Covid. Al momento abbiamo dati molto approssimativi sia per l’epidemiologia e che per l’economia in Africa.
L’inizio del 2021 ha visto il varo del trattato di libero scambio fra Paesi africani, segna un passaggio storico?
È un processo che nasce sul piano economico ma che potrebbe avere una spinta politica. Ma ci sono grandi sfide da affrontare. Purtroppo il continente africano ha subito l’estrattivismo e le esportazioni intra africane equivalgono al 16 per cento dei volumi prodotti. L’Africa è tutt’oggi saccheggiata ed ha flussi economici tutti in uscita, perché i soldi che vengono accumulati finiscono nelle banche europee, svizzere, ecc. Un’integrazione economica permetterebbe di cominciare a ragionare di potenziamento di investimenti intra-africani e a mettere in atto dinamiche positive. Ma ci sono aspetti critici: il primo è che i Paesi più grandi e più forti, a cominciare dalla Nigeria, vedono in una integrazione indifferenziata la perdita della propria capacità di egemonizzare questo mercato e quindi strascicano i piedi.
Una questione annosa…
È un classico nella scienza politica. È il dramma dell’azione collettiva: chi comanda quando ci si mette insieme? Ma c’è anche un altro punto critico: abolire nell’arco di una decina di anni in maniera progressiva i dazi sul 97% delle merci sul commercio intra africano significa privare gli Stati della gran parte delle loro entrate perché in Africa c’è un problema fiscale enorme che riguarda l’imposizione diretta. È difficile che in Paesi con una forte economia informale e uno spiccato problema di povertà il cittadino paghi le imposte sul reddito. La capacità fiscale dello Stato è molto bassa. Abolire i confini significa porre il problema della sostenibilità fiscale degli Stati in Africa e della loro capacità di dotarsi di strutture di ammodernamento. Non è facile far passare il principio che tutti debbono pagare le tasse sulla base impositiva proporzionale, invece che sussidiare l’economia con dei prezzi dopati e condonare gran parte dell’evasione fiscale. Introdurre dei meccanismi redistribuivi in Africa significa introdurre dei meccanismi fiscali e dare capacità allo Stato, significa produrre beni pubblici.
Come si esce da questo circolo vizioso?
Come se ne esca da questo paradosso è una sfida aperta. La domanda è: l’Africa può entrare nell’economia digitalizzata senza essere mai passata attraverso la rivoluzione industriale? Si possono saltare le tappe? Si può fare il delivery delle merci con i droni senza costruire le strade? Sì, ma fino a un certo punto. Perché si potrebbe arrivare al paradosso, per metafora, che tutti possiedono un cellulare ma nessuno ha la presa in casa per ricaricarlo. In sintesi: in Africa c’è un grande problema di elettricità e di acqua potabile. In particolare nella zona centrale larghe parti della popolazione sono off grid. La grande scommessa su scala continentale è portare elettricità, acqua potabile e infrastrutture. E quindi sviluppare la capacità fiscale dello Stato. Da questo punto di vista l’introduzione di una zona di libero scambio promette bene e al contempo rappresenta una grande sfida.
Come è andata fin qui nella parziale zona di libero scambio in atto nel West Africa?
Dove esiste già una zona di parziale libero scambio negli anni ci sono state enormi querelle doganali (se il riso potesse passare dal Togo, dal Niger, dalla zona anglofona ecc.) e sulla moneta. In quell’area la moneta tradizionale è il franco coloniale (Cfa)…la dice il lunga il fatto che sia ancora la moneta coloniale. I francesi hanno deciso di facilitare il passaggio a una nuova moneta che si chiama Eco. L’ipotesi sarebbe che l’area di libero scambio potesse avere una moneta unica, ma i ceti possidenti, piccoli ma potenti, frenano perché temono per la loro reveneu nel passaggio a una nuova valuta. È un po’ come il passaggio all’euro per l’Italia che ha creato problemi per fasce della popolazione ma anche all’industria che non riusciva più a esportare come prima. Insomma ci sono delle incognite anche dal punto di vista della valuta.

L’articolo prosegue su Left del 9-15 aprile 2021
Leggilo subito online o con la nostra App
SCARICA LA COPIA DIGITALE
SOMMARIO