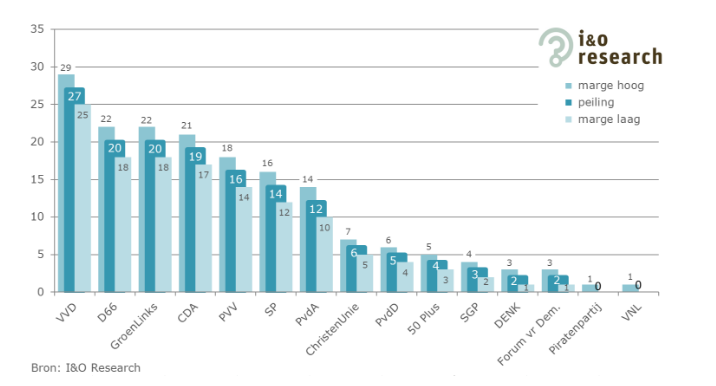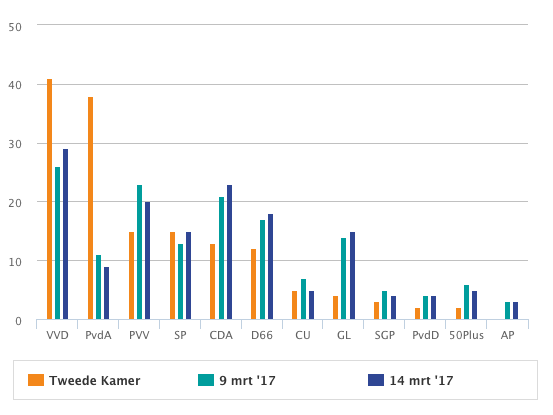Amsterdam – Geert Wilders ama paragonare l’Islam al nazionalsocialismo, le moschee ai «templi del nazismo» e il Corano al Mein Kampf di Adolf Hitler. Lo ha fatto durante un’intervista televisiva per poi definire, durante un comizio nei pressi di Rotterdam, parte della giovani olandesi di origine marocchina come una “feccia” con cui si dovrà, prima o poi, fare i conti. È grazie a questi toni sopra le righe che il suo Partito per la libertà (“Partij voor de Vrijheid”, Pvv) è giunto in testa ai sondaggi. Domani, 15 marzo, il Pvv potrebbe diventare la prima forza politica del Paese: i sondaggi lo danno intorno al 20%, il suo potrebbe essere il primo partito ma difficilmente troverebbe alleati per governare. A sfidarlo, alle prossime elezioni politiche, c’è un po’ tutto il panorama partitico olandese, a partire dai Liberal-Conservatori (“Volkspartij voor Vrijheid en Democratie”, Vvd) del Primo ministro uscente Mark Rutte.
Il programma di Geert Wilders, condannato a fine 2016 per incitamento alla discriminazione, è tanto conciso e quanto surreale: rimettere in mano agli olandesi il destino del Paese e arrestare «l’invasione islamica». Sebbene molti elementi del suo programma si trovino anche nei manifesti di altri partiti, nessuno ha la “credibilità” del leader del Pvv quando si parla di “fermare l’Islam”. Come corollario – e sulla scia del voto britannico del 2016 – Wilders spinge per una “Nexit” (termine che evoca Brexit coniugando le parole “Netherlands” ed “exit”) e per il blocco totale dell’immigrazione. Il tutto è farcito con una retorica contro le élite, un progetto di welfare spostato a sinistra (stop all’aumento dell’età pensionabile) e l’introduzione nella Costituzione di un istituto referendario vincolante per il governo.
“Chi siamo e dove siamo diretti?”. Non è una soltanto una domanda ontologica, ma anche «l’interrogativo cardine della campagna elettorale» olandese, nell’anno 2017. Lo chiarisce a Left Hans Vollaard, esperto di politica e dei processi di “disintegrazione europea” presso l’Università di Leiden. «Immigrazione, integrazione, norme e valori: sono questi i temi principali del dibattito elettorale, seguiti dalla discussione sui servizi di sanità. E i primi sono interrogativi che hanno a che fare con la globalizzazione e il processo di integrazione europea. Il panorama politico si sta spaccando in due. Da un lato c’è chi vede nella globalizzazione e nel multiculturalismo benefici economici e un “arricchimento culturale”, dall’altro c’è chi vi riconosce una minaccia economica fatta di multinazionali, “migranti che rubano il lavoro”, e un rischio per l’identità del proprio Paese». Secondo Vollaard, si tratta di una spaccatura trasversale e che disintegra il vecchio confronto tra una sinistra aperta al mondo e una destra culturale “conservatrice”. In questo contesto, «i partiti che giocano la carta “immigrazione” e “multiculturalità” in senso positivo si contano sulle dita di una mano: il partito liberale D66, il partito ecologista di sinistra GroenLinks e il partito delle seconde e terze generazioni di migranti, Denk».
Gli altri partiti, invece, strizzano tutti l’occhio alla “ventata xenofoba”. A gennaio, i quotidiani olandesi hanno pubblicato una lettera del Primo ministro democristiano, Mark Rutte, destinata agli elettori e agli immigrati. Il messaggio? “Adattamento o espulsione”. E la sinistra? «Il Partito socialista riconosce ormai nei lavoratori dell’Est un rischio per gli olandesi “doc”, mentre il vice primo ministro socialdemocratico Lodewijk Asscher gioca la carta del cosiddetto “patriottismo progressista”: una riformulazione in chiave “civica” di ciò che, altrimenti, si definirebbe nazionalismo», spiega Vollaard. In altri termini, quella del Pvv rappresenterebbe soltanto una delle varianti – tra le più estreme – in competizione lungo l’asse “immigrazione-identità-valori”. Wilders pone un accento “identitario” e “culturale” straordinario nel dibattito sulla migrazione. «Ma agli occhi dei cittadini cosa cambia?», si chiede il professore, sottolineando che ormai non sembra esserci spazio nemmeno per una distinzione tra rifugiati e migranti Ue. «Per molti elettori le questione culturali ed economiche si riducono a un unico nucleo concettuale, ovvero alla domanda: “Con chi vuoi condividere le tue risorse?”». In un quadro del genere, chi la “spara più grossa”, vince. Eppure «Wilders non ha nemmeno un merito particolare in questo senso», afferma Paul Lucardie, politologo, studioso del populismo in Olanda e autore di Democratic Extremism in Theory and Practice (“Estremismo democratico in teoria e nella pratica”, 2014). Lucardie in passato aveva definito il populismo nei Paesi Bassi come un “correttivo democratico”, ma a Left specifica che «non interpreterebbe Wilders in questo modo», anzi: «Wilders si è affermato seguendo le orme di Pim Fortuyn. Se a quest’ultimo va riconosciuto “il merito” di aver abbattuto dei tabù e di aver ampliato il raggio di azione del dibattito democratico incorporando i temi dell’immigrazione e dell’euroscetticismo, il contributo di Wilders alla democrazia è dannoso». Per il politologo il fatto che Wilders faccia campagna per l’introduzione del referendum non rappresenta un elemento distintivo della sua proposta politica, anzi, «è un obiettivo secondario. La sua priorità è l’Islam. Senza contare che è ambivalente rispetto al valore degli istituti democratici: un giorno elogia le virtù della democrazia rappresentativa, mentre il giorno successivo parla di “pseudo-Parlamento che agisce contro il volere del popolo”».
Ma come si spiega allora il successo di Wilders? Merito del suo carisma? Di una struttura partitica solida? E soprattutto, chi sono i suoi elettori? «Wilders è sveglio e “popolare”, ma non lo definirei “carismatico”: non mobilita chi non si interessa alla politica», afferma Lucardie, prima di sottolineare che «semmai, sono le minacce ricevute nel corso degli anni, a donargli un qualcosa di speciale». Il capo del Pvv usa molto bene l’immagine di leader su cui pende una taglia di al Qaeda (di recente ha anche sospeso la campagna elettorale ufficialmente per ragioni di sicurezza), richiamando alla memoria l’omicidio del 2 novembre 2004, quando un estremista musulmano sparò e accoltellò Theo Van Gogh, autore del corto sull’Islam Submission. Definire il suo un partito solido equivale però a raccontare una barzelletta. «Il Pvv è inesistente», afferma perentorio Lucardie.
«Basti pensare che, formalmente, Wilders rappresenta l’unico iscritto al partito». Non è un modo di dire. Si tratta di «un caso unico, probabilmente a livello mondiale». Gli stessi deputati del gruppo Parlamentare, non sono iscritti al Pvv. Tanto meno i candidati che gli elettori trovano sulla tessera elettorale. «Wilders decide tutto da solo, ma questo è anche il suo limite: non può essere ovunque». Alle ultime elezioni municipali, il Pvv si è presentato soltanto a L’Aia e ad Almere. In questo il Pvv somiglia alla Lista Pym Fortuyn, di cui raccoglie l’eredità.
Secondo Vollaard, un terzo degli elettori olandesi ha posizioni di sinistra per quanto riguarda le questioni di welfare e un’impostazione culturalmente conservatrice. Un profilo che farebbe il paio con l’offerta politica di Wilders. Entrambi gli esperti interpellati da Left ritengono che «Wilders riesca a intercettare diverse classi sociali, ma che il suo elettorato sia caratterizzato in maniera preponderante da un livello di educazione e salario più bassi della media». Secondo Vollaard, si tratta poi di elettori «ricettivi a una comunicazione senza filtri, traducibile in tweet da 140 caratteri, e sensibili al messaggio anti-establishment». Parte dell’elettorato popolare classico di sinistra percepisce poi un peggioramento delle prospettive economiche per i propri figli: «Contano i tagli al welfare e al sistema educativo-universitario degli ultimi anni». Eppure, su questo fronte Wilders dovrebbe in teoria subire la competizione del Partito socialista olandese. E la precarizzazione nel mondo del lavoro? Secondo Lucardie si tratta di un problema che riguarda soprattutto «i giovani con alti livelli di educazione e che difficilmente sono attratti da un messaggio di chiusura come quello del Pvv».
Rimane l’elemento geografico. Alle elezioni del 2012 il Pvv ha ottenuto un punteggio sopra la media nelle zone periferiche di alcune città, come Rotterdam, e più in generale lungo i confini del Paese. «Wilders ottiene consensi nell’Olanda sud-orientale, nella regione di Limburg, perché è originario di Venlo (cittadina nel Sud-Est del Paese, ndr)», sottolinea Lucardie. Ma non soltanto. Tutta l’area periferica del Nord, lungo il confine con la Germania, distribuisce voti al leader populista: «Zone de-industrializzate e impoverite che 200 anni fa erano anarchiche, successivamente caratterizzate dall’egemonia comunista e che ora appoggiano il leader populista». Lucardie legge dunque nell’espressione elettorale di quella regione anche un di voto di protesta. Anche perché qui, a differenza che nelle periferie urbane, di “islamizzazione” non si può certo parlare.
La corsa del partito senza iscritti e del leader di Venlo si potrebbe fermare, dopo il voto, per la mancanza di partiti disponibili ad allearsi con lui, che però fa la voce grossa dichiarando che se vince gli altri non potranno ignorarlo. Per Paul Lucardie «l’eventualità più concreta è quella di una coalizione di 4-5 partiti che escluda Wilders, a prescindere dal risultato del suo partito». Un’alleanza «fragile» certo, ma è una situazione che si era già verificata negli anni 70. L’alternativa sarebbe un governo di minoranza guidato da Wilders, che con un partito praticamente inesistente alle spalle difficilmente sarebbe in grado di gestire la formazione e la vita di un esecutivo. Sia Vollaard sia Lucardie pensano però che l’obiettivo di Wilders sia quello di «ottenere il maggiore consenso popolare possibile, senza doversi assumere alcuna responsabilità». «Non sarebbe perfetto?», chiede Vollaard. «Potrebbe continuare a fare la “vittima dell’establishment” e, allo stesso tempo, avere un’influenza indiscutibile sulle politiche del governo». Influenza che in fondo esercita già, a giudicare da come le altre formazioni politiche sono impegnate a mettere in campo proposte discriminatorie nei confronti di migranti e minoranze dietro il paravento della lotta al terrorismo.